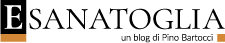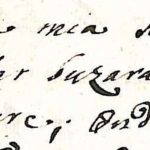Capitolo 2
I Cappuccini
L’Ordine dei Cappuccini offriva al giovane contadino, avvezzo al sacrificio e plasmato dal patimento, un modello di vita speculare a quello che aveva da sempre regolato la sua esistenza.
Un Ordine relativamente giovane, che prima di essere ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa, poco più di un secolo prima, aveva dovuto affrontare un’aspra lotta contro le gerarchie ecclesiastiche, quasi rinnovando le incomprensioni di cui era stato vittima lo stesso Francesco d’Assisi. Sorse e si sviluppò dal tronco dei Frati Minori Osservanti a partire dal 1524 e non a caso nella nostra regione, da sempre fucina di intensi e fervidi movimenti di integralismo francescano.
Proveniva da Bascio (oggi borgo di Pennabilli, nell’entroterra pesarese) uno zelante fraticello la cui figura e la cui opera si distinguevano nel marasma che avviluppava le genti del ducato di Camerino; infieriva il flagello della peste, rinfocolato secondo i cronisti dell’epoca, dall’incursione di un nembo innumerevole di farfalle e cavallette venute dall’ Ascolano.
Fra Matteo da Bascio non si limitava a predicare le penitenze per guarire le anime; si adoperava anche a curare i malati e a seppellire i morti ignorando i rischi personali legati alla sua totale immersione nell’immondezza della peste.
Era la dimostrazione estrema della dedizione verso il prossimo originata dalla sua ansia di ritorno alle origini del francescanesimo; l’esempio fulgido, in condizioni storiche e sociali a ciò favorevoli, attrasse altre anime pure e spiriti ribelli, e nel giro di breve tempo attirò su di sé gli strali dei suoi diretti superiori.
L’eremo di Santa Maria dell’Acquarella sul San Vicino sopra Albacina, e quello di San Giacomo a Braccano, dove viveva appartato nella sua vecchiaia Francesco da Cartoceto, una sorta di santone, un punto di riferimento per la sua integrità morale e per il suo ascetismo: furono questi, luoghi a noi molto familiari e vicini, i primi rifugi semiclandestini del nascente movimento riformatore. Fu invece nel convento di Forano, nei pressi di Appignano, che Fra Matteo, per ordine dei suoi superiori, fu ridotto in una umiliante prigionia.
Superato il carcere, affrontato fughe ed altre peripezie nei primi tre anni, per intercessione di Caterina Cybo duchessa di Camerino e nipote di Papa Clemente VII, il 3 luglio 1528 Fra Matteo e i pochi seguaci che nel frattempo s’erano aggiunti ottennero la Bolla papale ‘Religionis zelus’: era sancita la nascita dei Frati Minori Cappuccini, così chiamati dal cappuccio piramidale cucito sul saio.
Agli inizi furono i ‘frati minori della vita eremitica’, poiché si rifacevano alle esperienze di vita dei romitori o dei conventini della prima ora; ma il popolo, anche per distinguerli dagli altri due tronchi della famiglia francescana, ‘osservanti’ e ‘conventuali’, li volle chiamare, forse anche affettuosamente, ‘li scapuccini’. Un battesimo virtuale ricevuto direttamente dalla gente, che è valso loro la definizione di ‘frati del popolo’.
L’espansione dell’Ordine fu rapida sia in Italia che nel resto d’Europa; ovunque si distinsero principalmente in attività sociali in favore degli infermi ed appestati, con un punto di forza particolare: una predicazione basata su un fervore che attizzava le folle, privo di sottigliezze e tante filosofie perché ispirata ad una testimonianza evangelica diretta e orientata principalmente verso gli umili e i sofferenti.
Dal loro esempio e anche dal loro intervento diretto, in molte realtà locali compresa Sant’Anatoglia, sorsero o ripreso vigore istituti quali il Monte dei Pegni (sorti, in genere, verso la metà del XV secolo proprio per l’impulso della predicazione francescana) o il Monte Frumentario: strumenti fondamentali nella vita cittadina volti a regolare l’organizzazione economica e a contenere la miseria delle genti.
I Cappuccini a Sant’Anatoglia
Gli inizi non furono facili per i Cappuccini; anche nelle terre in cui avevano mosso i primi passi, la stima e il rispetto non furono immediati. Non riuscirono da subito a suscitare l’amore da parte del popolo, pur essendo essi stessi, in gran parte, figli del popolo.
Bernardino da Orciano, cronista dell’epoca, racconta di bastonate e colpi di accetta a Pietrarubbia, di porte sbattute in faccia a Castelbellino, e a Ginestreto “gli uomini e le donne gli facevano la caccia con le sassate, chiamandoli zingari, assassini di strada”. “In molti luoghi – prosegue – quando si vedevano i capuccini, erano da putti accompagnati con sassi, come più volte intervenne a Sant’Anatoglia”.
Ma superate le diffidenze iniziali, grazie anche al loro impegno caritatevole verso i poveri e gli infermi, in particolare nel corso di epidemie e in ogni altra occasione di sofferenza, conquistarono una posizione di rilievo nella vita sociale e nell’orizzonte spirituale che orientava la vita della gente di queste zone a cavallo tra il ‘500 e il ‘600; diventarono allora, nel breve volgere di alcuni decenni, non solo ben accetti, ma addirittura ricercati.
Già nel marzo del 1584 il Consiglio di Sant’Anatoglia mostra i primi segni di apprezzamento per l’opera del nuovo ordine e stabilisce che “alli frati Capuccini di Matelica s’habbia a concedere licenza di poter cavare dalle selve di Cafaggio 50 arbori”.
Alla fine del ‘500, l’Ordine, che intanto s’era espanso anche in altri paesi europei e che contava già più di settemila religiosi sparsi in più di seicento conventi, era ormai fortemente radicato.
Il 5 aprile 1615, durante il Pubblico e Generale Consiglio, 56 voti riempirono l’urna nel tiretto dei SI, uno solo fu contrario; con questa quasi unanimità, la Comunità di Santa Anatoglia decise di chiedere ai Padri Cappuccini, in occasione del loro Capitolo Generale che si sarebbe tenuto nel successivo mese di maggio in Fabriano, “di far qui un luogo di Cappuccini per augumento del culto di Dio e salute delle nostre anime”.
Nel luglio dello stesso anno, ancora il Consiglio Generale, stavolta all’unanimità, ottenuto l’assenso dal capitolo Generale dei Cappuccini, destina allo scopo la Chiesa di Santa Maria Nova (di cui oggi resta solo un rudere sotto la chiesetta del Crocefisso) ed elegge quattro deputati “quali in tutto e per tutto habbino autorità di far tutto quello occorrerà e sarà necessario”.
Ma la piccola chiesa, come relazionò ai Priori il Notaio Antonio Tronati, uno dei quattro deputati, risultò inadeguata “per essere Chiesa Parrocchiale e Cimiteriale” e poiché “la poca habitatione congionta alla detta Chiesa minaccia ruina”, si ritenne di indirizzare la scelta verso il Monastero di Fonte Bono, a quel tempo “benefitio semplice dell’Abbate Pierbenedetti da Camerino”.
Qualche tempo dopo, per il sostentamento del Convento, la Comunità si privava di una porzione della montagna, il Corsegno, da sempre patrimonio pubblico. E’ l’inizio di una attenzione continua: nel 1620 si stabilisce di concedere una elemosina annua di 24 scudi, nominando alcuni deputati per seguire i lavori della fabbrica; i lavori dureranno almeno un ventennio: ripetutamente la comunità concesse altre elemosine, legnami e contributi vari (“doi bidolli” vennero in dono anche dalla Confraternita del Gonfalone). Nelle locazioni di alcuni servizi veniva stabilita una elemosina obbligatoria in favore del convento: così il macellaro doveva riservare ogni anno un quarto di vaccina ai Cappuccini e anche nella locazione della “pisciaria”, che al tempo esponeva lasche, tinche e lucci, era previsto un contributo a “sostentamento dei capuccini”.
La loro presenza accrebbe il rispetto e la venerazione dei santanatogliesi per quel monte che sovrastava le loro case e che lungo il suo versante srotolava seminativi e boschi, pascoli, orti e acqua sorgiva, quasi un compendio dell’intero territorio; e sapientemente inseriti in quella risalita visiva, disponeva in progressione simboli di basse, ma non certo secondarie, esigenze terrene, come la torre di guardia del Roccone, e di elevata spiritualità, come l’eremo che sulle balze rocciose intimoriva e stimolava fantasie su miracoli e favolosi tesori.
E in mezzo, appunto, il monastero di Fontebono, pulsante di vita e ideale punto di raccordo tra il corpo e lo spirito, tra la terra e il cielo. Un percorso visivo ed emozionale che costituisce il fondale d’ogni possibile immagine di questo nostro paese e che custodisce, invisibili ai nostri distratti sguardi di oggi, ricordi di eventi e presenze che hanno caratterizzato la storia della nostra gente.
Alla nascita di Pietro Paolo, li Scapuccini s’aggiravano già lungo le strade di Sant’Anatoglia stringendo con la popolazione un legame importante.
Andavano per la cerca, la questua del pane, del vino, dell’olio, con cui si sostentavano; chiedevano (e spesso e soprattutto ai poveri che, è noto, a differenza di chi povero non è, difficilmente si sottraggono all’impegno della solidarietà, allora come ora…) e avevano perciò necessità di offrire qualcosa in cambio. Non solo parole di conforto spirituale, ma anche sollievo materiale di cui allora v’era di sicuro un gran bisogno.
La loro predicazione ed il loro esempio furono stimoli importanti alla pratica della solidarietà.
Non fu casuale che già l’inizio del loro primo insediamento coincise con una riorganizzazione del Monte dei Pegni che, istituito nel 1587, aveva col tempo progressivamente rallentato la sua attività.
Nel 1667 poi, come ci ricorda la Platea Universale della Famiglia Dialti, quando la presenza cappuccina s’era ormai consolidata, Angiolo Leonardi, particolarmente legato al monastero di Fontebono, lasciò in testamento alla Comunità di Santa Anatoglia “Rubbi dodici di grano coll’obbligo di fondarvi il Monte Frumentario Pio da imprestare il Grano a Poveri, annualmente nella Settimana Santa, e scudi ottanta coll’obbligo agli eredi di costruirvi la Casetta colla Madonna sopra il di lei Tetto da donarsi alla Chiesa di San Martino, per doversi portare in Processione nel giorno della Transazione della Santa casa di Loreto, come fù eseguito…”.
Era la riserva, soprattutto di grano, ma anche granoturco e orzo, che veniva raccolta in strutture adatte (a partire dal 1669 viene ammassata “sotto la Sala grande del Consiglio”, l’attuale teatro) e distribuita in tempo di carestia alle famiglie affamate; in molti casi, come anche a Sant’Anatoglia, tende a fondersi con l’istituto della Abbondanza che di norma aveva funzioni più ampie e complesse e prevedeva anticipazioni sui futuri raccolti.
Chiunque fosse pervaso da fervore religioso, da un concetto d’altruismo esasperato quanto, per la penuria dei tempi, esasperato era il bisogno di solidarietà, rivolgeva le proprie attenzioni, primi fra tutti, proprio a questi frati capaci di slanci e privazioni, staccati dal mondo ma in esso sempre immersi, immagini viventi di una povertà vissuta come viatico a benefici ultraterreni ma anche strumenti per lenire la fatica quotidiana di vivere, il dolore stesso dell’esistenza.
Se poi ciò inducesse ad una rassegnata accettazione o rappresentasse occasione di critica e di disaffezione a quel sistema basato sulle disuguaglianze, era e resta a tutt’oggi, uno dei problemi insoluti della religione fattasi istituzione; il messaggio evangelico sembra chiaro e radicale, che poi le parti più nobili siano state da sempre applicate in base ad interpretazioni che ne hanno stemperato la loro forza dirompente è una indiscutibile evidenza storica.
Riconducevano perciò a Fontebono gli impulsi che Pietro Paolo sentiva lavorare dentro di sé e che lo rendevano sempre più estraneo al suo mondo. E quelle voci soavi che sembra accompagnino questi momenti sublimi (come risulta dai racconti di chi viene risucchiato in vertigini mistiche) non faticarono ad individuare in quel monastero il luogo da cui potevano venire risposte alle inquietudini che da tempo ormai lo sovrastavano.
Inquietudini che, non è d’azzardo pensare, s’addensarono durante la Quaresima del 1638, a lungo ricordata come un evento speciale.
Riapriva la Chiesa di San Martino, il cui cappellone era stato appena ultimato ad opera di quegli abili specialisti venuti da lontano che la storia ci ricorda genericamente come “magistri lombardi”.
E poi la presenza di Frate Carlo Milanuzzi, il figlio del notaio del paese: musicista, poeta, fine dicitore, che nel suo girovagare in varie parti d’Italia, aveva diviso la sua vita tra conventi e salotti.
Prelato colto e uomo di mondo, avvezzo a sodalizi musicali con gente come Claudio Monteverdi, frequentatore di cenacoli e fatue accademie letterarie; distante ormai da Santa Anatoglia, ma nell’intimo ancora capace di calarsi nel ruolo del fustigatore in occasioni come quelle offerte dalla liturgia quaresimale, ch’egli forse viveva interiormente come una personale espiazione, per una vita forse non sempre consona all’abito talare.
La Comunità non poteva certo trascurare i rari ritorni in patria d’un concittadino così illustre; molti anni prima, nel 1616, gli aveva corrisposto 25 scudi per altrettante copie di un suo poema in ottava rima “Vita e morte di Santa Anatoglia”. Ora, il Consiglio Comunale nel febbraio del 1638, lo aveva nominato Predicatore per la Quaresima.
Ignorava forse le reali condizioni di larga parte di quella folla che s’assiepava nella chiesa, ma di certo ne capiva i sentimenti e ne sapeva stimolare le corde ricorrendo a quegli artifizi retorici che un uomo di lettere sa padroneggiare.
Non è difficile figurarsi l’intima reazione del giovane Pietro Paolo, pressato nella calca della chiesa, nell’udire la stentorea voce di quel frate agostiniano declamare ai suoi paesani ciò che aveva scritto nel suo ultimo libello, “I sette pungenti stimoli posti a’ fianchi del Penitente”, un commentario in ottava rima dei Sette Salmi penitenziali di David: “Omnipotente Dio mio, pensando di me stesso, e intrando dentro all’Anima mia, veggio chiaro che non son niente; e se son qual cosa, sono un ritratto di miseria, una carne verminosa, un vaso di putredine, una conca di cenere, un fango vivo, e una immagine espressa di vanità. Confesso essere simile ad una foglia d’arbore, che ad ogni vento si muove: anzi son come herba, recisa dalla falce, e come fiore, conculcato dal piede; Io, io son quello, ò Creator mio, che può cadere, ne può risorgere, pronto al male, e tardo al bene…”.
Parole che fendevano quell’aria rarefatta in cui l’aspro profumo dell’incenso s’impastava con l’inevitabile nidore stagnante dei tanti corpi che il rigido inverno di quell’anno costringeva in un viluppo di scialli, sinali e palandrane; esaltando la nullità si sbrecciavano i cuori dei presenti che quella condizione conoscevano, in molti direttamente, sulla propria pelle, senza alcuna metafora.
E la conosceva Pietro Paolo, nel cui intimo, seppur confusamente, sommando stimoli a inclinazioni, congiungendo esempi reali e immaginati, covava la smania di separarsi dalla sua stessa vita, da quel mondo chiuso che non poteva contemplare il suo bisogno di assoluto, le pulsioni verso scelte estreme.
Cresceva, così, sempre di più, lo smarrimento del giovane Pocognoli.
La famiglia, le bestie, la montagna, solo per qualche stagione riuscirono a trattenerlo ancora.
“Pervenuto Pietro Paolo coll’esercitio di vita così lodevole, e di costumi così esemplari all’età di circa ventitrè anni, si sentì nascer nel cuore, e dal cuore ascendere nell’Animo vive fiammelle d’un insolito spirito, che l’incitava, & eccitava a risolutione di opere più egregie, e di più generose, e più magnanime imprese”.
Fioriva in quel tempo la fama di Padre Dionigi Pieragostini, che “spargeva soavissimi e dilettevoli odori di virtù” nel convento dei Padri di San Filippo Neri a Camerino. Vi si recò allora, l’umile contadino, per esporre la sua situazione, i suoi impulsi, i moti segreti del cuore.
Alle risposte del venerando padre, egli rimase talmente impressionato e affascinato che, nella sua rustica semplicità, chiese a Padre Dionigi di… poter dormire, quella notte, con lui.
L’iniziazione
Una richiesta apparentemente strana, che “considerata nell’estrinseco, e con una sola superficiale riflessione potrebbe, anzi dovrebbe essere giudicata impertinente, o almeno affatto incivile”, ma che, se da un lato testimonia il probabile smarrimento di fronte a parole che gli confermavano la sua vocazione sciogliendo i dubbi che lo attanagliavano, stanno anche a dimostrare, nell’evidente ed ingenuo intento di assorbire con la vicinanza le doti del suo tutore, la corporeità della concezione religiosa del nostro, la sua fisicità, che avrà modo di manifestarsi poi in una innumerevole serie di fatti. Padre Dionigi “gli negò, è vero, con prudenti e congrue ragioni, di poterlo compiacere in quella sua divota, e semplice istanza”, ma lo rassicurò sulla giustezza della sua ispirazione prevedendo che “havrebbe perseverato con tutta facilità, e felicità nella sacra militia della Religione de’ Capuccini”.
Non tardò quindi a presentarsi al Padre Provinciale dell’Ordine ch’era allora Padre Francesco d’Ascoli, il quale, esaminato Pietro Paolo e avendolo trovato “pronto e fervido nel desiderio della virtù”, lo accolse nell’Ordine dei Laici e lo destinò per l’anno di noviziato nel Convento di Camerino sotto la direzione del Padre Nicolò da Cingoli “commendato ancor’hoggi per uno dei più insigni Maestri di spirito, e dei più perfetti Religiosi della Provincia della Marca in quel tempo”.
Trasferitosi quindi nel Convento di Camerino, dopo alcuni giorni in cui fu trattenuto, com’era d’uso, in abiti secolari, il 13 ottobre 1643 “fu favorito dell’Habito Serafico” e nel vestire il saio “fu honorato col nome del suo celebre Prozìo F. Giuseppe: il quale con fama (rispetto al luogo si può dir massima) di virtù era passato all’altra vita nell’anno antecedente in Macerata”.
Ecco quindi Fra Giuseppe da Sant’Anatoglia, detto ‘il giovane’ o ‘iuniore’, “un fiore da un rustico campo trapiantato ne’ giardini delitiosi” calare il suo fervore nel confronto quotidiano con le regole imposte dalla vita monastica.
Il periodo di noviziato lo confermò degno di essere aggregato all’Ordine e, al termine, “ne fu favorito, e decorato colla sacra, e solenne Professione da’ Padri”: divenne, come il Fra Giuseppe che l’aveva preceduto, laico professo.

Le mortificazioni di un carattere aspro
“Le mortificazioni; le penitenze; le fatighe, i digiuni; i disaggi; le astinenze; le discipline; il sovenire a gli altrui bisogni” questi gli aspetti fondamentali su cui volle improntare da subito la sua vita: lo aiutavano una fede ostinata e la tempra maturata sui monti.
La solitudine di un pastorello aveva lentamente forgiato uno straordinario fervore religioso, ma anche una straordinaria capacità sensitiva e soprattutto aveva affinato l’efficacia dell’ascolto e del gesto. La stessa solitudine rese invece incerta la sua parola, privandolo così di un fondamentale strumento, un lenimento spesso più energico di tanti medicamenti; seppure scarsa, la favella d’un contadino ignorante, seppe comunque usarla, con una parsimonia che ne aumentò l’efficacia.
Dei suoi primi anni, dell’ambiente in cui si formò, di Pietro Paolo Pocognoli insomma, rimase a Fra Giuseppe da Sant’Anatoglia un’impronta che per alcuni aspetti caratteriali lo contraddistinse lungo tutto l’arco di vita. Leggendo dei suoi ìmpeti, dei suoi scatti, di alcune sue intemperanze (poi sempre mitigate o comunque riassorbite dalla sua professione di fede), del temperamento a volte anche irascibile (un “humor bilioso”), viene da pensare a quello che parrebbe essere un luogo comune sul carattere del suo ceppo familiare.
Fa parte infatti della tradizione locale l’uso di ‘pocognolu’ come sinonimo, spesso anche giocoso, di modi bruschi, con valenze ancora più forti quando il termine, nei racconti di oggi, viene ricollegato a quegli episodi violenti in cui furono coinvolti, sul finire del secolo scorso, alcuni membri di quella famiglia e che si sfarinano nel fondo della memoria collettiva dove sedimentano, spesso confondendosi, storia e leggenda.
Nel ricostruire la sua figura, Fra Giovanni da Belvedere ci ricorda che “era egli di naturalezza, che tendeva all’aspro, & al rozzo; ma l’uno, & l’altro così contemperato, e raddolcito dal predominio auttorevole della virtù, che in vece di renderlo o incivile, o poco grato a chi trattava con lui, gli conciliava mirabilmente con un segreto impulso simpatico appresso i Frati, e molto più appresso i Secolari (ancorché nobili, e riguardevoli di condizione) un rispetto riverente, una veneratione divota, & un ragionevole concetto di una vita, non solamente buona, e virtuosa, ma santa”.
La lotta per contrastare questo temperamento, per controllarlo e reprimerlo, non dovette essere né breve, né facile; impressiona la durezza dello scontro interiore che portava ad un’aspra forma di autopunizione.
Quando si sentiva assalito da atteggiamenti inadatti alla sua professione di fede, quando insomma gli montava in corpo quella rabbia mai sopita contro cui aveva sempre combattuto, “se si ritrovava non distante dal fuoco, prendeva pugni di cenere, e se ne empiva all’improviso la bocca: e masticandola, & inghiottendola, puniva il suo forse non punibile errore, & insultava, e tormentava insieme se stesso. Ma questo è poco. Prendeva pugni di cenere non calda, nò; ma infocata tutta, e rovente: e ponendosela in bocca, e masticandola, & inghiottendola, insultava i suoi moti improvisi, li frenava, gli abbatteva, e li puniva con fervore ammirabile di un’asprezza, e penitenza non meno ardua a’ nostri giorni, che inaudita”.
La mortificazione raggiungeva il suo culmine nei rapporti con le donne: chiunque lo conobbe attestò che “sopra tutto alla presenza di Donne, di qualunque conditione si fossero, mai sia stato veduto alzar da terra per una semplice , o sola volta i suoi occhi. Anzi in questa parte sempre si portò con tanta, e tale ristrittione, e rigore, che o stando in piedi, o sedendo, o parlando secondo le occorrenze con Donne, tutto umile, vergognoso dal solo moto delle palpebre poteva dimostrar di esser vivo in questo senso della vista, e non morto”.
Umiltà e disistima (“Gli occhi in terra e l’anima in cielo”)
Tre sono i gradi principali della virtù dell’umiltà, come i frati del tempo potevano imparare principalmente dagli scritti di San Bonaventura da Bagnoregio, Doctor Seraphicus il cui ‘Itinerarium’ (che lo condusse, primo tra i Cappuccini, alla porpora cardinalizia), viene così pianamente volgarizzato da Fra Giovanni da Belvedere: “il primo è, il riconoscersi vile, peccatore, povero di ogni bene, debolissimo alle virtù; il non anteporsi a chi si sia, benché minimo, né bramare, e molto meno ricercar le lodi, e gli honori. Il secondo è, non solamente disprezzar se stesso, come affatto miserabile, e vile; ma sopportar patientemente, anzi desiderare con sincerità, di esser conosciuto, e disprezzato come vile da tutti, e vilipendere, & aborrire con un risoluto et implacabil’odio ogni honore. Il terzo, et ultimo grado finalmente è, che quanto più insigni sono le sue virtù, e quanto maggior’è la copia delle gratie da Dio per sua benignità conferitegli, e quanto più cospicui son gli honori, che conseguentemente ne riceve da gli uomini; tanto più si avvilisce, e si reputa di verità un puro nulla, riferendo, e restituendo tutto a quel Dio, ch’è l’unica origine, il dispensiero, e l’autor di ogni bene”.
Forse senza alcun debito verso la teoria, ignaro delle profondità del pensiero che si poteva costruire sulla rinuncia, Fra Giuseppe ci viene offerto come la quintessenza dell’umiltà e della disistima, quasi che lo spregio di sé fosse connaturato alla sua stessa esistenza e non certo frutto di studi e riflessioni.
Il sentir bassamente di sé stesso, lo studiare di avvilirsi, lo stimarsi inferiore a tutti, il reputarsi peccatore, il dichiararsi privo di ogni bene, l’attestarsi senza lume divino, il professarsi senza ombra di spirito, il pubblicare la bassezza dei suoi natali, l’ingrandire la scarsezza dei suoi talenti, l’ampliare la rozzezza dei suoi costumi, il ricercare i disprezzi, il desiderare i disonori, l’aborrire ogni stima, il detestare ogni lode, l’abbassarsi nei profondi abissi del suo niente,…… tutto questo fece si che “universalmente poveri, e ricchi; ignoranti, e dotti; plebei, e nobili; uomini, e donne; Secolari, et Ecclesiastici di qualunque sfera con somma stima l’ammiravano, ne discorrevano, il riverivano, lo celebravano”.
La fama delle sue gesta prese a diffondersi e in breve tempo si moltiplicarono le richieste d’aiuto; chiunque lo avvicinasse chiedendo di essere sfiorato a sollievo di qualche travaglio si sentiva rispondere “Che vuoi che faccia questo poveretto? Che vuoi che faccia un peccatore, come son io?” E a chi non aveva notizia della bassa condizione dei suoi natali aggiungeva con enfasi “Che vuoi da me che sono un Capraro, figliuolo di Pocognolo, che non so né leggere né scrivere, malcreato, senza vero e conveniente lume di Dio? Se mi conosceste, mi tirereste le pietre, né mi stimereste né mi portereste alcun rispetto come hora fate”.
Povertà “Più degli altri povero”
“Con ragione molti Santi, e fra questi il grande Agostino intendono e spiegano l’humiltà: in modo che non possa alcuno esser povero, se non è umile; né essere veramente, e virtuosamente umile, se non è povero”.
Il francescanesimo ha da sempre dibattuto sull’argomento della povertà; su questo terreno si sono consumate tante riforme quante nessun altro Ordine della Chiesa ne abbia conosciute.
Anche i Cappuccini erano nati da istanze legate ad un ritorno agli iniziali ideali di povertà che tre secoli di storia avevano appannato.
E Fra Giuseppe, cresciuto nel rigore di una povertà che pur se subìta aveva interiorizzato come l’estrema essenza della vita, sentiva intimamente che era quello il sentiero da percorrere, lo strumento per avvicinarsi al sublime, in leggerezza, spoglio di qualsiasi orpello.
Non solo amava ridursi alle strettezze, ma la sua stessa esistenza era connaturata alla miseria, ad una rigida e “rigorosa estremità di penuria”.
“Più degli altri povero nella Cella, di sito meno gradevole; di massaritie meno proveduta; di comodità affatto meschina…. Più degli altri povero nel vestire: le cui suole erano le più sprezzate; le cui mutande, e corda, erano le più mal acconcie: et il cui abito rozzo, rappezzato e così male in essere, che s’era atto a ricoprirgli con decenza convenevole il corpo, era poco atto a ripararlo dalla rigidezza della varia et ingiuriosa conditione dei tempi. Più degli altri finalmente povero nel vitto, nell’uso, negli affetti, e nella indispensabile, et assoluta privatione del tutto, in modo che l’istessa virtù dell’astinenza era da lui disposta all’ingrandimento della povertà, e col rigor dei digiuni, e coll’elegger sempre al necessario suo sostentamento il meno buono, il più mal conditionato, il più vile”.
Era la totale sintonia con i tempi e i luoghi della sua vita, la possibilità di fondersi con la miseria che sovrastava la vita della maggior parte della gente.
Non erano molti quelli risparmiati dalla penuria e che potevano consentirsi una vita dignitosa; pochi potevano scialare, pochissimi quelli che osavano farlo.
In questo quadro fosco, gli uomini s’alleviavano la vita contemplando la possibilità di mali peggiori, di una condizione più abbietta di quella in cui erano immersi; l’autoconsolazione aiutava non solo a sopravvivere ma pure a trovare tempo e coraggio per pensare anche agli altri, a chi stava peggio.
Così l’indigenza non impediva ai Priori che reggevano il Comune, di preoccuparsi, addirittura, “di fare una finestra di legno, et un tavolato nella nuova prigione stante la miseria e necessità dei poveri carcerati”; annotiamo: “i poveri carcerati”!
Si era periodicamente esposti alle indecifrabili vicende dei cicli stagionali, per cui a scarsi raccolti s’alternavano spesso vere e proprie carestie. Come nei primi anni settanta, quando per diverse stagioni la campagna tornò ad essere tanto avara quanto lo era stata negli anni più bui di cui si conservava il ricordo.
Scarseggiarono i raccolti e la Comunità s’arroccò per garantire la sopravvivenza: distribuzione ai poveri del grano dell’Abbondanza, divieto di vendere fuori del comune, tagli di spesa come diremmo oggi. Sulle porte delle taverne e delle pizzicarie si promettevano, anche se a prezzi proibitivi, “polbette”, “presciutto senz’osso” e “salciciotto buono”, ma trovavi solo “strutto, lardo e barbaglia” a cinque e anche sei baiocchi alla libbra, per molti un’enormità.
Il Consiglio Generale del 9 febbraio 1672 decretò addirittura una rinuncia, forse non pesante ma emblematica:“Essendo ch’in questi tempi calamitosi, che non si lavora, si vede tanta gran miseria nel popolo, acciò non si senta qualched’uno morir di fame, sarei di parere che si derogasse a quel decreto fatto di andare alla Santa casa di Loreto et in cambio che quel danaro sia restituito all’Abbondanza anzi alli poveri stessi…”. Nei borghi, nelle contrade afflitte da questa guerra quotidiana, Fra Giuseppe, povero tra i poveri, anzi “più degli altri povero”, s’aggirava col saio rappezzato, trovandosi spesso a ridistribuire il frutto della cerca, a dare ad altri quel poco che aveva ottenuto per sé e per il suo convento. La povertà era il suo privilegio, da lì forse veniva la forza che gli riconobbero quelli che lo incontrarono; era la sua arma, strumento poderoso per combattere la mai sopita sua guerra interiore: “…quanti furono gl’incontri generosi, e gli sforzi, co’ quali senza minima tregua atterrì, e felicemente atterrò i suoi nemici Mondo, Carne e Demonio”.