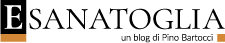In un recente post su Facebook, nel Gruppo “Dialetto matelicese”, è stata proposta la discussione sul termine “stumularu”. Nei vari commenti sono emerse da subito, oltre alla spiegazione del significato, anche le varianti, in particolare “stummularu” e anche “stimularu” o “stimmularu”.
E’ stato identificato da alcuni come lo strumento che serviva a pulire l’aratro o i coltelli della seminatrice raschiando via il fango che vi rimaneva appiccicato. Ennio Donati, provetto cultore del dialetto matelicese, propende per la variante “stumularu” che ipotizza possa provenire dal “tumulus” latino (tumulo, protuberanza di terra su un piano).
Ricordo che Don Amedeo Bricchi (nel suo “Matelica I suoi abitanti Il suo dialetto“) aveva a suo tempo proposto “stummularu” come “il bastone con cui si toglie la terra che si è ammassata sull’aratro, ma di questa voce non ho potuto trovare l’etimologia”.
Effettivamente serviva anche a questo, ma non solo. In base a quanto desunto da fonti archivistiche e da un conseguente approfondimento, mi sento di proporre una estensione della sua funzione e anche una etimologia diversa.
Non si limitava alla sola pulizia, era infatti un arnese per così dire pluriuso. Si trattava di un bastone, di norma leggero e resistente (preferibilmente, come vedremo, di castagno), preparato con essiccatura al fuoco, una sorta di carbonizzazione controllata per renderlo ancor più duraturo; ad una estremità era provvisto di una lama metallica che serviva appunto a raschiar via il fango dal vomere o da qualsiasi altro attrezzo agricolo che entrava a contatto con la nuda e fangosa terra, e al lato opposto aveva una punta di ferro che altro non era che il pungolo per i buoi (o ‘le vestie‘ in generale), in lingua chiamato anche “stimolo” (anticamente “stimulo“).
Da qui, probabilmente, il nome dell’attrezzo con la deformazione linguistica che avrà condotto l’originario “stimulu” dapprima a “stimmulu”, poi a “stimmularu”, fino a “stummularu” o “stumularu” che dir si voglia, con la progressiva perdita di collegamento con quella funzione di pungolo che inizialmente doveva essere stata la principale.
A parziale conferma di ciò, ricordiamo che De Martella, per quanto riguarda il dialetto camerte, propone “stummularu” come una “frusta, alla cui estremità è fissata una raschietta per togliere la terra attaccata al vomere”, laddove la frusta è a suo modo un pungolo, anche se non aguzzo, che denota comunque il doppio uso dell’attrezzo.
La vita del contadino era necessariamente legata agli animali e agli attrezzi agricoli da essi trainati, per cui “lu stimmulu” o “stimmularu”, proprio per la sua versatilità, era un necessario complemento alla attività ed era quindi molto spesso a portata di mano. Questo spiega perché molte questioni nate in ambiente campagnolo, terminassero poi con un suo uso improprio, da vera e propria arma di offesa.
Diverse testimonianze di casi finiti davanti al magistrato per lesioni personali ci raccontano l’estrema disinvoltura con cui, di punta o di raschia, si ricorreva allo “stimmularu” per dirimere controversie.
Ne scelgo uno ad esempio perché ce ne fornisce anche una accurata descrizione in quanto “lo stimmolà” stesso era ‘corpo del reato’.

8 agosto 1795
Siamo nell’agosto del 1795, nei pressi di Pagliano. Sul tratto di strada che Giuseppe Todini sta percorrendo, s’affaccia “l’ara” della casa dove abita Domenico Cristofanelli, originario di Serra San Quirico e contadino in una proprietà della Abbazia di Fontebono in affitto a Ludovico Fantini. A raccontare il fatto è Giovan Battista, figlio di Domenico, che si presenta al magistrato reggendo in una mano una sorta di bastone e nell’altra un cappello di paglia. Secondo il teste, Domenico aveva un conto in sospeso con il viandante e coglie l’occasione di quel passaggio di Giuseppe per togliersi un po’ del rancore che gli covava dentro. Inizia a rimproverarlo in maniera insistente “di aver sparlato delle sue figlie”. Di fronte a tali rimostranze, forse esternate in maniera anche un po’ aggressiva, Giuseppe non si lascia intimorire, anzi reagisce. Tanto è vero che Giovan Battista depone che: “lo stesso Giuseppe gli si è fatto contro con questo stimmolà che presento a Vostra Signoria [e avrà mostrato al giudice il bastone] avendo lo stesso mio padre con un colpo di esso datogli in testa disteso per terra con averlo ferito in due luoghi, dopo di che lo stesso Giuseppe avendo lasciato lo stesso stimmolà e suo cappello che parimenti presento a Vostra Signoria [e qui avrà deposto anche il cappello] è fuggito.”.
Esula dall’argomento ma merita soffermarsi sul cappello che è “di paglia con fettuccia di color di rosa spallida per il sole del prezzo di sette quattrini al braccio, con cappio della medesima fettuccia. Diversi lavori di paglia in guarnizione in mezzo alla falda; guarnizione di paglia spizzata all’estremità della falda; fuori all’esterno della cuppola due aghi da cugire uno senza filo e l’altro con filo bianco involto a detto ago.” Niente male come descrizione, esaustiva.
Di estremo interesse, per il nostro scopo, è invece la descrizione agli atti del vero e proprio corpo del reato: “Stimmolà con rascella [‘rasciare’ è una variante di ‘raschiare‘, da intendersi pertanto come ‘raschietta’] di ferro da piedi fermata con chiodo, da capo del medesimo Stimmolà una roccetta di legno del medesimo Stimmolà di Castagno, e in cima un puntaroletto di ferro”.

Descrizione de “lu stimmolà”
Domenico, la vittima, nella sua deposizione circostanzia ancor più la scena: egli stava “a capare la cicerchia” quando nella strada contigua alla sua aia transitano Giuseppe e suo fratello Sebastiano “li quali portavano un paio di bovi per ciascuno con Stimmolà in mani…”.
E a cosa servisse lo stimmolà ce lo ricorda un interessante esemplare mutilo conservato nel Museo del cavallino della Giara a Genoni (Nuoro). In Sardegna si chiama “lu strùmbugu” e viene definito come “strumento manuale con cui l’ aratore taglia le radici, spezza le zolle, pulisce il vomere dalla terra che vi si attacca ed incita la coppia di buoi a camminare“. La descrizione precisa che è uno “strumento composto da un manico in legno, lungo venti centimetri, sul quale è applicata la parte agente, una paletta di ferro tagliente, larga sette centimetri, a forma di trapezio isoscele rovesciato con la base maggiore che pulisce il vomere. Dall’altra parte del manico dovrebbe essere applicata una punta in ferro, ‘sa spina’, che serve ad incitare i buoi a camminare, ma in questo caso è mancante perché il manico del pungolo è spezzato.”.

lu strùmbugu (“lu stimmularu” sardo)
Testimonianze ancor più antiche sull’uso del termine nel nostro territorio e sulle particolarità tecniche dell’arnese stesso, sono contenute nei Registri Criminali del 1587 dove, nel caso di un dissidio sorto in un castagneto nella zona di Cafaggio viene riportato che alcuni boscaioli, prima di venire alle mani per questioni di confini, “cominciaro ad abbruscare i picchoni o vero stimulari che havevano cavati da detta selva…“.
Per avere un quadro completo di questo arnese di cui s’è ormai persa la memoria e persino il nome, lo si immagini come se fosse stato allo stesso tempo attrezzo di lavoro, simbolo di distinzione (qualche lavorazione di intaglio del legno non sarà di certo mancata – si pensi alla “roccetta di legno” di cui alla descrizione di fine ‘700) e, all’occorrenza, arma di difesa e d’attacco.