millenovecentodiciassette
Anno terzo
Affinché nessuno potesse illudersi, il 1917 s’annunciò così: il primo di gennaio, con implacabile puntualità, all’Albo Pretorio del Comune e negli spazi d’affissione in piazza, apparve il manifesto dell’Ufficio Leva con l’obbligo per i nati del 1900 “di domandare entro questo mese la loro inscrizione e di fornire gli schiarimenti che in questa occasione potranno loro essere richiesti”.
La guerra continuava e i prossimi sarebbero stati loro.
Così come l’anno prima era toccato agli ultimi nati del secolo passato, che di lì a poco sarebbero stati inviati ai campi di battaglia e consegnati alla storia come ‘i ragazzi del novantanove’.
Nei registri d’anagrafe del 1899 risultavano una ottantina di nascite. Una metà circa erano femmine. Per i maschi, la morte prematura ne scremò più di un quarto che, com’era usuale allora, non sopravvisse ai primi due anni di vita. Altri se ne partirono, negli anni a venire, al seguito delle loro famiglie per migrazioni vicine e lontane. Da una diversa colonìa in qualche paese vicino, fino alle lontane Americhe. Ulteriore selezione la fecero le difficoltà del campare, che producevano una buona quota di invalidi e inadatti alle armi. Fatto è che di abili arruolati all’alba del 18 febbraio, per il primo dei tre scaglioni, se ne partirono in dieci. Due di loro non sarebbero mai più tornati.
Degli altri due scaglioni, un’altra decina di ragazzi in tutto, furono invece in tre a non far ritorno.
Il loro addestramento fu sommario e sbrigativo; furono all’inizio inquadrati in battaglioni della Milizia Territoriale con compiti di scorta ai prigionieri e poco più. Conobbero poi il campo di battaglia, dove vennero scaraventati verso la fine dell’anno, nell’urgenza dei momenti disperati del dopo Caporetto.
Per rinsaldare lo spirito fiaccato e le speranze affievolite, alcuni dilettanti – così si definirono quei quattro o cinque che, per capacità e intraprendenza ma anche per la fortuna di potersene stare dietro a una scrivania o a un bancone, riuscivano a concepire queste idee – vollero mettere in scena al Teatro Comunale un “dramma patriottico in due atti”, il ‘Guglielmo Oberdàn’ di tal Oreste de Vivo. Lo presentarono con una perorazione in rima, indirizzata al Presidente della Deputazione Teatrale, con cui riassumevano la situazione angosciosa del paese: “Come un velo offuscante e tenebroso / L’apatia sottopone tutto qui; / Il respiro predomina alenoso / E ci rammenta sempre chi partì.” E ancora, dopo altri versetti dallo spirito lieve e dalla rima forzata, precisarono che “L’incasso verserassi al Comitato / Civile di Mobilitazion. / Bello il movente e tutto l’operato / Degno è di plauso e d’ammirazion.”.
Voleva essere di sprone a un amor patrio che cominciava a vacillare e anche di ideale sostegno a quelli che pativano e che partivano, ancora.
E partirono, proprio pochi giorni dopo, i primi dieci ragazzi del ’99. Il 18 febbraio all’alba, con la prima corsa del postale, capo drappello Evaristo Pacini. Tra di loro, c’era anche chi non aveva ancora compiuto diciott’anni.
Abili, arruolati, insubordinati.
“Un supremo sforzo per la patria….”, era l’imperativo di chi apertamente condivideva quella guerra.
“Vogliono altra carne da macello…”, sentenziava mugugnando chi, all’opposto, la avversava.
Comunque fosse, per rastrellare tutto il capitale umano vennero rivisti tutti gli esoneri concessi in precedenza.
Fu ridotta anche l’altezza minima per essere arruolati, da un metro e cinquantacinque scese a uno e cinquanta; d’altronde, non era forse ferma a uno e cinquantatré Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele Terzo di Savoia?

Per quei pochi centimetri, in due tornate di visite al Distretto, tra aprile e luglio, ne furono ripescati addirittura in venti, tra cui Filippo Dragoni, 152 centimetri e mezzo, che sopravvisse alcuni mesi alla fine della guerra e morì a Esanatoglia divorato dai patimenti sofferti al fronte.
Negli accertamenti sui rivedibili e sui riformati, sembrò venisse rivista e riformata la stessa scienza medica. La Commissione, a meno di casi eclatanti, disconobbe l’impiccio di ernie inguinali e la gravità di conclamate epilessie, minimizzò sulle gracili costituzioni e ignorò del tutto “cicatrici estese a tutto il corpo” e persino la “alterazione organica dei testicoli”.
Nella foga di rimpolpare le fila dell’esercito, non si guardò in faccia a nessuno, e non solo in senso figurato. Perché se i coscritti li avessero guardati almeno in faccia, uno come Ginetto (così da tutti era chiamato), lo avrebbero rimandato subito a casa. Invece persino lui fecero ‘abile arruolato’ e lo spedirono “in territorio dichiarato in istato di guerra” malgrado non fosse capace di intendere alcunché né tantomeno di badare a sé stesso. Dovette intervenire il Comune, con una ferma protesta e un fitto scambio di corrispondenza con Ministero e Distretto, per far riconsiderare e annullare quell’arruolamento e riconsegnare Ginetto alla sua famiglia prima che facesse del male a sé e agli altri. Dovettero andare a riprenderlo all’Ospedale Militare di Spezia.
Se quello era il criterio, Lao si sentì rincuorato: pensò che di quel passo, sarebbero anche riusciti a cancellare, magari con Decreto Luogotenenziale, il suo rachitismo, rendendolo per legge “bónu pe’ lu Re”, come si usava dire.
Ma eccetto i casi estremi, come Ginetto e Lao, da quella guerra non si scappava. Qualcuno raccontava ancora del periodo a cavallo dell’unità d’Italia, quando era piuttosto diffusa anche da noi la renitenza ed era facile nascondersi e sottrarsi ai controlli. Ma erano ormai passati quei tempi e l’unica via percorribile – a meno che non si avessero agganci potenti – era, per così dire, la via sanitaria, cioè l’esonero per problemi fisici. In generale, si manifestarono molti casi di autolesionismo, di simulazione di malattie mentali, e qualche mugugno sotterraneo riguardo a qualche caso, serpeggiò anche da noi.
Ma non era facile, il setaccio dei controlli fu a maglie sempre più ristrette. Quindi, si chinava il capo, si partiva e si combatteva, magari covando dentro disperazione e rabbia. Tutt’al più si provava ad evitare il fronte più esposto.
Vi furono casi di ribellione, ma si trattò di episodi legati più alla reazione contro disparità e disumanità di trattamento che contro la guerra in sé, e se ne ebbe solo una conoscenza tardiva.
Un episodio, tra quelli che nella storia ebbero maggior rilievo, un po’ ci riguardò anche da vicino.
Quando la seppe Lao, diverso tempo dopo, la notizia era già di terza mano, come spesso erano i racconti della guerra. Riguardava Alberto Cesolari, classe 1887, e proveniva da alcuni suoi commilitoni che parlarono di lui come un carattere che, già focoso di suo, s’era assai inasprito con la guerra. I Cesolari, originari di Tolentino, erano da una trentina d’anni contadini qui da noi. Esanatogliesi a tutti gli effetti ormai, e anche un po’ collegati a Lao per via di certi comparaggi con la famiglia materna degli Spitoni.
Alberto fu fante del 38° Reggimento Fanteria, nella Brigata Ravenna che le cronache avrebbero poi ricordato per uno degli episodi più odiosi del conflitto. In quel marzo, accadde che i soldati della Brigata, provati fisicamente dalla lunga permanenza al fronte e esasperati per i turni estenuanti e le licenze sospese, manifestarono insofferenza per il rientro in prima linea. L’alcool che si usava per abbattere i freni inibitori affinché non esitassero al momento dell’assalto, quella volta aiutò i fanti a sollevare la testa. Ne uscì una protesta. Vennero esplosi colpi di fucile in aria. Niente di più. Poi tutto fu sedato e parve rientrare nella normalità. Ma l’Alto Comando ritenne di dover dare una lezione esemplare a quell’affronto. Iniziarono col giustiziare sul posto due soldati trovati assopiti dove e quando non avrebbero dovuto. Proseguirono, tenendo sulla corda l’intera Brigata, giorno dopo giorno per quasi un mese, con la crudele decimazione, tramite fucilazione, di almeno una trentina di soldati.
Cesolari, che pare fosse parzialmente coinvolto nella protesta iniziale, riuscì, non si sa come, a scamparla. Ma non ebbe modo di poterla raccontare perché cadde in combattimento, il successivo 23 maggio, nel corso di un attacco sul San Marco che fruttò la conquista di una importante posizione (Casa Diruta – Due Pini), la cattura di più di cento prigionieri, al costo, per la Brigata Ravenna, di oltre 400 uomini dei quali 19 ufficiali.
La vita scandita dai morti
Si piangevano i morti della guerra, si parlava di loro, ma dal fronte, morti non si tornava. Un effetto strano, irreale. Da noi la morte era un fatto concreto, fisico, aveva i suoi solidi rituali basati sulla vicinanza, su gesti antichi di contatto col corpo del defunto che dilatavano quel poco tempo concesso prima della definitiva separazione: la stretta al momento del trapasso, la vestizione, la veglia funebre, l’amorevole ultima carezza prima della chiusura della bara. Poi, da un secolo ormai, l’ultimo simbolico tragitto insieme, fino al Camposanto, l’accompagnu, con la bara trasportata col carretto che i familiari quasi spingevano insieme ai vespilloni o qualche volta portata pure a spalla, e quindi la sepoltura, quasi per tutti in terra. Di tutto questo, niente. La morte dei soldati era solo la cancellatura di un nome da un elenco. Solo fogli di carta che arrivavano in comune, dispacci secchi, a volte anche insolenti, forse involontariamente, come quando un graduato sprovveduto, nel comunicare che un soldato era disperso, scrisse: “ho il pregio di comunicare che… ecc.”. Poi, qualche volta, magari a mesi di distanza, tornava un pacchettino con gli effetti personali del militare morto, ed era ancor più straziante e per di più beffardo, ritrovarsi tra le mani pochi spiccioli, qualche lettera, un santino o una medaglietta. Quattro carabattole che diventavano reliquie, riassunto di una vita.
Sembrava che non fossero davvero morti, che la morte fosse solo una notizia, che a morire fosse solo il nome.
E dopo ogni notizia, dopo ogni nome che veniva depennato, Lao lo avvertiva, aumentavano le visite al suo scranno di scrivano. Alla notizia di una sventura, reagiva così chi aveva familiari al fronte, provava a sincerarsi che i loro cari fossero ancora vivi, stabilendo l’unico contatto possibile, quelle poche righe, per le quali Lao si stava specializzando sempre più.
Scriveva, e teneva la conta di tutti gli eventi legati alla vita del fronte, incrociava le notizie dei militari che scrivevano, le loro licenze, il ritorno in linea. Un archivio vivente del conflitto, arricchito anche di placida quotidianità, ma che continuava a contemplare, anzitutto, quella terribile cancellatura, con il passaggio dei nomi dall’elenco “militari al fronte” a quello “caduti”.
Nei primi cinque mesi dell’anno, con sollievo di tutti, la contabilità dei morti subì un rallentamento. Solo tre volte venne aggiornato l’elenco.
Il primo a cadere, in ordine di tempo, a metà gennaio, fu Fiore Chiappa. Un contadino che trasferendosi da una colonìa all’altra in fondi confinanti, s’era trovato, a guerra iniziata, ad essere cittadino di Matelica. Classe 1876, uno dei più anziani e quindi inquadrato in una Centuria, la 895esima, con compiti di supporto. Una valanga di neve lo travolse sul Monte Adamello. La sciolta delle nevi restituì il suo corpo il 23 maggio successivo, dopo quattro mesi. Insieme ai tanti altri ch’ebbero la stessa sorte, peregrinò ancora per quelle terre, poiché fu sepolto dapprima a Val Cigolera e da lì poi trasferito, nel 1920, a San Martino di Castrozza e quindi, ultimo suo ricovero, quando il mito dei caduti fu utile al fascismo, finì nel Sacrario di Feltre. Girò molto di più da morto che da vivo.
Ai primi di febbraio, il 7, toccò a Emilio Darrighi, ventidue anni, figlio d’ignoti, un visciu o visciarellu come si diceva, cresciuto da un tal Antonio Bottaccio come garzone (“come un figlio” fece attestare costui al Sindaco, un paio d’anni dopo, per avvalorare la richiesta di reversibilità della pensione di guerra). Il destino collocò la sua esistenza grigia a combattere sul Carso e a morire in combattimento sul fronte Castagnevizza – Hudi Log, nella Dolina Liguria, col 1° Reggimento Fanteria, Brigata Re, uno dei più antichi e gloriosi dell’Esercito Italiano. Chissà se mai ritenne questo un privilegio.
Appena due giorni dopo giunse la notizia della morte di Antonio Di Piero, del 213° Fanteria, Brigata Arno. Lo raccolsero quelli della 128esima Sezione di Sanità Someggiata, deputati con muli e cavalli allo sgombero dei feriti, in quella striscia di terra tra le trincee opposte che si fronteggiavano intorno al Monte Palo, tra Asiago e l’Ortigara. Fu trasportato a morire nel presidio approntato più a valle. Risultò ufficialmente morto a Campofilone, il 22 gennaio. “Voglia la S.V. – scrisse al Sindaco, con inusuale delicatezza, un Colonnello Comandante – prestare i conforti del caso ai congiunti addolorati e farsi interprete dei sensi di riconoscenza della Patria.”. Antonio Di Piero, classe 1896, ventuno anni.

“Io ti scrivo quasi tutti li giorni..”
A partire da maggio e fino alla fine dell’anno le morti si infittirono, in sei o sette mesi sarebbero state una quindicina.
Pur essendo concentrato sulle vicende dei singoli, e uso a dedicare il suo tempo a storie infinitamente piccole, Lao non poté non avvertire di quel periodo gli enormi cambiamenti nello scenario mondiale. Ai primi di aprile entrarono in guerra gli Stati Uniti d’America, e avrebbero cambiato le sorti del conflitto. A marzo, in Russia, era iniziata una rivoluzione che le sorti le avrebbe cambiate al mondo intero.
Ma tutto ciò, almeno per il momento, nella quotidianità nulla cambiava: gli uomini erano ancora in guerra e Lao, quindi, scriveva.
Scrisse, ad esempio, a metà aprile, per Maria ‘de Dorge de le Coste de Fargotto’ a rassicurare Giuseppe Dolce, suo marito, che si lamentava di non ricevere da molto tempo sue notizie, nonostante lui trovasse il tempo per farlo assiduamente (“io ti scrivo quasi tutti li giorni..” scrisse nella cartolina postale che Maria portò a Lao, sostenendo fosse l’unica arrivata). Giuseppe si preoccupava, “per cui – le mandava a dire dalla Zona di Guerra – non posso stare contendo perche mi fanno sospettare a tante cose” .


Tra le tante altre, scrisse a metà maggio una lettera per conto di Vincenza Bartocci, madre di Francesco e Giuseppe Barbarossa. Non indirizzata a loro, che erano morti, ma direttamente a Sua Eccellenza il Ministro della Guerra, come Lao stesso si vantò d’averle consigliato, per chiedere che l’altro suo figlio al fronte, Celeste, venisse dispensato dal servizio in prima linea “affinché venga almeno alleviato lo stato di trepidazione in cui vivono senza tregua una povera madre ed una giovane sposa”. La richiesta, Lao volle che fosse precisato, era fatta “in via di grazia e non di giustizia”.

Scrisse la lettera secondo prassi e con adeguata forma. Lao era attento a questo, si sentiva ormai esperto in ‘suppliche ai potenti’. Vincenza ottenne una risposta, e il Ministero non era certo solito farlo con tutta la corrispondenza che riceveva, soprattutto quella che riguardava casi ordinari. Ma la risposta fu uno schiaffo, secco e sonoro. Si ribadiva che l’esonero spettava solo a chi aveva tutti i fratelli alle armi e di questi almeno due dovevano esser morti in combattimento ovvero dichiarati dispersi da oltre tre mesi. I due morti c’erano, ma mancava l’altra condizione: v’erano infatti altri tre ostacoli: si chiamavano Palmerino, Sestilio e Pietro, tre fratelli più piccoli che erano quindi d’impiccio per ottenere l’esonero. La famiglia poteva ancora offrire alla Patria. Niente da fare.
Scrisse poi a giugno, Lao. Scrisse per Cherubino Dragoni che chiedeva al Comune la cancellazione dal ruolo ‘pesi e misure’. Aveva ormai 72 anni e non poteva più fare il carbonaio, perché la sua forza scemava e soprattutto perché quella dei suoi figli gli era stata rubata dalla guerra: erano tutti al fronte. Uno di loro, Antonio, era morto meno di un anno prima.
S’era presentato alla Croce Bianca perché riteneva che il problema del suo lavoro fosse più legato alla guerra che all’età, e dato che ormai era lì, chiese a Lao di buttar giù anche un saluto ai suoi due ragazzi ancora in vita. Giusto la notizia che avrebbe smesso di andare su la macchia a far le còtte e che aspettava il loro ritorno, per vederli ricominciare.
Gli scrisse Lao una sorta di lettera circolare: testo uguale per entrambi, diverso solo il nome e la Brigata.
“Al Fante Dragoni Carlo 58° Reggimento Fanteria – Brigata Abruzzi – Zona Di Guerra: Figlio caro……”. Carlo l’avrebbe letta dopo aver partecipato alla 10a battaglia dell’Isonzo. La sua Brigata aveva lasciato sul campo di battaglia alle falde del Monte Santo e del Monte San Gabriele circa 2600 uomini; al momento si stava riorganizzando con un periodo di riposo a Valerisce, verso il fondovalle del versante opposto a Gorizia. La morte lo aspettava l’anno dopo.
“Al Fante Dragoni Filippo 82° Reggimento Fanteria – Brigata Torino – Zona di Guerra: Figlio caro…….”. Filippo invece l’avrebbe letta in un’altra zona del fronte, la Marmolada, dove i più arditi e più convinti della sua Brigata s’erano radunati in due battaglioni sotto il comando, altamente evocativo, del Colonnello Peppino Garibaldi, nipote del Generale, che li portò a conquistare, per qualche mese la Cima Costabella. Filippo non era tra questi. Restò, con la stragrande maggioranza della Brigata, a presidio della valle. La vita di trincea minò la sua salute. Sopravvisse alla fine della guerra. Riuscì a tornare a casa che si reggeva a stento, per morire quattro mesi dopo, nel marzo del 1919, ultimo dei tre figli che Cherubino Dragoni si vide sottratti dalla Patria.
Tanti erano i morti e quelli riempivano i cimiteri improvvisati della Zona di Guerra; tantissimi, da far perdere il conto, erano i feriti. Si dovettero aumentare i presìdi sanitari allestendo, ovunque fosse possibile, ospedali, ricoveri, cronicari, reperendo strutture adatte ad ospitare quell’umanità malconcia che il fronte quotidianamente produceva. Anche Esanatoglia volle partecipare e offrì la disponibilità dei 15 posti del Ricovero di Mendicità (lu Ricoveru) e i 30 posti dell’Ospedale Civile. Nel caso non fossero bastati, per estrema necessità il Sindaco volle anche ricordare che “a 100 metri di distanza dal capoluogo esiste anche un antico convento di Cappuccini con un ampio terreno interno chiuso da mura di cinta. In esso si potrebbero ricoverare circa 100 persone. È però di proprietà del seminario di Camerino che lo ha acquistato circa due mesi fa a scopo di villeggiatura”.
Nel frattempo la crisi economica ebbe come effetto, tra i tanti, anche la scarsità della benzina e il suo razionamento. Si fermò pertanto la corriera della SAEM (Società Automobilistica Esanatoglia – Matelica) di Alessandro Fiacchini, che con le sue tre corse al giorno assicurava il collegamento con Matelica. Se la rise invece Antonio Bottaccio, quando, per lo stesso servizio, furono costretti a richiamarlo per ripristinare la sua “vettura ippica” che era stata scalzata dal possente Omnibus Fiat targato 34-34 che, dismesso dalla ‘Perogio di Cingoli’, con un immane sforzo economico Fiacchini aveva appena comprato nel settembre dell’anno precedente.
E per dare un minimo di sollievo all’indigenza, e allo stesso tempo per contribuire allo sforzo per la patria, dai primi mesi dell’anno era stata avviata una lavorazione a domicilio di indumenti militari, guanti e ventriere di lana, che occuparono diverse donne del paese.
Sotto la guida di Teresa Censi, fiduciaria, la produzione venne poi estesa alle calze e vi furono coinvolte per diversi mesi una ottantina di donne.

Altre cancellature
Dopo Alberto Cesolari, morto il 23 maggio sul San Marco, ai primi di giugno cadde l’ennesimo fante contadino, Alessandro Bartoccetti, 35 anni. La Brigata Teramo, di cui faceva parte, era stata costituita a gennaio con l’obiettivo di conquistare il Monte Vodice che, solo in quel mese di maggio, avrebbe visto morire diecimila italiani e altrettanti austriaci. Aveva già affrontato a metà di maggio, con il 242° Reggimento di cui faceva parte, sette giorni di aspra lotta sotto l’imperversare delle mitragliatrici nemiche che dominavano dall’alto. Per lui, un sacramento d’uomo alto un metro e novanta, era anche difficile rannicchiarsi in quei ripari improvvisati e striminziti. Il 22 una pausa. Una settimana in Val Scrio per respirare, per riorganizzarsi. Fino a quel momento aveva perso 96 ufficiali e 222 uomini di truppa. Il 30 maggio di nuovo in prima linea sul Vodice, a difendere le posizioni conquistate. Sarebbero rimasti lì per una quarantina di giorni, perdendo mediamente una decina di uomini al giorno. Alessandro scomparve in un diluvio di fuoco il 3 di giugno. Disperso.
Il 26 di giugno la notizia non venne dal fronte, ma da un ospedale militare a Rieti. Aveva consumato lì i suoi ultimi giorni Ettore Pedica, 23 anni, contadino a Capriglia. Nel dicembre del 1914 prima che l’Italia scendesse in guerra, era di stanza a Faenza. Per l’inabilità del padre Nicola, che ironia della sorte gli sopravvisse fino al 1943 a 79 anni, ottenne di essere riconosciuto di 3° categoria e pertanto fu posto in congedo provvisorio. Fu però poi richiamato Il suo Reggimento di cui faceva parte, l’81° Fanteria della Brigata Torino, era in una zona del fronte tra le meno impegnative per quanto riguardava i combattimenti, ma disumane erano le condizioni di vita, tanto che si ammalò di una febbre tifoide che non gli diede scampo.

Nella zona del Vodice, a Zagora, era impegnata anche la Brigata Elba in cui militava Agostino Onesta, classe 1879, fante del 262° Reggimento Fanteria. In tempo di pace viveva con moglie e quattro figlioletti alle Case Rosse. Il 17 luglio, in una giornata non certo tra le più cruente, era impegnato nella zona della Selletta. A pochi chilometri da lì, due anni prima, aveva perso un nipote, Cataldo, figlio del fratello Antonio. Il bollettino di Cadorna raccontò di quel giorno che “l’artiglieria nemica batté specialmente le nostre linee in regione Zugna, sul Pasubio, sul Vodice e ad oriente di Gorizia.“

Uno dei colpi sul Vodice batté proprio sulla postazione di Agostino. Fecero appena in tempo a portarlo alla 73a Sezione Sanità dove morì. La notizia arrivò un mese dopo col telegramma del Comando che si diceva “fiero ed orgoglioso del nuovo tributo dato alla completa liberazione italica ad opera del soldato Onesta Agostino, il cui nome sarà di esempio e di fecondo ricordo nelle memorie del Reggimento.”. A novembre sarebbe poi arrivato al Comune un plico. L’oggetto riportava: “Denari e reliquie appartenenti al defunto militare Onesta Agostino”. La famiglia, di lui riebbe indietro “lire 84,80 dalla cui somma si è detratto l’importo della cartolina vaglia – Portafogli – Orologio di metallo con catena – Corrispondenza – Carte varie e due cambiali.”.
L’inutile strage, come l’aveva definita ad agosto Papa Benedetto XV nell’inascoltato appello “ai capi dei popoli belligeranti”, continuava.
Continuò, per quanto ci riguardava, con Venanzo Carsetti, classe 1898, anni diciannove e mesi sei, precisi. Contadino alla Ajalta. Combatté col 247° Reggimento Fanteria della Brigata Girgenti, sulle falde del Monte San Gabriele che si ergeva a sentinella dell’altipiano di Ternova, verso la conca di Gorizia. L’intera zona fu martellata per giorni e giorni dall’artiglieria che riempiva il cielo di nuvole rossastre e pesanti, come se la terra tutta si incendiasse. In quell’inferno veniva imposto agli uomini di lanciarsi in disperati assalti per raggiungere la linea di cresta. Occorrevano, come declamava una delle tante roboanti voci di mistica guerriera che guardavano la guerra da lontano, “uomini dai nervi d’acciaio, dai petti robusti, dall’energia tenace, e soprattutto, capaci del disprezzo assoluto della vita”, o forse qualcuno da dietro che ti spingesse a farlo in punta di fucile, come raccontarono poi le cronache postume? Non si seppe a che genere appartenesse Venanzo e cosa pensasse quando si lanciò all’assalto del 13 settembre, quello che pose fine alla sua breve vita, stroncata da esplosione di granata.
Ma c’erano anche molti che combattevano motivati, “capaci del disprezzo assoluto della vita”. Nell’estate di quell’anno era stata istituita una nuova formazione della Fanteria, gli Arditi, truppe scelte di assalto, che ebbero poi nel dopoguerra un ruolo importante nell’avvento del fascismo.
Vennero impiegati per gli attacchi, ma anche per puntate di singole ricognizioni e di sabotaggi alle linee nemiche. Azioni spesso disperate. Subirono gravi perdite e molti furono fatti prigionieri. Ci si arruolava per ardimento, ma anche a causa di pendenze con la giustizia militare che venivano così sanate. Convinti o disperati che fossero, tre esanatogliesi ne fecero parte. A riprova dell’estrema esposizione di quello speciale inquadramento militare, tutti e tre caddero prigionieri. Ermenegildo Rosini che fu prigioniero a Kassel in Germania; Bartolomeo Modesti che fu invece internato a Veszprem in Ungheria. Entrambi riuscirono a tornare.
Non tornò invece Angelo Cingolani, contadino di vent’anni, del 160° Fanteria – Brigata Milano, che nel campo di prigionia di Innsbruck, in territorio austriaco, morì di broncopolmonite il 14 febbraio del 1918 (ma si venne a sapere solo nel 1919). Era stato catturato, riportò la scarna biografia militare del suo foglio matricolare, il 27 ottobre 1917 “per il fatto d’arme di Castelmonte”; erano rischiose azioni di disturbo, attuate per rallentare l’avanzata del nemico e consentire il ripiegamento dei reparti di varie brigate che si stavano ritirando dopo Caporetto.
Fu partecipata in Comune, poiché esanatogliese di nascita, anche la morte di Luigi Bendia, classe 1897. Da qualche anno s’era trasferito a Matelica, mantenendo comunque amicizie e parentele nel suo paese d’origine. Era fante del 69° Reggimento Fanteria – Brigata Ancona. Si ammalò gravemente al fronte, tanto che il primo di aprile lo lasciarono tornare a casa per 6 mesi di convalescenza. Come se gli avessero stabilito il tempo che gli restava, perché morì allo scadere dei sei mesi, il 24 settembre.
Ben più scalpore fecero – perché anche le morti non sono tutte uguali – i caduti di ottobre.
Due famiglie, Buscalferri e Zampini, che fino a qualche anno prima e per più di un decennio, s’erano combattute, a suon di carte bollate, in quella che fu detta “guerra dell’acqua” per assicurarsi la risorsa dell’Esino da utilizzare per alimentare le rispettive industrie, furono in quel mese accomunate dallo stesso dolore.
Giulio Buscalferri, trent’anni, Tenente del 2° Reggimento Artiglieria da Campagna. Si era trasferito a Fabriano, ma la sua famiglia, ultima propaggine di una dinastia tra le più ragguardevoli del paese, era rimasta a Esanatoglia.

La parabola della sua vicenda militare, che sarà stata senz’altro lunga e articolata, si riassume in due episodi chiave, da cui due notazioni per una biografia succinta.
Nel maggio di quell’anno era stato decorato con la Medaglia di Bronzo al Valor Militare: “tenente reggimento artiglieria campagna. – Quale sotto-comandante di una batteria coadiuvò efficacemente il proprio comandante nello spostamento e nella successiva presa di posizione della batteria, sotto un violento fuoco nemico. – Carso 26-27 maggio 1917”.
Il 10 ottobre morì all’Ospedale da Campo n. 46 per “vasta ferita alla regione tempero-occipitale sinistra prodotta da scheggia di granata mentre trovavasi in detto giorno in servizio di collegamento con un Reggimento di Fanteria”. Vi fu poi una terza notazione: alla notizia fece seguito un ordine del giorno del Comando, in cui era dato “Caduto sul Campo d’Onore” e si esprimeva “l’affettuoso rimpianto di tutto il Reggimento”. Trovò sepoltura al cimitero vecchio di Aquileia.

Appena tre giorni dopo, il 13, la stessa sorte ebbe Umberto Zampini, Tenente di complemento della 2a Batteria, del 21° Reggimento Artiglieria da Campagna. Il più giovane dei figli di Sor Luigi Zampini, morì a 23 anni alla Sella Kradver per ferite multiple al torace forse causate da un proiettile Shrapnel, quelle micidiali granate che esplodevano a mezz’aria e diffondevano d’intorno una miriade di schegge metalliche e pallini di piombo. Fu sepolto a Lombai, in un improvvisato cimitero, nel Comune di Grimacco nella provincia di Udine. Sulle cime delle montagne della zona, passavano le linee arretrate dello schieramento difensivo approntato dalla 2ª Armata a protezione della pianura friulana in caso di ripiegamento delle linee combattenti.
Dietro a quelle cime, sotto la copertura assicurata da interminabili giornate piovose, e senza che il Comando italiano se ne avvedesse in alcun modo, si stava organizzando quell’immane movimento delle truppe austroungariche e tedesche, che sarebbe culminato, di lì a breve, nello sfondamento del fronte nella zona del villaggio di Kobarid, che per gli italiani si sarebbe tradotto in Caporetto.
Fecero rumore in paese quei caduti eccellenti.
Innanzitutto risaltò che anche nella morte si confermava quella che era l’appartenenza in vita. Nel senso che gli unici effetti personali che tornarono alle rispettive famiglie, furono i soldi, nient’altro.
Di Giulio Buscalferri tornarono ai suoi genitori settecentosessanta e rotte lire, e per il Tenente Zampini le lire furono quasi mille, la paga di cinque anni di guerra per un semplice fante. Un ufficiale prendeva non meno di 200 lire al mese, mentre un soldato ne aveva, “paga alla mano”, intorno a 15 lire. La vita di quei fanti valeva 50 centesimi al giorno.
Nel sentire comune, era evidente la differente considerazione: un conto era che a cadere fosse il fante ‘visciarellu’ Emilio Darrighi, un conto che fosse il più giovane dei figli di Sor Luigi Zampini della omonima ‘Premiata Conceria’. Un conto era morire da ‘fante contadino’ intento a zappare una trincea sul Carso come prima zappava la tèra jo ‘n Pajanu, altro conto era morire da Tenente, con una medaglia già appuntata al petto, mentre si coordinava in battaglia lo spostamento di intere batterie d’artiglieria. E questa percezione apparteneva anche a tanti di quelli che per condizione erano più vicini ai ‘fanti contadini’ e ai ‘visciarelli’ piuttosto che ai ‘figli dei signori’.
Lao, ne trasse invece spunto per un’amara e realistica riflessione circa la potenza livellatrice della morte – “la morte ‘ppara tuttu”, sosteneva – su cui costruì una delle sue squinternate filastrocche in versi ottonari. Cantilenata negli anni, venne affidata alla memoria collettiva che, in una delle tante versioni, più o meno così l’avrebbe conservata:
“è ‘na strage de ‘nnocenti / non c’è propiu paraenti, / sta gueraccia ‘mmazza tutti / sia li vélli che li vrutti, / li cristiani mòre fitti / sia signori che poeritti.”.
Sempre ad ottobre – che parve voler concentrare nell’arco dei suoi giorni tutte le vicende di militari di elevato censo, graduati e decorati – vi fu, nel corso dell’immane rovina che fu Caporetto, un terzo caduto eccellente.
Caporetto.
Quello che accadde ‘alla fronte Giulia’ tra il monte Rombon e l’Altipiano della Bainsizza, in quella notte tra il 24 e il 25 ottobre del 1917, gli italiani lo seppero solo più tardi e più tardi ancora lo capirono. Qualcosa si cominciò a intuire qualche giorno dopo, ma giusto l’indispensabile date le notizie scarne. Dai bollettini ufficiali non si capiva un accidente se non che il nemico aveva attaccato. La stampa sembrava esibirsi in giri di parole per annebbiare ancor più la situazione. Quando s’avventurava a cercare di fornire qualche spiegazione, scattava la censura sugli articoli e interi brani venivano cancellati. Qualcosa di più si cominciò a capire solo dopo qualche settimana, ma non del tutto.
Allentato il fronte orientale, la Germania poté trasferire parte delle sue truppe sul nostro fronte a irrobustire gli altrimenti non irresistibili austro-ungarici. Errori tattici, sottovalutazione, impreparazione, stanchezza, e via dicendo, fatto è che il nemico sfondò le linee tenute dalle truppe italiane e in breve dilagò fino al fiume Piave.
Chissà se si arriverà mai a stabilire la cause di quel disastro militare e umano che rappresentò la più grave sconfitta per l’esercito italiano, un’onta incancellabile. Sui perché di quella disfatta si sarebbe discusso per decenni, fornendo le più disparate spiegazioni. Comunque la si rigirasse, la vicenda coinvolgeva la sfera profonda dei sentimenti e del carattere nazionale, e perciò non si poteva pretendere che si arrivasse ad una interpretazione da tutti condivisa. Un paradigma dell’indole italiana.
Cosa fosse l’esercito in rotta, a fine mese si cominciò a leggerlo sui giornali, ma lo si capì ancor meglio, per quanto ci riguarda, quando sui muri del paese comparve il manifesto del Comando Supremo firmato “Noi Conte Cavaliere di Gran Croce LUIGI CADORNA Capo di Stato Maggiore del R. Esercito” con cui si ordinava ai militari “sbandati” di presentarsi alle autorità militari entro 5 giorni pena la “morte col mezzo della fucilazione nella schiena”. Uno degli ultimi atti di Cadorna prima che l’otto novembre venisse sollevato dall’incarico e sostituito dal Generale Diaz.
I numeri di Caporetto furono sconvolgenti. Gli italiani registrarono quasi 12.000 morti, 30.000 feriti, 300.000 prigionieri; oltre a questi c’erano 350.000 sbandati che vagabondavano senza meta o tornavano a casa
Più che le spiegazioni, le interpretazioni, che sono complesse e attengono allo studio della Storia – quella ‘maiuscola’ – seguiamo la ‘minuscola’ storia di Lao che, in quei giorni, cercò di star dietro ad una impennata della sua attività di scrivano.
Che fu quanto mai intensa, nonostante la posta militare “a causa dell’intensificato traffico ferroviario” fosse sospesa. Ma la corri- spondenza veniva inviata ugualmente e Lao rischiò di perdere il conto. La sede della Croce Bianca era trafficata quasi quanto gli uffici del Comune. Lì c’erano orari da rispettare e sempre un certo sussiego nel fornire informazioni, il rigore dell’ufficialità.
L’ufficio di Lao, rimase invece aperto anche di pomeriggio e di- sponibile verso ogni richiesta. Divenne più che mai un crocicchio di umanità varia, dove si incontravano e si mescolavano le singole vicende di un grande dramma collettivo che Lao a volte, con qual- che sua trovata, qualche lampo isolato, riusciva a volgere in com- media; anche se solo per qualche attimo era un beneficio per tutti.
Partirono decine di lettere e cartoline postali, verso quella ‘Zona di Guerra’ che non si capiva nemmeno se esistesse ancora.
Alla disfatta di Caporetto si legò, anzitutto, nella nostra con-ta delle perdite, il terzo caduto eccellente, Angelo Bartocci, 27 anni, Capitano del 10° Reggimento Artiglieria da Fortezza. Lao aveva sempre ricamato molto su di lui e soprattutto sulla velocità con cui, dalle sue tenute di Palazzo, piombava in paese con la sua Ferrera, la prima motocicletta – e l’unica per allora – che avesse solcato le strade locali. Lo ricordava impavido e ardimentoso, come appariva in sella a quel diavolo rombante, che esaltava la sua imponente stazza. Pare che così fosse anche in divisa, stando alle motivazioni per la medaglia d’argento al valor militare che aveva meritato nel primo anno di guerra: “Nonostante il fuoco aggiustato dell’artiglieria avversaria, che batteva il pontone sul quale egli si trovava coi suoi cannoni, conservava calma ammirevole e con serenità, continuava per ben tre ore consecutive a dirigere il tiro, riuscendo a far tacere la batteria nemica . – Basso Isonzo, 11 novembre 1915.”
Non si ebbero notizie precise della morte.

Fu inghiottito nella baraonda della ritirata dalle postazioni del Tolmino, scomparve nel nulla e di lui restò – sembra una costante degli abbienti – solo il denaro custodito in un libretto postale di risparmio che aveva affidato a un suo sottoposto. Fu proprio questi, il Tenente Amos Maretti a raccontare di aver lasciato il suo Capitano, nel pomeriggio del 28, nei pressi di Pavia d’Udine. Nel pandemonio della ritirata di Caporetto, il Capitano Bartocci salì su un camion dando appuntamento al suo Tenente a Udine o a Casarsa. “Alcuni soldati della Batteria – scrisse Maretti – asseriscono averlo visto nel pomeriggio stesso del 28 in Udine. Fu sempre in quei momenti calmo e mai accusò il minimo disturbo”. Da quel momento, più nulla.Solo l’atto di morte, e il libretto postale che il Tenente Maretti rese alla famiglia.
Il corpo, ritrovato in circostanze non chiare, sarebbe poi stato il primo dei pochi a tornare in paese, ma quasi sei anni dopo, il 7 giugno del 1923. La comunità lo avrebbe accolto con onoranze funebri eccezionali come fosse il simbolo di tutti gli esanatogliesi caduti.
Prigionieri che tornarono.
Nel suo elenco, Lao approntò la colonna “prigionieri” in cui confluivano anche quelli che dai comandi militari venivano indicati come “dispersi”. Quella dicitura, che era una specie di limbo, a volte rimaneva per diverso tempo, seppur non risultasse la presenza del disperso in nessun campo di prigionia. Avrebbe ricordato, anche a distanza di tanto tempo, i nomi di quelli che furono invece i redivivi, coloro cioè che furono inizialmente dati dispersi e, dopo pause di silenzio lunghe anche dei mesi, risultarono inter- nati in campi di prigionia da cui poi riuscirono a tornare.
Qualche nome tra i tanti, quelli che Lao ricordava, e quelli di cui si accenna in vari documenti:
– Cataldo Spitoni, Caporal Maggiore del 122° Fanteria, che fu prigioniero fin dal 1° novembre 1916;
– Angelo Quaresima del 161° Reggimento Fanteria “disperso in combattimento a quota 1050 il giorno 9 maggio 1917”;
– Luigi Lacchè, classe 1896, del 213° Fanteria e Palmerino Paoletti, classe 1892, 14° Fanteria, che furono rintracciati a Sigmundherberg, in Austria, dove i prigionieri erano oltre 180 mila, una città intera che funzionava da centro di smistamento per i diversi lager;

– Ferdinando Dolce, classe 1899, 87° Brigata Ionio, fatto prigioniero nella Battaglia del Solstizio sul Montello;
– Isidoro Bartocci, classe 1896, 8° Reggimento Alpini, che dopo la prigionia di un anno intero, fu anche prigioniero del suo stesso esercito per 8 giorni nel Campo di concentramento italiano di Castelfranco;
– Pacifico Procaccini, classe 1896, 213° Reggimento Fanteria Brigata Arno, prigioniero dal giugno del 1917 fino all’armistizio;
– Luigi Cilla classe 1889, 8° Reggimento Artiglieria da Fortezza, prigioniero per venti mesi in Baviera;
– Giovanni Liberati, classe 1887, 120° Reggimento Fanteria caduto prigioniero dei tedeschi sull’altopiano della Bainzizza il 28 ottobre 1917;
– Ercole Grasselli, classe 1895, del 27° Reggimento Fanteria “prigioniero delle truppe tedesche e liberato in seguito armistizio li 11.11.1918 – durante la prigionia rimasto ferito alle gambe da scheggia di bomba aerea”.
Uno dei campi più tristemente noti fu il lager boemo di Milowitz, a trenta chilometri da Praga, dove furono rinchiuse decine di migliaia di prigionieri di diversa nazionalità. In quella immensa distesa di baracche nere, fredde e buie, già in passato utilizzata per lo stesso scopo da Napoleone come poi lo sarebbe stata da Stalin, i prigionieri italiani agli inizi del 1918 sarebbero stati più di quindicimila.
In barba a tutte le convenzioni internazionali, le condizioni di vita dei prigionieri erano disumane. La fatica, la sporcizia, il freddo, la fame, alimentarono tubercolosi, enteriti, polmoniti, e soprattutto, edemi da denutrizione. Molti gli esanatogliesi che quell’inferno lo conobbero e che poterono raccontarne gli orrori. Tutti catturati nella rotta di Caporetto, tutti tornarono solo a fine guerra:
Luigi Bottaccio Caporale del 13° Autoreparto; Antonio Tozzi di Nicola del 90° Fanteria, classe 1895 Giovanni Gregori, Carabiniere, classe 1895; Alessandro Chiappa, classe 1897, Giuseppe Bottaccio, classe 1898, Brigata Milano ; Francesco Todini, classe 1896, 69° fanteria; Luigi Mariotti, classe 1884, 28° Artiglieria.
Se difficili erano i contatti con i militari al fronte, quasi impossibili furono quelli con i prigionieri.
Tante cose si seppero solo molto tempo dopo.
Si ignorava allora, ad esempio, che i prigionieri italiani morivano in misura nove volte superiore a quello dei prigionieri austroungarici in Italia. Al Governo e allo Stato Maggiore dell’esercito italiano non erano mai piaciuti quelli che cadevano prigionieri; su di loro aleggiava sempre il sospetto di codardìa, se non addirittura di essere disertori camuffati. Per i prigionieri del dopo Caporetto, la considerazione diminuì ancora.
I profughi.
A Caporetto, si lacerò l’Esercito Italiano e con esso un vasto territorio di paesi e città sulla linea del fronte e nelle prime retrovie, fino al corso del Piave che sarebbe diventato l’ultimo irrinunciabile baluardo. Brandelli di quella lacerazione, si dispersero un po’ ovunque e raggiunsero anche Esanatoglia.
Prima arrivarono le vèstie.
Lao serbò a lungo il ricordo che cominciavano già i primi freddi quando il paese, come non accadeva da anni, di colpo tornò a popolarsi. Prima arrivarono qualche decina di capi di bestiame bovino provenienti dalle zone occupate dagli austroungarici e vennero presi in affido da alcuni possidenti. Un gesto simbolico.
Dopo le bestie arrivarono li cristiani .
Più di 400 mila civili avevano lasciato le zone invase dopo Caporetto, ed erano fuggiti oltre il Piave, altri 250 mila civili erano fuggiti dalle retrovie prossime al fronte. Interi nuclei familiari a cui, per non cadere nelle mani del nemico, erano state concesse poche ore per raccogliere lo stretto indispensabile e abbandonare la loro terra. Scortati poi ai punti di raccolta di Udine e Palmanova, schedati disinfettati e vaccinati contro il colera e la dissenteria, erano stati infine trasferiti alle loro destinazioni.
Da noi arrivarono, dalla provincia di Udine, i Mocellini, i Venuti, i Facci, i Verdini-Geller. Famiglie numerose. Affrontarono quello sbandamento che li aveva sospinti qui da noi, a cinquecento chilometri di distanza, con inusuale dignità, nonostante si vedesse che pativano e che preferivano ridurre al minimo i contatti con la gente del posto. La loro presenza fu più che discreta, e durò non tanto da far maturare particolari legami. Furono comunque aiutati e nel sostenere la loro triste condizione, volle distinguersi Sor Luigi Zampini che per onorare la memoria di suo figlio Umberto, “caduto nelle infauste giornate dell’ottobre scorso”, concesse a loro beneficio un contributo di 600 lire.
Intanto il 9 novembre morì Angelo Bartolini, classe 1882, contadino a Campocujano. Sulle sue possenti spalle quattro figli, di cui l’ultimo nato durante la guerra nel 1916. Combatté nel 31° Reggimento Artiglieria da Campagna. Lasciò il fronte per aver contratto il tifo addominale, una delle malattie che falcidiarono le truppe, e fu portato a morire a San Giorgio delle Pertiche, nel padovano, nella villa che da dimora gentilizia dei Pugnalin-Valsecchi-Carnaroli era stata trasformata in Ospedale Territoriale della Croce Rossa.

Ragazzi, anche bambini.
Nel racconto generale che si fece poi della Guerra, furono individuati alcuni elementi che assursero a miti. Due di questi elementi, il ‘Monte Grappa’ e ‘i Ragazzi del ’99’ , appartengono alle vicende di Ilario Barbarossa e Sestilio Bartocci, entrambi del 264° Fanteria – Brigata Gaeta.
Dopo la disfatta di Caporetto, l’estrema linea di difesa s’era attestata sul Piave e il fulcro di quella linea era il massiccio del Monte Grappa. La caduta di quell’ultimo baluardo avrebbe consentito agli austroungarici di dilagare verso la sottostante pianura veneta. Per contrastare l’attacco, vennero schierati cinquanta battaglioni, stipati, in pochi chilometri quadrati, cinquantamila uomini, tra cui appunto tanti ragazzi dell’ultima leva.
Della classe 1899 era appunto Ilario Barbarossa, contadino a Pagliano. Era arrivato al fronte il 14 di ottobre. Morì in combattimento “in località Punta Brenta” il 25 novembre. Nel 1918 sarebbero arrivati alla famiglia i suoi effetti personali: “un notes con 11 francobolli, un orologio di metallo bianco e corrispondenza personale”. Tutto qui. Lao ricordò sempre d’aver provato un forte dolore a fare quella cancellatura, e a scrivere quel nome nell’elenco dei caduti. L’aveva scritto già “Barbarossa Ilario” qualche anno prima, in altri registri. Diversamente da tanti altri, il Foglio Matricolare di Ilario riportava: “Sa leggere..SI; Sa scrivere..SI”. Era stato, non per nulla, un alunno de lu Maestru Lao alla scuola di Pagliano.

Ancora più breve fu il tempo di Sestilio Bartocci, anch’egli del ‘99. Lui arrivò al fronte addirittura il 14 novembre. Ebbe due settimane e poco più per conoscere la guerra. Fu ferito in combattimento, e morì il 2 dicembre all’Ospedale da Campo 131 di Caoria di Canal San Bovo, nella provincia trentina.

Poco prima che loro morissero, l’encomio solenne di Diaz (“..i nostri giovani fratelli della Classe 1899 hanno mostrato d’es- sere degni del retaggio di gloria che su loro discende.”) aveva già dato inizio alla consacrazione di quella classe di leva.
La Battaglia difensiva del Grappa ridette fiato alle speranze. A fine anno il fronte si era ormai stabilizzato. L’offensiva nemica era stata bloccata. Gli austroungarici erano rimasti soli, poiché i tedeschi avevano spostato le loro armate sul fronte occidentale. Gli italiani invece furono affiancati, seppure in funzione di riserva, da più di duecentomila uomini tra francesi e inglesi. Non fu nemmeno un pessimo inverno e questo facilitò la riorganizzazione dell’esercito. Dal punto in cui si era sprofondati, si poteva soltanto risalire.
Si moriva per la guerra anche lontano dal fronte.
All’Ospedale Militare di Genova, era morto nel febbraio di quell’anno Giovanni Profili, sessant’anni, “Operaio della Ia Armata”.
Lavoravano invece in una industria d’armamenti, ‘in Zona di Guerra’, Giuseppe Zampini, 36 anni e suo figlio Narciso, appena quindicenne.
Il 25 settembre, Narciso Zampini, classe 1903, morì nell’esplosione di un deposito di polvere da sparo, e il padre fu gravemente ferito.
La morte, ovunque, ad ogni età.
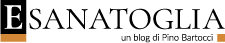










Veramente interessante. Quanti morti ci sono stati. Poveri ragazzi. Poi ora sono riuscita a sapere con certezza come e dove è morto Ettore Pedica fratello di mio nonno perché di voci ce ne sono tante ma di sicuro poco. Grazie per tutte queste informazioni. Sono racconti veramente interessanti.
Grazie. La foto di Ettore, con lo sguardo smarrito di quegli occhi sgranati, racconta bene dello smarrimento di quella generazione di “fanti contadini” che fu sopraffatta da quel macello.