Millenovecentosedici
Non sarà breve
Il fronte era lontano, ma la guerra cominciava a sentirsi dappertutto. Ogni atto della vita si compiva con il respiro grosso e il groppo in gola. Era difficile trovare qualcuno che non fosse in qualche modo coinvolto, dalle grandi alle piccole cose.
Poche le famiglie a cui la guerra non aveva preso qualcosa e che ad essa non avevano già corrisposto un qualche tributo umano, per lo meno un familiare in divisa o al lavoro nell’industria bellica. E i tributi erano destinati ad aumentare e a diventare sempre più gravosi.
Costantemente aumentava il peso di vivere e diminuiva tutto ciò che poteva rendere la vita un po’ più degna di essere vissuta e che per tanti era già merce rara prima di allora: il cibo, la salute, un briciolo di serenità.
Tanto per dire – perché Lao, così strampalato da ritenersi maschera vivente, pare ne restò turbato – fu cancellato il Carnevale. Guai a divertirsi. Il Prefetto aveva richiamato le autorità locali ad una particolare attenzione per regolamentare e tenere a freno le inopportune esuberanze che contrastavano con la tragicità del momento, e il 2 febbraio il Sindaco, con ordinanza vergata di suo pugno, tagliò corto e proibì “di comparire al pubblico con maschera, di mettere in mostra, come di consueto, costumi ed altri oggetti per mascherate” mettendo al bando “qualsiasi manifestazione carnevalesca”.
Il carnevale esanatogliese non era una manifestazione che poteva preoccupare in quanto a turbolenza: un po’ di balli, in teatro e in case private, qualche mattata in giro con maschere improvvisate, serenate e mattinate (queste sì, a briglia sciolta), un po’ di sana baldoria insomma, al massimo con qualche sbornia in più. Niente di eclatante. La proibizione quindi non era certo una gran cosa; anzi, vista la penuria e la tragicità dei tempi, appariva come la minore delle privazioni. Magari per il rispetto dovuto ai combattenti, sarebbe venuto anche spontaneo astenersi dagli eccessi. Ma quando ridere e divertirsi viene proibito per legge – si ritrovò a pensare Lao – è tutta un’altra cosa, molto più seria. Ebbe a temere che, passo su passo, sarebbero arrivati anche a proibire di raccontare i suoi pensieri strambi. Di farli, addirittura. Erano dettagli, che alla gente normale potevano sfuggire. A Lao, no.
E se quella era la guerra che si respirava qui da noi, estrema retrovia, che non sentivamo cannonate, che avevamo sì dei morti, ma senza aver visto mai una salma, un corpo restituito, era difficile immaginarsi la vita lassù dove la morte la faceva da padrona.
Ogni pensiero, ogni riflessione, sia di chi avversava la guerra sia di chi si infervorava per Trento e Trieste e tutte le terre irredente, finiva per rifugiarsi nella speranza di venirne fuori al più presto.
Perché si cominciò a capire che non sarebbe stata breve; cominciarono a scriverlo anche i giornali e diveniva voce sempre più diffusa che non sarebbe andata come era stato raccontato.
Già dalle storie dei soldati tornati in licenza a fine d’anno, s’era capito che la realtà vera non assomigliava per niente ai bollettini di Cadorna e che si sarebbe andati verso quella che veniva detta “guerra di posizione” perché le trincee, le gallerie, i cunicoli, che senza sosta si continuavano a scavare, stavano risucchiando tutti quegli uomini, le loro vite, insieme alla speranza di una fine imminente.
In quell’inizio di anno, l’attenzione e la preoccupazione furono subito deste dalla prima nòa cattìa che giunse dal fronte: riguardava Bonifacio Rosini, classe 1892, sarto e barbiere, che con altri compaesani della Brigata Macerata, era appena ripartito dopo la breve licenza natalizia. Il tempo di tornare per andare a morire, il 21 di gennaio, in una delle cinquanta brande dell’Ospedaletto numero 84, impiantato in fretta e furia nel paesino di Villesse, un grumo di case in quella lingua di terra goriziana dove le acque del Torre s’accostavano a quelle dell’Isonzo, prima della confluenza. La Brigata Macerata era impegnata da mesi, nella zona da Campolongo – San Martino del Carso, nella contesa di alcune trincee aggrovigliate in un intrigo di reticolati. Tra queste, quella che i fanti chiamavano ‘trincea dei morti’, che fu più d’una volta conquistata e poi persa. Persi, dall’inizio della guerra e fino a quel momento, anche un centinaio di ufficiali e quasi tremila militari di truppa, soltanto di quella Brigata.

Il 2 gennaio, dopo il periodo delle licenze, fu di nuovo in linea per una ventina di giorni di intensi scontri. Il 23 la Macerata tornò di nuovo nelle retrovie per un breve riposo e una profilassi antitifica. Ma Bonifacio non c’era. Era morto due giorni prima all’Ospedale da Campo per le ferite riportate in combattimento. Inutile dettaglio sapere se in uno dei tanti assalti o in una delle tante ritirate.
A febbraio, il 21, risultò disperso Rinaldo Tacconi, originario di Cerreto, ma da molti anni ormai contadino jo’ la Cima; 29 anni, sposato da tre anni appena con la sua Giulia che gli aveva sfornato uno dietro l’altro due maschi. Uno di quelli che, in licenza a fine d’anno, s’era concesso qualche scappata in paese lasciandosi andare ai racconti della vita di trincea. Raccontò dei primi giorni di guerra, quando con la Brigata Lombardia aveva attraversato lo Judrio e il tutto sembrava una marcia trionfale, fino a quando, dopo una decina di giorni, il passo fu bloccato da una barriera di siepi spinate e cavalli di Frisia, con l’artiglieria nemica che faceva fuoco dall’alto delle pendici del Monte Peuma. Tra i boschi di spina gaggia in cui cercarono riparo, vide scorrere il primo sangue dei suoi compagni. Cominciò la vita rintanata nei cunicoli delle trincee da cui si usciva per quegli assalti che definiva disperati. Raccontò, della conquista di Oslavia, i combattimenti corpo a corpo, le mazze ferrate, scene difficili da rendere a parole. Un inferno da cui, per il momento, lo aveva salvato la neve che aveva interrotto e reso impossibile qualsiasi azione militare. Non ebbe poi modo di raccontare il seguito, il ritorno a scavare trincee lungo il versante del basso Sabotino che non è come zappare la vigna. Primo, perché il piccone urta la viva roccia, poi perché dall’alto ti sparano come e quando vogliono. Nel giorno che gli fu fatale, sotto un tiro dell’artiglieria caddero in molti: 24 furono i morti e due i dispersi. Uno di questi due era Rinaldo. Disperso significava, nel suo caso, che non si trovarono manco i pezzi. Né del suo corpo, né del suo piccone.
La morsa della guerra stritolava la vita quotidiana.
Si peggiorava sempre più e peggio andava per chi già era male in arnese. L’elenco annuale dei poveri, caricati alla pubblica assistenza, era in continuo aggiornamento. Il numero in costante aumento.
Lao, tornato a vivere con l’anziano padre, era una presenza fissa in quell’elenco e riusciva a campare solo dei sussidi, sempre più scarsi e stentati, e di qualcosa d’altro, in natura, che riusciva a racimolare in giro.
Alle scarse risorse di cui disponeva il magro bilancio comunale, si cercava di supplire con lo sforzo delle Società di Mutuo Soccorso, che concedevano sussidi per malattia e collaboravano per la distribuzione del grano alla popolazione bisognosa. Ve n’erano due, quella maschile, con 90 soci e quella femminile, che ne contava 15; fu importante il loro contributo per affrontare quei momenti difficili molto più del solito e tristi. Quella femminile, in particolare, si mostrava nelle sue iniziative intraprendente e battagliera come solo le donne sapevano essere, ancor più dopo che la guerra aveva accollato loro nuove responsabilità, rendendole, anche loro malgrado, protagoniste nella vita sociale.
Le necessità stringenti smorzavano anche quei timidi segni di progresso che avevano iniziato a marcare la vita dell’anteguerra. In città e luoghi strategici si spegnevano le luci notturne per non offrire riferimenti ai bombardamenti aerei, da noi le sparute luci lungo le principali vie si abbassarono per risparmiare energia e ridurre il conto con la ditta Zampini che con le sue turbine ad acqua erogava il servizio alla comunità.
Rinsaldare lo spirito.
Vigeva il divieto per ogni tipo di manifestazione, fatte salve naturalmente le adunanze patriottiche necessarie ad ogni guerra.

Si mosse per prima la Chiesa, ad organizzarne una col sostegno di quanti, piegati alle ragioni della guerra “resa inevitabile” dai “vitali interessi della patria nostra”, vollero ricordare i caduti che, a loro detta, “sprezzando il pericolo, anelarono con fede italiana- mente pura alla immortalità”. Capitò a Lao di manifestare pubblica perplessità. Conosceva bene quasi tutti quei paesani morti e stentava a credere che avessero anelato a quella fine.
Ma così bisognava dire, e così disse il Sindaco Mollajoli, che non sapeva esimersi dalla prosopopea, ribadendo con enfasi questi concetti nella chiesa di San Martino stipata di gente. La presenza di alcune vedove e orfani accrebbe la sacralità della funzione. Il paese si stringeva intorno al loro dolore.
La Festa del 1° maggio, ovviamente, non fu invece consentita.

Ma la Camera del lavoro di Macerata e Provincia stampò per l’occasione un manifesto che ricordava i morti, auspicava la pace ed aspettava il “sol dell’avvenire”.
Scarni i capannelli a leggere e commentare com’era in uso allora: mancavano i socialisti, anch’essi erano al fronte.
E poi, da un po’ di tempo, bisognava stare attenti a come si parlava, a non esporsi alle accuse di disfattismo.
L’acme del sostegno patriottico fu raggiunto in occasione della ricorrenza più significativa, il 24 maggio, giusto un anno dacché l’Italia s’era gettata nel conflitto. Si volle cogliere l’occasione per compattare le schiere e rinsaldare lo spirito. Tanti di quelli che avevano a che fare con la guerra, direttamente o indirettamente, non avevano certamente un granché da celebrare. Si batté allora la grancassa dell’infanzia. Venne l’appello del Provveditore agli Studi che invitava a ricordare quella data citando le parole del Ministro Grippo che nella sua circolare rimarcava, con un periodare lungo, tutto d’un fiato, ad aumentare la speditezza del pensiero, che “….un luogo fra tutti appare in singolare modo propizio al ricordo delle gesta mirabili fin qui compiute ed è questo la scuola elementare ove si dà la prima incancellabile impronta alle co- scienze delle nuove generazioni e si educano i cuori a sentimenti di Amor patrio e di virtù civili”. Di conseguenza partì la lettera invito del Corpo Insegnante con cui veniva indetta una ‘Adunata’. Firmò e organizzò tutto il Maestro Tommaso Mosca, proveniente da Rieti, fresco di incarico e infervorato come pochi; accesissimo patriota, quasi folle d’impeto guerresco, ma forse per una sua congenita natura assai belluina, che lo avrebbe poi portato, una volta finita la guerra, a spegnere la sua esistenza peregrinando di manicomio in manicomio tra Marche e Lazio.
La cerimonia coinvolse frotte di bambini e ragazzi d’ogni età. Centocinquanta circa erano in quel momento gli esanatogliesi al fronte. Seppure in prevalenza giovani, avevano lasciato a casa ben 129 figli che, secondo la statistica richiesta dal Prefetto, il Comune così suddivise: 63 dai 3 ai 6 anni – 46 dai 6 ai 9 anni – 20 dai 9 ai 12 anni.
Per completare il numero della figliolanza rimasta senza padre, a questi andavano aggiunti i figli delle diverse decine di uomini impegnati in altre zone per lavorare nell’industria bellica.
Appena poco tempo prima, in 45 avevano chiesto di recarsi in zona di guerra: 32 erano braccianti, manovalanza pura, 3 i muratori, 4 i minatori, poi 3 fabbri e 3 falegnami.
Erano partiti per Macerata il 2 di aprile e, come stabilivano le direttive del Prefetto, si presentarono al Commissariato di Sicurezza “provvisti dei necessari indumenti, una coperta di lana e recipiente con cucchiaio per rancio”. Così si partiva.
Esonerati e non.
Nella tarda primavera di quell’anno, nel breve volgere di poco più di un mese, due arruolamenti, che qualcuno definì d’eccellenza, ebbero esiti con riflessi pesanti sulla vita locale e alimentarono discussioni e chiacchiere.
Giuseppe Oltolina, classe 1886, stabilitosi a Esanatoglia ormai da qualche anno, il 20 aprile fu chiamato a visita di leva. Risultò “abile arruolato” seppur di terza categoria. Il primo maggio avrebbe raggiunto il corpo a cui era stato assegnato. “O la guerra o la conceria”, pare che disse al Sindaco quando tornando dal Distretto Militare, gli fornì la distinta incolonnata dei 36 operai che avrebbero perso il lavoro se lui fosse partito per il fronte.


Il Sindaco, per scongiurare quel rischio, si attivò prontamente e scrisse alla Commissione per gli Esoneri, ponendo tutti i suoi massimi uffici, tutta la sua autorità, soprattutto calcando sulle ripercussioni per la collettività. L’azione tempestiva e insistita diede i suoi frutti.
Oltre al diretto interessato, furono in molti a trarre un sospiro di sollievo alla notizia dell’accoglimento dell’esonero, in particolare i suoi pellari. Sor Giusè, come lo chiamavano quelli che ostentavano una certa intimità, evitò il fronte e poté continuare la propria attività. Ma non furono pochi quelli che vi trovarono conferma a certe pessimistiche idee, da sempre circolanti, riguardo alla giustizia applicata ai potenti. Ripresero a circolare quei consueti commenti su “li sòrdi che manna l’acqua per in sù….”.
Quasi contemporaneamente toccò a Erso Zampini, anch’egli ‘abile arruolato’, e per di più di prima categoria. Diverso, rispetto al concorrente, l’esito della sua vicenda. Intanto Erso, che era anche Consigliere Comunale, partì a metà maggio e fu assegnato alla Terza Compagnia Automobilisti, essendo all’epoca ancora assai rari gli abilitati a condurre autovetture.
Era stato arruolato ed era già al fronte anche l’altro fratello, Umberto. Sor Luigi Zampini era così rimasto senza figli. Con la partenza di Erso, rimase innanzitutto senza titolare della Farmacia Comunale di cui era concessionario. Per questa mancanza ottenne dal Prefetto una deroga che stabilì sufficiente la presenza dell’assistente Antonio Mollajoli “per tutto il tempo che il titolare Erso Zampini resterà sotto le armi”. Ma oltre a questo, senza Erso rimase anche privo di ‘Direttore Tecnico’ della Premiata Manifattura Pellami Zampini Francesco. Per questa mancanza invece, senza chiedere alcunché, Sor Luigi fermò la produzione e chiuse lo stabilimento. Erso era ormai l’anima della Conceria, che di operai, al momento, ne aveva un centinaio, e che senza di lui – così aveva stabilito il padre – non poteva che fermarsi.
Fu lo sconcerto generale. A Lao sarebbe mancata la lettura di giornali e riviste, a un centinaio di famiglie sarebbe mancato il pane.
All’inizio sembrava fosse solo questione di qualche giorno, ma quando poi fu chiaro che la chiusura sarebbe stata lunga, gli operai si mossero e il paese fu in subbuglio.
Il 7 giugno i pellari riempirono la piazza del Comune, e il Sindaco, che li ricevette sotto le logge, da subito si adoperò con telegrammi e lettere a fare pressioni sulla Prefettura la quale rigirò la palla al Ministero.

In attesa della risposta da Roma, saliva intanto l’agitazione e gli operai decisero di radunarsi alla Croce Bianca, in quello che ormai era l’ufficio di Lao, la sua trincea, che da ufficio di guerra, s’apprestava a cimentarsi anche come una sorta di ufficio di Mutua Assistenza. Il giorno dopo, il Comune ricevette la petizione, diligentemente compitata da Lao che sparse voce d’aver faticato non poco a convertire in un discorso piano che filasse, quanto era emerso da quella assemblea rumorosa e disperata. S’aspettavano, i pellari, che il Ministero rimandasse a casa Erso Zampini e, in attesa, chiedevano lavoro.
Non ebbero, almeno in un primo tempo, né una cosa né l’altra. La risposta del Ministero della Guerra fu negativa: il Sergente Automobilista Erso Zampini, essendo ormai già incorporato, anche se avesse avuto diritto alla dispensa, a quel punto non avrebbe più potuto goderne.Per il lavoro, invece, il Comune poteva solo metterli in lista per mandarli a lavorare in Zona di Guerra.
Niente di più.

Si cercò di arginare la disperazione dei conciapelli disoccupati distribuendo alle loro famiglie grano del Monte Frumentario, quattro chili a persona.
La crisi si prolungò costringendo il Comune a insistere e a scrivere anche alla Commissione Centrale per le Esonerazioni Temporanee a Roma per tentare ancora una soluzione.Ma non ebbe esito.
Erso avrebbe proseguito la sua vita militare fino alla fine della guerra. Sor Luigi, dopo qualche mese ritornò, almeno parzialmente, sui suoi passi. La Conceria riaprì i battenti, anche se con una riduzio- ne di personale; nel frattempo, qualcuno era partito per il fronte, e qualche altro se n’era andato a lavorare in zona di guerra.
La guerra, intanto.
Mentre teneva banco la vicenda dei pellari, al fronte si registravano altre perdite.
Due morti nei primi sei mesi, poi, da giugno a ottobre, uno o due morti al mese.
A metà maggio, cadde Ansovino (Federico) Gregori, figlio di Luigi, lo stradino comunale. Ciclista Bersagliere dell’Undicesimo Reggimento, Seconda Compagnia. Ventinove anni, muratore, fisico gagliardo. Il Reggimento, che era in trincea a Vermegliano, il 15 “fu fatto accorrere a Monfalcone” a supporto dei Cavalleggeri per la riconquista di quota 93 appena persa.

Le biciclette Bianchi armate di moschetto lanciate a sostegno del 1° Reggimento Nizza Cavalleria. Appena una trentina di chilometri più avanti c’era Trieste, la mèta. Si pedalava sotto una pioggia di granate. Nel dettaglio, il referto ricordò impietosamente che fu colpito alla testa poiché morì per “fuoriuscita di sostanza cerebrale”. Di quel superbo figlio, alla famiglia furono riconsegnati: “un libretto personale, un portasigarette, un orologio con catenina, una tessera di riconoscimento, uno specchietto, un taccuino con- tenente cartoline, cartoline e francobollo da 10 centesimi, un paio di occhiali, un fazzoletto”.

Nella notte tra il 14 e il 15 maggio gli austroungarici, con un fuoco d’artiglieria mai visto prima, sferrarono sul fronte trentino quella che per loro fu “l’offensiva di primavera” (‘Frühjahrsoffensive’) e che da parte italiana fu invece tradotta – e soprattutto vissuta e subìta – come “la spedizione punitiva” (‘Strafexpedition’).
Puniti, ci volevano, non solo in quanto nemici, ma in quanto ex-alleati e “traditori” della Triplice Alleanza.
Le cronache di guerra dei giornali (per non parlare dei bollettini di Cadorna) calcarono sull’eroica resistenza dei nostri, sugli attacchi respinti, e sulle notevoli perdite del nemico. Difficile immaginare che dietro al “ripiegamento in perfetto ordine fuori della pressione del nemico tra Astice e Brenta e in Val Sugana”, ci fosse in realtà una nostra ritirata di qualche decina di chilometri, fatta in fretta e in furia e col pànico per aver capito cosa potesse significare il rischio d’essere invasi.
Vennero spostate ingenti forze dal fronte veneto, ordinata la mobilitazione delle ultime leve e fatti affluire uomini da tutta Italia. Una difesa massiccia che, grazie anche alle complesse manovre su altri fronti, ebbe efficacia e l’offensiva si arrestò a metà giugno, quando gli austriaci si attestarono sulla nuova linea del fronte. Ma gli eserciti continuarono a fronteggiarsi in uno stillicidio di scontri. I risultati, dal punto di vista militare, furono scarsi. Invece i morti, nei due schieramenti, furono oltre duecentotrentamila.
Tra gli esanatogliesi:
Luigi Antonio Buldrini, Tenente dell’80° Fanteria, Brigata Roma, classe 1886. Un figlio di due anni, Sestilio. In prima linea sulla fronte del Torrente Lena di Vallarsa, sotto al Pasubio, nelle zone dove neanche un mese dopo sarebbero stati catturati Cesare Battisti e Fabio Filzi. Nei giorni dal 9 al 12 giugno, l’operazione costò al suo Reggimento la perdita di 17 ufficiali e 848 uomini di truppa fra morti e feriti. Sotto una pioggia infinita, Luigi fu tra i dispersi, il 10 giugno;
Attilio Perelli, 84° Reggimento Fanteria – Brigata Venezia. Quando si allentò la pressione della Strafexpedition, l’esercito riprese alcune delle posizioni perse. Trovò ciò che Cadorna nel bollettino definì “prove numerose della innata barbarie nemica”, ma altro non era che il frutto della guerra: Arsiero e Asiago distrutte e incendiate; sul monte Magnaboschi furono rinvenuti “in pozzanghere un centinaio di cadaveri di nostri soldati denudati”.

Sull’Altipiano di Asiago, in uno dei tanti feroci scontri, Attilio, conciapelli, classe 1896, risultò disperso il 27 giugno;
Pacifico Bartocci, il più anziano tra i caduti, 49 anni, contadino in una colonìa a cavallo con Matelica. La Brigata Ravenna, di cui era fante nel 38° Reggimento, dal 30 giugno era impegnata sull’Altipiano dei Sette Comuni in una lotta che si svolgeva con lanci di bombe a mano e violenti corpo a corpo. In quattro giorni di continui assalti, sarebbero arrivati, inerpicandosi di roccia in roccia, a un passo dalla cima del Selug- gio. La vita di Pacifico Bartocci si fermò lungo quella risalita, il 2 luglio, sulle pendici meridionali del monte.

In altra zona, sul fronte isontino, in quella che fu poi numerata come la Sesta delle battaglie, era impegnato Antonio Dragoni, col 57° Reggimento – Brigata Abruzzi – che aveva il compito di sfondare le difese nemiche ad est di Oslavia e procedere quindi verso l’Isonzo. Con deciso slancio i reparti mossero dalle trincee il primo giorno, il 6 agosto, riuscendo a conquistare il costone di Oslavia e catturando un centinaio di prigionieri, ma non poterono procedere oltre per il tiro di sbarramento di mitragliatrici nemiche.
Il bollettino militare parlò di “sensibili perdite”, che tradotto, significò che in quattro giorni fu una carneficina: più di mille tra morti e dispersi, un migliaio anche i feriti. A cadere, tra i primi, fu anche Antonio, 31 anni, carbonaio, figlio di Cherubino.
Aveva già conosciuto la dura vita dell’emigrante, Severino Nucci, contadino, classe 1890, originario di San Severino. Era partito da ragazzo con la sua famiglia per il Brasile ed era tornato, a vent’anni appena, con moglie e figli; dai campi di Jahù nel cuore dello stato di San Paolo per una colonìa sotto Pagliano.

Con la Brigata Macerata, 121° Reggimento era a Case Bonetti, sul Carso, alle spalle del lago di Doberdò, lungo la strada del vallone che collega Gorizia a Monfalcone, che allo scoppio della guerra era diventato retrovia dell’esercito austro-ungarico, deposito di merci e materiale bellico, e truppe di riserva. Dopo la sesta battaglia dell’Isonzo e la conquista di Gorizia venne abbandonato dagli imperiali che si ritirarono sulle colline intorno da cui ingaggiarono una strenua difesa. Il 16 settembre Severino risultò tra i dispersi. Lasciò tre figli e la moglie incinta. Maria, ricordo dell’ultima licenza di fine 1915, nacque due settimane dopo la scomparsa del padre, già orfana.
Verso la fine di settembre, la madre di Francesco Barbarossa, la prima vittima esanatogliese del conflitto si presentò a Lao per scrivere all’altro figlio Giuseppe che, dopo la presa del Sabotino stava facendo un periodo di riposo. Non risultò che Giuseppe l’abbia mai ricevuta perché la Brigata Toscana il 27 settembre si trasferì sui luoghi dell’ennesima battaglia dell’Isonzo, la ottava, che si svolse sul Carso nella zona di Doberdò.
Dal 9 al 12 ottobre si ebbero non meno di quarantamila morti tra gli austriaci e venticinquemila tra gli italiani. Tra questi ci fu anche Giuseppe Barbarossa, contadino, classe 1894, che risultò disperso proprio l’ultimo giorno dei combattimenti “nel fatto d’armi del Veliki-Hribak”.
Lao, come tanti, ricordò bene la dichiarazione di irreperibilità di Giuseppe, perché arrivò per telefono. Il nuovo servizio si inaugurò proprio con quella comunicazione della Prefettura. Nella tragica coincidenza, chi aveva lo sguardo vòlto al passato, intravide riscontro alle proprie diffidenti idee: il progresso portava solo sciagure.
A settembre partirono i giovani del 1897. Erano in 24, e 5 di questi non sarebbero mai più tornati.
La diserzione.
Quel periodo fu turbato, tra l’altro, anche da una vicenda assai particolare.
I fatti erano accaduti l’anno prima, ma se ne venne a conoscenza solo in quell’ottobre, quando al Sindaco arrivò la comunicazione, ovvero la sentenza. Bastarono appena poche ore perché la notizia, per vie traverse, raggiungesse il Gabinetto di Lettura. Fu in breve di pubblico dominio; fece discutere e divise.
Riguardava un tal Giovanni Cofani, che solo pochi in paese ricordavano e ancora di meno potevano dire d’aver conosciuto. Di padre fabrianese, fu invece esanatogliese dalla nascita fino ai sette anni d’età, quando, dopo la morte della madre, seguì suo padre in Germania. Fu tra i rimpatriati a forza per lo scoppio della guerra, ma non transitò neppure a Esanatoglia, dove non aveva più domicilio. Si ritrovò a servire una patria che forse non sentiva sua. Ventunenne fu arruolato nel 2° Reggimento Fanteria – Brigata Re.
La sua Brigata era impegnata al Fortino del Podgora, al Grafemberg, e ogni giorno, per i continui sanguinosi scontri, mancavano all’appello 10, 20, 30 uomini. Uno stillicidio. Nella notte tra il 23 e il 24 novembre 1915, approfittando d’una nuvolaglia che oscurava la luna ancora quasi piena, dalle trincee nel Vallone sottostante il Fortino, un’ombra sgattaiolò, procedendo in direzione delle postazioni nemiche e scomparve nel buio. Pare che, almeno ufficialmente, nessuno se ne accorse. Si capì solo quando nelle tenebre risuonò l’eco di un concitato dialogo in tedesco. All’appel-o, nella trincea italiana, mancò il fante Cofani. In un angolo della sua postazione, era rimasto il moschetto e il suo equipaggiamento.
Il 2 ottobre 1916 il Tribunale Militare del VI° Corpo d’Armata lo ritenne “colpevole di diserzione qualificata da passaggio al nemico” e lo condannò, in contumacia, “alla pena di morte col mezzo della fucilazione nella schiena previa degradazione”.

Non si conobbe poi la sorte di Giovanni Cofani, se ebbe un futuro e quale.
Lao ricordò violente discussioni tra chi riteneva quel reato il più turpe, e chi tendeva a trovare una giustificazione, una scusante, ché anche un disertore era vittima del meccanismo infernale della guerra.
I primi ricordavano il coraggio e l’eroismo di quanti ave-vano anteposto il valore della patria a quello della propria sopravvivenza, i secondi parlavano della paura, dello smarrimento, della disperazione che potevano indurre a quella scelta, ma c’era anche chi, avverso alla guerra, parlava della diserzione come una giusta ribellione alle ingiustizie di quella carneficina. E ricordavano, alcuni altri ancora, che diversi erano i modi di disertare, anche imboscarsi lo era, e spesso proprio gli imboscati erano quelli che con più vigore sventolavano la bandiera del patriottismo. E giù che partivano aspre discussioni dove riemergevano mai sopite divisioni.
Il fronte esanatogliese.
Nel novembre del 1916 la neve cominciò a cadere sul fronte alpino e l’inverno che seguì fu uno dei più rigidi a memoria d’uomo. Pose fine ai combattimenti sul medio e alto Isonzo dove i versanti delle montagne furono sommersi dalla neve, che fu, si disse, tre volte la media consueta. Solo durante la seconda metà di dicembre ne cadde una coltre di più di 5 metri.
Di quell’inverno Lao avrebbe poi ricordato un altro elenco oltre a quelli ormai consueti, dei morti in guerra, che con dolorosa diligenza aggiornava, e dei poveri, in cui ormai gli era garantito un posto fisso, insieme a un’altra cinquantina di persone. Era l’elenco dei riformati, dalla classe 1876 a quella del 1896, che fu affisso all’Albo Pretorio: praticamente la lista di quelli che per la guerra proprio non potevano servire. Non erano rimasti in tanti, appena una decina. Ma si cercò di attingere anche lì.
Lui era al primo posto e fu chiamato a visita l’ultimo giorno dell’anno. Fosse stato un po’ di tempo prima, forse avrebbe provato ad esorbitare sulle sue capacità e minimizzare sui suoi vistosi limiti, ma avvertì la serietà del momento e si lasciò andare, mostrandosi al naturale e evitando ogni sproloquio.
Fu confermato l’esonero. Non poteva essere altrimenti. Si raccontò del suo evidente dispiacere. La sua guerra avrebbe dovuto continuare a combatterla altrove. Il fronte non poteva che essere al paese, nel Gabinetto di Lettura della Croce Bianca.

Fortuna che l’inverno abbondò di neve anche da noi, tanto che Esanatoglia, a guardarla bene, poteva somigliare a uno di quei villaggi al fronte, su in Trentino.
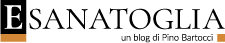










Interessante come sempre. Grazie Pino.