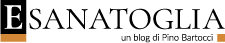Millenovecentoquindici
Guerra sì, guerra no.
Quell’anno, il 1915, la cui cifra sarebbe stata poi impressa in una miriade di bronzi commemorativi, incisa su innumerevoli lapidi, e quindi scolpita nel ricordo vivo di milioni di italiani, tanto per cominciare si annunciò con uno spaventoso terremoto. La mattina del 13 gennaio, poco prima delle otto, una scossa di undici gradi Mercalli devastò una zona degli Abruzzi, la Marsica, radendo al suolo l’intera cittadina di Avezzano. Trentamila morti sotto le macerie. Fece vittime anche nel Lazio e si avvertì un po’ in tutta la penisola, riportando alla mente quello spropositato del 1908 di Messina. Riemersero, nelle nostre terre ballerine, le consuete paure. Seppure la percezione del disastro risultasse qualcosa di lontano, fu comunque motivo d’angoscia, e l’orizzonte, già denso di nuvoloni a cataste, si fece ancora più oscuro. Mosse da sincera pietà e da senso di vicinanza, ma anche sollecitate dalle autorità centrali che tendevano a utilizzare anche queste occasioni per instillare quel senso di unità e di coesione di cui difettava la ancora giovane e sfilacciata nazione, vennero un po’ ovunque organizzate iniziative di solidarietà con la raccolta di fondi per l’assistenza alle popolazioni colpite. Esanatoglia raccolse in tutto 195 lire. Cinquanta furono del Comune, proprio come era stato sette anni prima col sisma di Sicilia e Calabria; il resto venne dalle due concerie, maestranze e dirigenza della Conceria Zampini (che da sola ne offrì 110) e di quella Giordani; la partecipazione emotiva fu tanta, magari anche sincera, ma i tempi erano grami.
Proprio in quel periodo, una vedova con quattro figlioli a carico, nella sua richiesta di un sussidio al Sindaco, sintetizzava quello che per lei era “il tragico andamento della vita” di quel periodo, parlando – per sé, ma poteva anche inquadrare l’epoca – di “questi famosi momenti di questo strano secolo”.
Lao, che del tragico andamento della vita si riteneva l’emblema vivente e, di fatto, tanto strano quanto il secolo che stava vivendo, povero in canna e di famiglia iscritta a ruolo tra le tante che riempivano l’elenco comunale dei miserabili assistiti, non potendo privarsi manco di pochi centesimi, partecipò a suo modo al moto solidale per i disastrati del sisma. In molti ebbero poi a ricordare che, anche in tale occasione, egli fece da megafono e per quanti conosceva o incontrava, per strada o all’osteria o ovunque si trovasse, fu voce narrante della sciagura. Rubava spezzoni di cronaca ai giornali, fissava nella mente qualche foto che campeggiava nelle prime pagine e rielaborava raccontando tutto alla sua maniera. Così, per tanti che non avevano altro modo di informarsi ma ebbero la ventura di incrociarlo, il racconto delle cronache del disastro fu opera di Lao che non si lasciava certo pregare per sciorinare dettagli talmente catastrofici da apparire del tutto astrusi.
Ma la realtà, anche in quel caso, superava di gran lunga la più fervida fantasia e andava oltre le fantasticherie di cui lui era capace. Hai voglia, pensava in questi casi Lao, a scatenare la forza dell’esagerazione quando il padreterno poi, con un subbitu, riesce a superare ogni limite.
Era una bella gara a chi era più sprocedatu.
Durò comunque ben poco questa diversione, poiché ben altre scosse incombevano su quella tragica età e sugli uomini che la vivevano. Le prime pagine dei giornali, dopo neanche una settimana, passata giusto la visita del Re sui luoghi del disastro, tornarono a parlare soprattutto di guerra, e Lao, che quotidianamente scartabellava tutta la stampa che la concia di Sor Luigi gli metteva a disposizione, tornò a dedicarsi esclusivamente alle battaglie che insanguinavano l’Europa, e non solo.
Che la situazione generale fosse di estremo rischio, cominciavano a intuirlo in tanti. Bastava essere un minimo informati, o anche solo essere improntati a un minimo realismo. Ne furono ancora più consapevoli, quella trentina, o poco più, di esanatogliesi che il pomeriggio del 31 gennaio, nonostante il freddo pungente, si recarono in teatro ad ascoltare una pubblica conferenza su “Il pensiero anarchico nell’ora presente”. E cosa pensassero in quel frangente gli anarchici lo illustrò, con la prosa chiara ma veemente che lo distingueva, il libertario toscano Umberto Mincigrucci. Spitó, costante punto di riferimento degli spiriti liberi locali, si premurò di presentarlo come reduce dal ‘Convegno Nazionale Anarchico contro la guerra’ che s’era tenuto a Pisa la settimana prima e pertanto invitò i presenti, con le maniere ruvide e spicce di cui era capace, ad aprire bene le orecchie e il cuore.

A sentirli, gli anarchici, sembravano proprio duri. Loro erano – Lao ricordò che disse così Mincigrucci – per “fare guerra alla guerra”, e criticavano i socialisti che in Europa andavano schierandosi ormai per l’intervento, ciascuno sotto la propria bandiera nazionale, ché si sarebbero sparati tra compagni, con buona pace dell’internazionalismo.
Come fu in ogni angolo d’Italia, anche da noi si cominciò a discutere sulla guerra e s’accese il dibattito tra i pro e i contro.
Apparve singolare che tra i favorevoli vi fossero ragioni del tutto opposte.
Erano a favore, per esempio, coloro che non vedevano di buon occhio quella crescente minaccia rappresentata da “tanta marmaglia” che pretendeva sempre di più, si organizzava, parlava di diritti, di socialismo, di rivoluzione e minacciava così il quieto vivere; costoro speravano che la guerra potesse ristabilire l’ordine giusto delle cose, il principio di autorità, un freno a quelle pretese distruttive dell’ordine costituito.
Ma erano a favore anche tanti di quelli che proprio tale ordine intendevano sovvertire, perché la guerra appariva come lo strumento per scardinare i vecchi equilibri che avrebbe permesso l’affermarsi di forze nuove e la liquidazione del vecchio e infame mondo. Ritenevano sarebbe stato l’innesco della rivoluzione tanto attesa.
Contro erano in tanti, pacifici e pacifisti, a seconda che prevalesse il carattere o l’ideale, ed erano sicuramente maggioranza.
Insomma, chi aveva qualche idea politica, sociale, culturale, e lanciava lo sguardo un palmo oltre il suo naso, aveva una sua idea della guerra, pro o contro che fosse.
Chi non viveva di idee, o magari ne aveva ma di brevissima gittata, era estraneo al discorso – come fu in larghissima parte nel mondo contadino – e non era certo a favore della guerra.
Lao, per quanto raccontò poi di sé stesso, ondeggiava tra neutralismo e interventismo; amava la pace, ma se avesse dovuto rispondere alla chiamata della patria, lo avrebbe fatto senza indugio, per non sentirsi escluso.
Ma si sentiva intimamente combattuto, anche perché prefigurava una ecatombe, fatta di numeri spropositati, morti e distruzioni a iosa, scenari apocalittici tipici del suo stile, ai quali, come per esorcizzarlo, gli veniva solitamente opposto un “ma che dici… ma valà…!”, che a lui rivolto diventava “fugghjiaaaa Lao… !!”.
Le ultime voci contro
Giorno dopo giorno, in tutti, anche nei meno attenti, i meno partecipi, la cui vita era già da sempre dura quanto poteva esserlo una guerra, aumentava la consapevolezza, o comunque la sensazione, più o meno vaga, che si stava procedendo inesorabilmente verso un qualcosa di oscuro, un buco nero, un vuoto. Per alcuni era attrazione, per tanti altri un incubo, per altri ancora, forse la maggior parte, una inevitabile fatalità da cui non ci si poteva tirare indietro. Che il vuoto sarebbe stato poi un abisso, solo pochi furono capaci di avvertirlo. La grande maggioranza degli italiani era per restare fuori dal conflitto europeo; era noto, e lo sapeva anche il governo Salandra che aveva tastato il polso della gente attraverso un’inchiesta commissionata alle Prefetture.
Ma era fievole la voce dei neutralisti. Il fronte socialista si era incrinato dopo che Benito Mussolini, uno dei suoi massimi esponenti, tra i più avversi alla guerra, quello che aveva tuonato “né un uomo né un soldo alla guerra!”, nel volgere di poco tempo aveva cambiato completamente le sue parole d’ordine e invocava ormai, seppur ancora – come egli sosteneva – nel nome del socialismo rivoluzionario, “a voce spiegata, senza infingimenti, con sicura fede, oggi: una parola paurosa e falciatrice: guerra!”.
Ma quelli che la guerra non la volevano, vollero invece, fino alla fine, anche nei luoghi meno esposti come il nostro, far sentire la loro voce, anche se tanto flebile ormai da non riuscire più a coprire le urla di chi invece la invocava. Da noi, i contrari, i ‘neutralisti’, socialisti e anarchici in testa, decisero di organizzare, per la prima volta, un Primo Maggio insieme, per unire le voci e farne una sola, più grossa. Il momento imponeva di battersi contro l’isolamento che aumentava sempre più. Per molto tempo, quella sarebbe stata l’ultima Festa del Lavoro.

Quattro lunghi anni sarebbero passati prima di rivedere il drappo rosso (quell’anno fu però anche verde e nero) in cima a ‘lu magghju’, il pioppo piantato, come ormai si usava da un decennio, al centro della piazzetta di Santa Maria, dove tanti anni prima, agli inizi del secolo scorso all’epoca dei napoleonici, si raccontava venisse issato l’Albero della Libertà della Rivoluzione Francese.
Quattro anni per tornare a sentire inni e canti, scanditi a passo di marcia, che accompagnavano il corteo a qualche pratozza lungo l’Esino o verso Sant’Angelo per la ‘gita campestre’ che culminava con una solenne smerennata. Quattro anni prima di rivedere uno di quei cortei tornare in paese, con passo più incerto e scombinato per la stanchezza e il vino, e disporsi ad ascoltare, come era prassi, comizio e concerto. Lao, che pur non essendo un sovversivo, era attratto da tutto – e in particolare da ciò che era mosso dal pensiero, salvo poi ripensarlo a modo suo – fu partecipe di quel primo maggio, ma non fu del corteo, poiché avrebbe stentato a mantenere il passo. Rimase in paese ad attenderne il ritorno e non si perse le ripetute sortite della Fanfara che, lungo l’arco della giornata, inondò di musica le vie del centro con ripetuti servizi destinati a tener desta l’attenzione.

Nel frattempo passava e ripassava i vari manifesti di cui il paese era inusualmente tappezzato. Grandi e di colori accesi, tutti avversi alla guerra. Spiccavano quelli della Direzione del Partito Socialista Italiano e della Camera del Lavoro di Macerata.

Lao si concentrò sul alcuni passi cercando di tenere a mente qualche frase che potesse tornargli utile nelle sue esternazioni.
”La borghesia coi suoi furori di conquista e di cupidigia ….. una guerra delle più fiere e tremende che la storia ricordi. …. Milioni di nostri compagni travolti nello immane conflitto si scannano senza pietà;…. milioni di ricchezze, accumulate con secoli di paziente lavoro, vengono distrutti dalla furia sanguinaria. ….. E per la bufera corrono i pianti e la disperazione delle vedove e degli orfani infelici.“
E ancora: ”…quell’immenso sterminio di sangue di ricchezza che oggi si compie ……sangue e ricchezza che voi avete nutrito con le vostre vene e con le vostre fatiche… …la guerra con la distruzione e con la morte…“
Così scrivevano i socialisti, così la Camera del Lavoro, e parve, perfino a Lao, che stessero esagerando.

Ma nonostante le parole decise e dure che risuonarono al comizio, nonostante la musica che infervorava gli animi, era evidente che l’atmosfera era tesa, e preoccupata. Sulla festa incombeva la consapevolezza che ormai i giochi si stavano compiendo.
Appena tre giorni dopo, ai manifesti del primo maggio, ancora integri, venne affiancato l’Invito Sacro dei cattolici.

La Chiesa rispose, alla mobilitazione del Primo Maggio, con la forza dirompente del Santo sotto la cui ala protettrice, gli esanatogliesi, da tempo immemorabile avevano cercato riparo per dare robustezza al compito affidato alla patrona titolare, Santa Anatolia.
Si spalancò la cancellata dell’abside e dall’Eremo si mosse, in soccorso del paese, non la reliquia che tre secoli prima era giunta da Taranto con l’estenuante cavalcata di Teodoro Buscalferri, ma la statua intera, il Santo tutto, sorretto da possenti fedeli.
Lao ricordava l’evento come qualcosa di straordinario.
Si diceva che in passato fosse già accaduto. Di certo, sosteneva qualche ben informato, per l’epidemia di colera del 1836 quando il terrore del contagio indusse – temendo non bastasse quel solo atto devozionale – a murare anche tutte le porte d’ingresso al paese, eccetto le principali, e a piantonare armati le case dei malati. Lao ci inserì del suo, e favoleggiò che qualcosa di simile era avvenuto pure al tempo dei francesi, ai primi dell’800. Ma in quel caso – si allargò Lao – il Santo “s’era móssu da sulu“, per intimorire i giacobini che depredavano monasteri e chiese.
La statua fu portata nella Chiesa della Pieve dove il 6 maggio iniziò un triduo di preghiere per scongiurare la guerra e per sette giorni vi rimase esposta.
A Lao, che naturalmente vi partecipò, le varie funzioni parvero quasi veglie funebri, tanta era la mestizia di quanti in chiesa, davanti a quella statua mora e arcigna, appena ingentilita da una ghirlanda di fiori maggiolini che qualcuno gli aveva appuntato sul petto, si profondevano in lamentose preghiere.
Il 13 maggio, giorno che era giusto dell’Ascensione, la statua risalì in corteo lungo il versante del Corsegno e l’Abate Pievano, Don Albino, si fece carico di riaccompagnarla alla Chiesa del Monte, appesantita dalle suppliche e preghiere ricevute nel corso della permanenza in paese. Più leggero il fardello dei doni propiziatori depositati nello stesso tempo ai suoi piedi, la cui consistenza venne annotata in tre tovaglie e una cotta, due lampade e ventuno falcolotti di cera d’api, cinque cuori d’argento, diciassette anelli, tre fedi e tre spille a fermaglio. Ricollocata la statua nel suo stallo, per la folta schiera di fedeli fu un mesto ritorno, in ordine sparso. Negli stessi momenti di quella tiepida serata, nei palazzi di Roma si completavano i giochi e il terribile passo stava giungendo a compimento.
L’Italia si avviava verso l’entrata in guerra.
Ignari, i fedeli esanatogliesi proseguirono nei giorni successivi i viavai lungo le pendici del Corsegno per impetrare al Santo: la mattina dopo toccò alla Confraternita del Gonfalone, all’epoca la più numerosa, due giorni dopo furono i Confratelli del SS.Sacramento, quindi il 16 fu la festa vera e propria “con notevole concorso di popolo”.
Sarebbe stata una delle ultime occasioni pubbliche, perché poi, in virtù dell’art. 3 del Regio Decreto 674 del 23 maggio, sarebbero state “vietate in linea assoluta riunioni pubbliche processioni civili e religiose passeggiate con o senza armi e assembramenti in luogo pubblico”.
Due manifesti si trovarono ad essere affiancati, quello della Camera del Lavoro e l’Invito Sacro dei cattolici. Lao lesse ad alta voce, per sé e per tanti altri: “…..giuramento solenne di stringere più compatte le file, di intensificare la propaganda, di elevare gli animi degli intelletti, perché non si abbiano più a rinnovare i presenti delitti, ed una pace duratura diffonda i suoi benefici fra i popoli e gli uomini, divenuti finalmente fratelli.”
E lesse ancora: “mentre l’Europa quasi tutta trascinata nei vortici di una funestissima guerra, ai cui pericoli e conseguenze fatali nessuno può pensare senza il più grande spavento, a noi non resta che rivolgerci a Dio e chiedere a lui aiuto con l’intercessione dei santi protettori. Si rinnovi pertanto e si estenda in questa ora triste tremenda la nostra preghiera; e sia tanto più fervida, quanto maggiore è la trepidazione e il pericolo”
Ma erano sempre meno, anche tra i credenti, quelli che credevano veramente potesse bastare un triduo di suppliche per scongiurare ciò che ormai sembrava inevitabile.
Così come erano sempre meno, anche tra i sovversivi e liberi pensatori, quelli che pensavano veramente potesse bastare un corteo, un coro, uno sventolìo di bandiere per contrastare l’incombente guerra.
E gli eventi poi precipitarono, nonostante le grida a pugni stretti, o le preghiere a mani giunte, tutto si sciolse nella velocità che stava segnando la vita di quei tempi, sprofondò in un pozzo senza fine che risucchiò tutti, e fu, anche per noi, la guerra.
L’entrata in guerra
Lao, nonostante potesse dirsi informato perché girava sempre armato di curiosità, non ebbe, come fu anche per la stragrande maggioranza della gente, precisa consapevolezza dei fatti che si accavallarono negli ultimi tempi che precedettero l’entrata in guerra dell’Italia e che ci videro scendere in campo contro l’Impero Austro-ungarico che era nostro alleato dal 1882.
Al contrario di tanti altri avvenimenti, il ricordo di quei giorni restò per lui qualcosa di indistinto. Gli si confondevano i titoli dei giornali, gli si intrecciavano i nomi di Sonnino e di Giolitti, di Salandra e di Cadorna. Riusciva a tener distinto solo Zupelli, perché era Ministro della Guerra, ché a Lao gli bastava pensare a ruolo e nome per capire che c’era volontà di battaglia: Vittorio Italico, si chiamava. Ricordava solo una particolare eccitazione e un coro di voci che riecheggiavano per il paese. Gli scambi erano sull’ordine delle battute: dura pocu… non poèsse… dio ce ne scampe e llibberi… la patria tòcca servilla… che volìmo fà… pozza morisse chi la vòle …, e via di questo passo con giaculatorie sempre più vuote.
Tanta gioventù era già partita, gli uomini validi mobilitati, tanti altri se ne sarebbero presto andati in rapida successione, e lui sarebbe rimasto in paese, a coltivare la sua ‘arte’.
Lao restò, a tessere racconti, a incrociare sguardi e paure, ad assistere a quella incontrollabile frenesia, come una susta, che sembrava essersi impossessata della gente. E nel trambusto di quel giorno epocale, in cui sembrava che ogni normale ritmo fosse accelerato, se n’era andato in conceria a consultare la stampa per meglio capire cosa stesse realmente succedendo.
Era la guerra.
Quando se ne tornò via, rimuginando sulle enormità che aveva appena letto, scendendo per il Corso fu rapito dal suono stridulo di un violino che s’udiva in lontananza. Come scese ancora, scoprendo per intero la piazza del Comune, s’accorse che le porte del teatro erano aperte e il suono sembrava provenire dall’interno. Vi si affacciò incuriosito. Nella penombra della sala intravide le figure di diverse persone, dislocate variamente, chi in platea, chi sul palcoscenico, qualcuna nei palchetti, qua e là. Immobili, eccetto quella che strideva sul violino. ‘Statue’, raccontò d’aver pensato Lao.
Il suono si arrestò. Lui si fece avanti. Bastava poco per attaccar bottone. Lui era Lao: un saluto, una smorfia, una battuta e l’aggancio era fatto. Loro, le statue, erano attori. La ‘Compagnia Teatrale Drammatica di Luigi Pittore e Enrico Bolaffi’ da Roma, al completo di tutti i suoi effettivi; dieci teatranti, tra uomini e donne, compresa la piccola Emma Orlandi, che a quattro anni si ritagliava già qualche piccolo ruolo insieme ai genitori. Erano arrivati da un paio di giorni per rappresentare “Il Cardinale” ma l’entrata in guerra li aveva bloccati impedendogli di andare in scena.

Reduci dal fiasco patito a Fiuminata, precedente tappa del loro giro, erano rimasti a corto di soldi e avevano chiesto al Comune un ricovero di fortuna, all’interno del Teatro, solo per qualche giorno, in attesa di per poter lasciare quel cul di sacco in cui erano rimasti intrappolati insieme ai loro bagagli e all’armamentario teatrale di venti quintali. Stavano quindi come accampati lì dentro, aspettando una risposta dal Sindaco che, nel frattempo, aveva interessato il Prefetto: “Trovansi qui alcuni comici senza mezzi di via e senza la possibilità di ricavare i mezzi stessi della loro professione, essi hanno chiesto di essere avviati alla stazione di Chiusi per raggiungere una piazza dove dovranno lavorare.”
Cosa realmente fecero e cosa si dissero Lao e gli attori della Compagnia Pittore-Bolaffi dentro il Teatro Comunale in quelle paio d’ore, di preciso non si seppe. Pare che risuonassero brani di poesie e recitativi vari, seri e scherzosi, ma anche racconti del suo mondo sbalestrato che a volte metteva pure in rima. Avrà magari rallegrato i disperati e abbandonati attori con qualche perla dei suoi recitativi che spesso dispensava in giro per il paese, come “A la fiera de Cammerinu ho compratu un porcellittu era tantu picculittu che capìa me lu taschinu…..”, oppure “smiàula sulu e me se lagna che no’ scòte me’ la porta / non se sa quello che magna / e me fa la gatta morta” che utilizzava per alterare la descrizione del suo personale bestiario in cui il maiale si rimpiccioliva quanto un pulcino e il gatto levitava al pari di un vitello.
Ma li avrà anche informati di quanto stava accadendo, declamando, come sapeva fare, qualche titolone dei giornali appena letti: “L’Italia dichiara la guerra all’Austria!”, “Il Generale Cadorna parte per la guerra!”, “La guerra per la difesa del buon diritto d’Italia comincia oggi!”. Si sa soltanto che Lao ne uscì, a suo dire, attore consumato. Per anni raccontò d’aver duettato su lu pargoscènicu, il giorno che l’Italia entrava in guerra, con il famoso attore Enrico Bolaffi e con la primadonna, la Ada Piccini, attrice fiorentina.
Fuori del teatro, tempio delle illusioni, era però la Guerra, veramente.
Anche Lao si lasciò trasportare dall’entusiasmo per quella che i primi giorni sembrava una gagliarda avanzata, poteva veramente assomigliare a quella “bella guerra” di cui tanti avevano parlato.
Si sarebbe poi giustificato, col senno di chi può guardare indietro, citando a sua discolpa quello che raccontavano i giornali favorevoli all’intervento, che erano in maggioranza. Anche la partenza dei mobilitati, non aveva nulla di particolarmente tragico, non dava l’idea di gente che s’avviava al patibolo, sembrava che avessero accolto quell’ardente spirito patriottico che trasudava dalla carta stampata.
Ma non per tutti era così. I contadini, per esempio, diffidenti di natura, Lao li vedeva alla partenza dei drappelli diretti al Distretto e quindi al fronte – difficilmente ne perdeva una – che erano i più seri, i più cupi, forse anche perché spaesati. Alcuni di loro non avevano mai lasciato il loro terreno se non per qualche scappata nei paesi del circondario in occasione di qualche festa. Non davano certo l’idea di partire contenti. Ma i contadini, si sapeva, non leggevano la stampa.
Lao sarebbe certamente partito se non fosse stato il segnato che era. Ma in cuor suo non disperava: “Si può servire la patria anche in modo diverso, che ne sai – ripeteva a sé stesso – che anch’io non possa fare la mia parte….” . Intanto, l’esercito italiano era già passato sopra il mormorio del Piave. E dopo due giorni, come ricordava il bollettino di Cadorna, avanzò lungo la frontiera friulana, occupando una serie di luoghi che divennero poi terribilmente familiari, tra di essi uno chiamato Caporetto. A fronte di questo vittorioso dilagare, che era anche alla frontiera della Carnia e anche in Adriatico, nei Bollettini di guerra non si mancava di precisare che “perdite nostre: un morto e pochi feriti.”. Una passeggiata.
Per tanti fu breve davvero.
Breve e vincente. Questa, pensavano in tanti, sarebbe stata quella guerra. Lo pensavano, perché così gli avevano detto, anche i fanti della Brigata Pistoia che, dopo aver passato il confine quel 24 maggio, procedeva verso la testa di ponte di Gorizia. Doveva essere una marcia trionfale e sembrava che così fosse avendo in pochi giorni avanzato senza grossi problemi. E forse si sorpresero quando videro che il nemico, a un certo punto nei pressi della città, sbarrava la strada e rispondeva al fuoco. Anzi, che era come un tiro al piccione. I crucchi in alto a dominare la valle e loro sotto a ricevere gragnole di fuoco. Alla Pistoia venne affidato il primo attacco di quell’altura, il Podgora da cui si dominava Gorizia e che, già prima d’allora, chiamavano anche Monte del Calvario. E quello fu, per tanti poveri cristi. Il 10 giugno il 35° Fanteria iniziò con slancio l’assalto, “ma – come raccontarono cronache postume – il nutrito fuoco di fucileria ed il tiro aggiustato delle artiglierie avversarie arrestarono le truppe del reggimento ai reticolati intatti, infliggendo loro perdite gravi”.
Caddero in poche ore 26 ufficiali e 600 uomini di truppa. Tra questi, i primi due esanatogliesi.
Francesco Barbarossa, contadino di vent’anni, che era in servizio militare di leva dal 13 gennaio di quell’anno, rimase sul campo di battaglia con la divisa impigliata a quei “reticolati intatti”.
Caio Albani, ferito all’addome, fu trasportato morente nelle retrovie. Transitò appena nell’Ospedaletto da Campo 44, dove il giorno dopo morì. Fu seppellito nel Cimitero di Cormons. Caio, 23 anni, un’infanzia difficile, lavoro duro come conciapelli, poi l’emigrazione in Francia a lavorare negli storici altiforni di Saulnes dove pensava di rifarsi una vita e non tornare mai più. Difatti, per due anni di seguito non si presentò alla chiamata di leva. Quando, con moglie e due figli, fu rimpatriato a forza per lo scoppio della guerra, dovette costituirsi al Distretto Militare e fu condannato a un anno di carcere per diserzione. Ne scontò tre mesi appena, perché fu graziato e arruolato per due anni e 30 giorni. La sua vita in divisa durò soltanto 5 mesi.
Sempre il 10 di giugno, e sempre al cospetto del Podgora, cadde Cataldo Onesta, del 12° Fanteria Brigata Casale. Alla ‘brigata polenta’, come la chiamavano per il giallo dei suoi colori, era assegnato il compito di conquistare la cima del Podgora, la quota 241.

Costò quella conquista 14 mesi di guerra, fino alla cosiddetta Sesta Battaglia dell’Isonzo, e costò soprattutto, solo quella collina e solo per la Brigata Casale, la vita di oltre millecinquecento soldati, di cui tre esanatogliesi. Il 12° era da due giorni fermo alle pendici dell’altura, a ridosso delle prime case di Lucinico. Il passo era sbarrato da un muro di reticolati e da una barriera di tiratori e mitragliatrici, appostata in modo da coprire tutto il terreno di attacco. L’ordine era comunque di avanzare, anche sotto i tiri incrociati. “Ferite multiple a tutto il corpo” riportò l’atto di morte di Cataldo, crivellato di colpi e sepolto nel Camposanto a Lucinico. Ventuno anni, faceva il falegname.
Queste prime morti scossero l’ambiente e le coscienze.
Si cominciò a capire cosa fosse realmente la guerra, o almeno cosa potesse diventare, perché dai giornali la questione non era poi così chiara. I bollettini ufficiali, che Lao quotidianamente leggeva e reinterpretava raccontandoli in giro, calcavano sulle perdite e sulle difficoltà del nemico, tacendo o minimizzando sulle sorti dei nostri. I morti, pochi a dar retta ai bollettini ufficiali, erano solo dei numeri stampati sulla carta, privi di corpo, di sostanza. Se ne parlava, venivano citati, ma erano morti lontani, chissà.
Ora c’erano invece dei morti veri, gente che si conosceva, che faceva parte della vita di tutti i giorni. C’erano vedove e orfani di cui sentivi il pianto. Chi aveva un familiare al fronte cominciò a sentirsi sprofondare nella realtà. Iniziò a diffondersi un senso di smarrimento, a prender corpo sentimenti nuovi. E anche Lao s’accorse che era sempre più difficile trovare qualcuno disposto a parlare con leggerezza della guerra. Tanti di quelli che avevano sostenuto con vigore quella scelta, avevano abbassato i toni. Ma ormai guerra era e guerra bisognava affrontare, “Avanti Savoia! – ripeteva Lao, chiosando poi con – … anche se non c’hai vojia!”. Tutti erano coinvolti. A partire da sé stesso.
Il manifesto di Lao
Si raccontò che Francesco Santaroni, titolare della ‘Tipografia Economica’, fu dapprima come infastidito da quella improvvisa intrusione nel suo laboratorio. È facile immaginarlo, ed è facile che pensasse ad una delle solite sparate di Lao, quando questi gli si parò davanti sventolandogli un foglietto sotto al naso e chiedendogli quanto sarebbe costato farne venti manifesti, quaranta per sessanta, su carta colorata.
Avrà ricordato in un lampo di memoria, mentre lentamente inforcava gli occhiali, quando una ventina d’anni prima, non ancora ventenne ma già di conclamata bizzarrìa, Lao s’era messo in testa di diventare tipografo e rilevare la sua attività proponendo al Comune, con tanto di richiesta formale, scritta a chiare e ampie lettere com’era sua abitudine, l’acquisto della sua macchina a caratteri tipografici e offrendosi come nuovo gestore. Aveva approfittato di un momento in cui il lavoro della tipografia era un po’ diminuito. Qualche sputaveleno aveva fatto circolare maligne voci sulle difficoltà economiche dell’attività e Lao, abile nell’ingigantire, aveva fatto il resto. “La si potrebbe acquistare a basso prezzo – aveva azzardato, incauto e impietoso, nella richiesta al Sindaco – per le critiche circostanze di costui”. Erano sì venute a mancare alcune commesse di manifesti pubblicitari per certe aziende della zona, e altre avevano subito un rallentamento, come la stampa del periodico sindacale “Poste e Telegrafo”, curata fin dal 1892 e diffusa in tutte le provincie delle Marche, che aveva diradato le sue uscite, ma l’attività, svolta con tutte le regole dell’arte, frutto di una consolidata abilità professionale, proseguiva. Lao, affamato di lavoro ( “… sarebbe procurare un lavoro ad un povero sventurato – supplicava – che non ha nessun modo da procacciarsi un tozzo di pane”), ma soprattutto animato dalla passione per le lettere e quindi anche del modo di stamparle, aveva ignorato ogni ritegno e rovesciato sull’amministrazione comunale la richiesta di finanziare la sua caparbietà e quel suo incontenibile amore. Come candidamente spiegava, lavorando anche per il Comune nel fornire moduli, stampe e manifesti vari, avrebbe, piano piano, restituito nel tempo i soldi investiti.
Una mattàna delle sue, fu ritenuta, e lì finì. Nessuno gli rispose e non se ne fece nulla.
Restò l’affronto per il mite Santaroni che, tra l’altro, riteneva Lao, rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi compaesani analfabeti o quasi, affine con la sua arte di tipografo, visto che andava sempre in giro con qualche libricino, ritagli di giornale, scampoli di carta stampata.
Si ritrovò quindi, il Santaroni, sistemate le lunette al naso, quel foglietto stropicciato tra le mani. Lo sguardò, di sbieco, prevenuto e per nulla convinto, vista quella lenza d’uomo che aveva di fronte. Lo colpì però l’imperioso inizio che lasciava pensare a uno scherzoso proclama: “Cittadini!”, così cominciava, e in stampatello. Inarcando i sopraccigli socchiuse per un attimo gli occhi, quasi a porsi in attesa di chissà quale seguito.
Un attimo appena, per proseguire poi la lettura con un graduale cambio d’espressione.
Era una cosa seria. Annuì, fissò brevemente Lao e…. “venti sò tróppi, facìmo dieci, misura quaranta per sessanta e nó li paghi”. “Però su carta colorata…” volle precisare Lao. Uno sguardo d’intesa, prima di avviare tutto il procedimento di composizione e stampa.
Usciva così, dalla pressa tipografica di via Brasca Bartocci, il manifesto con cui Lao si apprestava a entrare in guerra, o quasi. E il giorno dopo, negli abituali spazi di affissione, ma anche in spazi più inusuali, come la farmacia Zampini perché volle mostrarsi al Sindaco Mollajoli che vi prestava la sua opera di Assistente Farmacista, come il caffè di Santaroni perché il più frequentato del paese, come l’osteria di Neno Pedica perché la principale del Corso, e quella di Alfredo Giordani perché era vedovo di sua sorella Emma, e come l’edicola-merceria di Gubinelli perché poté affiancarsi alla civetta di un giornale dove si enfatizzava “Il completo successo d’un impetuoso attacco degli Alpini nella zona di Montenero”, questo si lesse:
Cittadini!
sebbene non faccia io parte di alcun Comitato, pure in quest’ora di eroici sacrifici per la Patria nostra…

Di buon’ora, tanto da anticipare la spasa del mercato e l’arrivo di quel po’ di gente ch’esso attirava ogni mercoledì, Lao curò direttamente l’affissione e compiuta l’opera andò, con passo imperioso seppur sempre claudicante e sciancato, a prendere posizione dietro alla piccola scrivania che Semme Procaccini gli aveva riservato nei locali della Croce Bianca vicino a San Martino.
La voce si diffuse in fretta e suscitò non poche discussioni, apprezzamenti, ma anche ovvie ironie e maldicenze.
Ci fu chi pensò ad una delle solite stramberie di Lao, considerandola anche sconveniente per il momento tragico che si stava vivendo.
Ma ci furono anche quelli che ne presero le difese: cosa c’era in fondo di tanto strano? Perché mai Lao – che sa lègge e scrive – non poteva offrirsi per quell’intento nobile?
E poi, non era forse stato anche Maestru de Pajanu ? Ricordò infatti così chi lo sostenne, quella sua imprevedibile carriera maturata sulla cattedra della Scuola Rurale di Pagliano quando, per due consecutivi anni scolastici, ebbe l’onore di firmarsi “Maestro Stanislao Cambriani”.
Non era passato tanto tempo, ma come sovente capita, ciò che contraria il comune sentire, l’opinione dei più, viene ignorato o comunque rimosso o seppellito in fretta.
Lui stesso tendeva a sorvolare sul ricordo, forse per il rammarico di non aver potuto seguitare quella che ormai, agli ignari, appariva come una delle sue tante invenzioni.
Era accaduto realmente invece, qualche anno indietro, nel 1908 ad essere precisi, che per le scuole rurali di Pagliano e Capriglia non si trovassero maestri disponibili. Il Comune aveva cercato in ogni modo di provvedere ad assegnare le cattedre, ma davanti alle ripetute rinunce dei maestri incaricati, non trovandone di titolati, decise di affidare l’incarico a una inedita coppia: un ottuagenario di malferma salute e uno storpio bislacco. Richiamò infatti in servizio l’anziano maestro Gaetano Vannucci che, accompagnato e sorretto da suo nipote Giacomo Bolognesi, si prese la briga di recarsi ogni giorno alla scuola di Capriglia. A Lao che, seppur maestro non fosse, fu reputato capace di supplire in qualche modo alla funzione, toccò invece la Scuola Rurale di Pagliano, dove lui, nel tempo di un paternostro – come volle precisare – si trasferì accomodandosi in una stanzetta dell’edificio che il Comune aveva affittato per la scuola. Era il “casino di villeggiatura” di Alessandro Fiacchini che ebbe qualche problema con la stravaganza del maestro perché questi tendeva spesso a fare lezione, contro il suo volere, dentro la Cappellina del “casino” (quella che oggi è la Chiesetta di Pagliano) utilizzando addirittura la campana per radunare gli alunni.

Talento naturale e autodidatta totale, Lao ci sapeva fare. Le cose necessarie per una istruzione di base le sapeva e quelle che non sapeva, riusciva a immaginarle; i bambini erano contenti di quel fanfarone che riusciva a insegnare e divertire; e pare fossero contenti anche i genitori.
Anzi, per la verità partì proprio dal basso quel suo incarico. Poiché negli anni precedenti, per passione ma anche per sbarcare il lunario e racimolare qualcosa in natura, aveva di sua iniziativa tenuto lezioni nelle campagne, dimostrando le sue capacità, furono un buon numero di genitori a candidarlo per quell’incarico: “cinque o sei bambini – scrissero al Comune riempiendo un foglio protocollo di stentate firme – hanno imparato a leggere e scrivere e fare dei conti dal medesimo Cambriani” e allora, visto che non si trovavano maestri chiesero a gran voce che fosse per Lao quel ruolo che definirono di “insegnante empirico“.

Durò, purtroppo per tutti, solo due anni, finché il Provveditorato ripristinò la legalità e la regolarità, affidando la cattedra a chi era in possesso dei regolari titoli, ma non sappiamo se anche della stessa passione mostrata dal supplente Lao.
Quindi non c’era nulla di strano che, il già Maestro Stanislao Cambriani, mettesse a disposizione “in quest’ora di eroici sacrifici per la Patria nostra”, le sue doti intellettuali e in particolare la sua arte scritturale.
Gli analfabeti erano tanti, e tanti quelli che sapevano appena fare la propria firma e poco più. Pochi, insomma, quelli in grado di articolare uno scritto seppur breve.
Comunque fosse e checché ne pensasse la gente, Lao si piazzò lì, in quella postazione nel Gabinetto di Lettura della Croce Bianca, come fosse in trincea, armato di penna, calamaio e una mezza risma di carta. Quello, per tutto il tempo necessario, sarebbe stato il suo fronte di battaglia.
S’era proposto che non sarebbe stato un semplice scrivano. Avrebbe tradotto la semplicità dei sentimenti di quanti si sarebbero rivolti a lui, avrebbe aiutato a cavare le parole da quegli animi incupiti per trasferirle al foglio, attento a rispettare quanto imposto dalla censura militare che aveva stabilito ferree regole per disciplinare la corrispondenza con il fronte.
Cominciò ufficialmente il suo ufficio di scrivano a servizio del popolo.
Era il 17 giugno del 1915.
Bastò rompere il ghiaccio con le prime semplici cartoline postali, con qualche sparuta notizia sulla salute del parentado e l’auspicio per quella del soldato, che il servizio cominciò a prendere piede.
Furono uomini e donne, padri, madri e mogli a presentarsi di fronte a Lao per innescare quei contatti con la “Zona di Guerra”.
Fu calcolato, quando tutto finì, che nel corso della Grande Guerra furono movimentate, in Italia, circa 4 miliardi tra lettere e cartoline, dal fronte al paese e viceversa. Un oceano di parole, di emozioni e sentimenti che alimentarono uno smisurato romanzo collettivo in cui anche Lao, affondò la sua penna.
Non sempre la corrispondenza poteva ritenersi una espressione libera. C’era la censura e, di conseguenza, l’autocensura.
Furono certamente più autentici i racconti che emersero dai diari e dalle memorie che apparvero dopo, a guerra finita.
Ma Lao, che non era solo un freddo estensore di missive, ma partecipava e inseriva sempre qualcosa di suo, scriveva con un apporto profondo, che dava spessore, e un po’ di calore, anche al semplice saluto di circostanza e a quelle basilari notizie su salute, lavoro e famiglia che venivano inviate al fronte. L’importanza di quella mole di scritture che fu la corrispondenza di guerra, forse più che nel contenuto, era nel mezzo stesso, nella lettera o carta postale che viaggiava ed era il filo che teneva unite le persone.
Quel viavai alla Croce Bianca non poteva passare inosservato, alimentò la curiosità e con essa l’attrazione e la frequentazione.
Forse l’idea non era affatto bislacca. Forse Lao l’aveva vista giusta.
Poi, a confermare la giustezza dell’iniziativa, a consacrare quel ruolo da scrivano, venne la lettera a Sua Maestà Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d’Italia.
La voce viaggiò rapida: “I sapùtu che Lao ha scrittu a lu Re?… A lu Re!…”. Scambi di sguardi d’ogni tipo. Commenti vari.
La lettera, in verità, era a firma di Giulia Arcangeli maritata Pacini, ma Lao, oltre ad averla elegantemente vergata, l’aveva suggerita ed elaborata. Aveva composto per la povera donna, madre di undici figli, di cui il più grande impegnato al fronte, una commovente richiesta a Sua Altezza Regale di “un qualche sollievo al frutto delle sue viscere”: Nazzareno, appena quindicenne, era da sei anni malato di pleurite cronica e costretto all’isolamento per rischio di contagio. La supplica fece il giro del paese. La storia successiva non ha conservato voci o racconti sul suo esito. Nazzareno sopravvisse una decina d’anni, non sappiamo se anche grazie all’aiuto di Casa Savoia.
Vita quotidiana e notizie dai fronti
Il Gabinetto di Lettura della Croce Bianca (che fu poi per tanti anni sede dei Combattenti e reduci e poi dell’AVIS), animato dallo scrivano Lao, divenne in breve tempo punto d’incontro dove si raccontava la guerra, se ne discuteva, il pubblico ammasso delle storie e dei problemi di quelli che stavano al fronte e di tutto ciò che intorno alla guerra girava.
E oltre alle loro storie, in occasione delle rare e brevi licenze, passarono di lì anche molti dei soldati stessi, in carne ed ossa.
Il conto delle vite mosse dalla guerra si faceva anche, o meglio soprattutto, negli uffici comunali; ma con Lao era cosa diversa, un’altra storia. Ecco, per l’appunto, erano storie.
Come ad esempio queste, che avrebbe registrato e ricordato: a luglio, il 26, Antonio Tozzi ebbe in sorte di morire a Redipuglia, su quella collina che poi col suo Sacrario sarebbe divenuto emblema del mito dei caduti. Fu come se gli avessero costruito il Cimitero intorno. Con la Brigata Macerata, dal nostro capoluogo di provincia, il 2 giugno aveva raggiunto Lonato, vicino al fronte, e “dopo un periodo di intensa istruzione” venne inviato a Fogliano entrando in azione insieme alla “Brigata Savona” contro la linea delle quote 121- 118- 100 (Redipuglia). La sua guerra durò solo due giorni e si fermò prima che la sua Brigata riuscisse a conquistare la postazione nemica (‘il trincerone’) che costò la morte di una trentina di ufficiali e oltre 500 uomini della truppa. Ferite multiple alla testa e alle gambe. Mitragliatrice o schegge di granata. Sepolto a Polazzo, frazione di Fogliano Redipuglia. Nel commentare la sua morte, ci fu chi ricordò che a febbraio di quello stesso anno aveva orgogliosamente presentato al Comune il suo ultimo nato, Attilio.
Non ebbe nemmeno il tempo di piangerlo più di tanto il suo amico, compaesano e commilitone, Nazzareno Gagliardi. Insieme nell’infanzia di Pagliano, insieme nella breve adolescenza perché di famiglie amiche e anche imparentate, poi insieme nello stesso Reggimento, il 122° Fanteria della Brigata Macerata.

Dal ‘trincerone’, conquistato e riorganizzato come avamposto, si mosse la Brigata per proseguire nell’attacco. Il 6 agosto un colpo secco al petto lo lasciò tra le pietre, a una quota più alta di qualche decina di metri rispetto al fraterno amico Antonio. Aveva 26 anni e due figlioli: Maria di due anni e Antonio di un anno appena.
A completare la morìa dei fanti esanatogliesi del 122° – Brigata Macerata, il 12 agosto cadde Augusto Zampini, 27 anni, boscaiolo.

Anche lui un colpo d’arma da fuoco al petto, anche lui lasciò due bambine in tenerissima età, Anna e Teresa.
Infine, per fermarsi all’estate di quell’anno, Modesto Ceolotti, classe 1888, Caporal Maggiore del 46° Reggimento Fanteria- Brigata Reggio, arrivò “in territorio in stato di guerra” il 12 giugno. Morì il 30 agosto, nel corso di un combattimento nella zona del Col di Lana, nel bellunese.
Per un paio di mesi, le triste nòe sulle sorti dei nostri compaesani, vennero a cessare. Ci fu come una pausa; ma nessuno credeva che potesse essere finita.
Lao continuava la sua opera, immancabile. Raramente passavano giorni senza che scrivesse almeno una cartolina sempre e solo a quell’unico indistinto luogo che gli appariva ormai quasi una smisurata città: “Zona di Guerra”.
Il mese dei morti
Gaudenzio Cilla, ennesimo calzolaio del paese, era anche, per necessità, custode al Cimitero. Gaudenzio Cilla aveva due figli al fronte.
Stando ai sogni che gli ricorrevano negli ultimi tempi, Gaudenzio Cilla, nel sonno, temeva di dover seppellire i suoi figli morti in guerra e non trovare uno spicchio di terra libero.
Da sveglio, il 24 ottobre, segnalò alle autorità la necessità di liberare posti al Cimitero procedendo alle esumazioni: si diceva che su al fronte non ci fossero più posti per le sepolture.
Nessuno pensava ad un possibile ritorno di quanti erano caduti lassù al fronte e di quanti avrebbero avuto analoga sorte.
Ma Gaudenzio voleva ugualmente prepararsi, pronto ad ogni evenienza. Lo angosciava l’eventualità di non poter accogliere i figli nel suo Cimitero. Iniziarono le esumazioni e volle il caso che con esse iniziò una lunga sfilza di lutti; intorno a novembre, che non per niente è il mese dei morti. E tanti ve ne furono da noi: sette esanatogliesi nel giro di poco più d’un mese. Gaudenzio Cilla continuò a sognare mentre ogni quattro, cinque giorni, occorreva aggiornare il conto. Si liberavano i posti al Cimitero, ma dal fronte, dei morti arrivavano solo le notizie.
Il primo aggiornamento dopo quasi tre mesi di silenzio, riguardò Francesco Spitoni, fu Romualdo, classe 1895, 118° Reggimento Fanteria della Brigata Padova. Era già stato insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare con questa motivazione: “ Per ben tre volte, di notte, in terreno insidioso e sotto il fuoco di fucilieria nemica, portava avvisi ed ordini a reparti lontani, riuscendo sempre nel difficile e pericoloso incarico. Rimasto ferito, non pronunziava un lamento, e si interessava soltanto della riuscita dell’azione, con parole da vero soldato. Podgora 20-21 luglio 1915”. Ferito in combattimento sul Monte Cosich, nei pressi di Monfalcone. Da quell’altura (112 metri sul mare), dapprima conquistata e poi lasciata per la “viva reazione avversaria che cagiona la perdita di 18 ufficiali e 700 uomini di truppa”, fu portato a morire all’Ospedale di Cremona – Duemiglia, il 28 ottobre.
Fu poi la volta di Angelo Todini, Caporal Maggiore della Brigata Casale, 12° Reggimento Fanteria. Classe 1885. Rientrato in patria per la guerra dopo sette anni di lavoro in Francia. Anche lui, come già altri esanatogliesi, cadde sulle falde del Podgora durante un’offensiva che affondava nel fango. Il 28 ottobre era iniziato un attacco sotto l’imperversare di una bufera che durò poi diversi giorni. Piovevano catini d’acqua e frustate di nevischio che in tempo di pace sarebbe stato difficile camparci.
S’aggiunse un altro Francesco Spitoni, figlio di Giuseppe, neanche parente dell’altro, ma ventenne anche lui come il suo omonimo. Dei luoghi della guerra conobbe solo le colline di Santa Lucia e Santa Maria, attrezzate a difesa di Tolmino con trincee reticolati e un grande schieramento d’artiglieria. Aveva raggiunto la sua Brigata, la Bergamo, il 28 settembre, trovandosi davanti quel muro. Quaranta giorni di scontri in quella zona, compresi quelli della Terza Battaglia dell’Isonzo, posero fine alla sua avanzata. Il nove novembre, uno squarcio al fianco sinistro lo portò a morire nell’Ospedaletto da Campo n.30. Fino a quel punto, quei pochi chilometri erano costati la vita di 1.200 soldati della sua Brigata. Fu sepolto a Padravna in Valle d’Indrio. Appena al secondo giorno, sotto il fuoco martellante dell’artiglieria, a fine giornata mancò all’appello e fu tra le centinaia dei dispersi. Non risultò tra i prigionieri. Svanito nel nulla.
Era fante del 28° Brigata Pavia, Nicola Bartocci, un altro ventenne ancora. Il 21 di novembre toccò a lui. Sotto il maltempo, il 10 era ripresa l’offensiva della Quarta Battaglia dell’Isonzo. Una decina di giorni d’inferno, poi il 20 la conquista della quota 188 presso Oslavia. Catturati 300 prigionieri, ma dal 16 al 23 novembre la Pavia avrebbe sacrificato circa 1000 uomini. Negli ultimi scambi di colpi, prima che la Brigata si ritirasse per riorganizzarsi, Nicola si perse nella battaglia. Il Comando comunicò che “prese parte al combattimento in data 21 novembre 1915, e che dopo tale fatto scomparve e non venne riconosciuto tra i militari morti né fu denunziato come prigioniero, per modo che è stato dichiarato irreperibile e deve presumersi morto il ventuno novembre millenovecentoquindici.”.
Altro contributo della classe 1895, fu quello di Filippo Onesta che cadde il 28 novembre. Era impegnato in servizio di trincea nel settore di Kozmarice, a sud di S.Lucia, dove il 93° Reggimento Fanteria della Brigata Messina era attestato ”compiendovi tormentati periodi, sino alla fine di dicembre”.

Durante i mesi di agosto e settembre furono innumerevoli i tentativi di conquistare questo monte alto 588 metri, che si eleva con pareti ripidissime interrotte da sbalzi quasi verticali e difeso da fitte siepi di filo spinato. I nostri soldati riuscirono a mettere il piede sulla vetta del colle, ma furono subito respinti dal fuoco dell’artiglieria, dalla furia dei contrassalti austriaci e dai lanciafiamme. Dal 2 novembre al 14 dicembre questa semplice routine produsse 150 morti 500 feriti e 24 dispersi. In uno dei tanti assalti, Filippo si prese una pallottola al petto e fu sepolto a Santa Lucia. Sei mesi dopo, alla famiglia sarebbero stati recapitati i suoi effetti personali: “borsellino con lire 0,37, orologio e catena, specchio, pipa, carte varie e due libretti”; nell’oggetto: “Successione Onesta Filippo”.
Infine, a concludere quel rosario di ventenni, il 29 novembre, cadde sulla Sella di Oslavia, nei pressi di Gorizia, Giovanni Fabrianesi, bracciante. Era fante del 154° Reggimento della Brigata Novara ed era giunto al fronte il 4 ottobre.
L’ultimo morto dell’anno non cadde direttamente sul campo, ma morì nelle immediate retrovie del fronte.

Fu stroncato da una ”paralisi cardiaca” all’Ospedale di Padova, il 30 novembre, Alessandro Mancini, sarto, 32 anni e 4 figli: Ruggero, Romolo, Remo e la piccola Geltrude, che aveva appena quaranta giorni quando suo padre con la Brigata Casale superava il confine e puntava dritto verso il Monte Calvario.
Stremato dalle fatiche di quel novembre in cui piovvero incessantemente grandine e granate.
La voce dei soldati
Calò sulle zone di guerra un inverno totale. La neve, come non si vedeva da anni, sommerse uomini e trincee. Tutte le attività belliche furono costrette dapprima a rallentare, poi quasi a fermarsi del tutto. Poiché la truppa da tempo aveva preso a lamentarsi per le scarse licenze concesse senza regolarità e s’erano verificati alcuni episodi di ribellione, in occasione delle feste del Natale lo Stato Maggiore decise di rimandare a casa, per quindici giorni, decine di migliaia di soldati. Fu una svolta, perché avvenne così che cominciarono a diffondersi tra la gente, in ogni angolo d’Italia, i racconti di prima mano, le storie vere di ciò che accadeva al fronte.
Gli stenti, le sopraffazioni e le carneficine raccontate da chi, almeno per il momento, era sopravvissuto.
Anche a Esanatoglia tornarono diversi militari in licenza. Alcuni parvero come spiritati, si appartarono nelle loro case, al riparo delle loro famiglie e scelsero il silenzio. Ma ci fu anche chi si lasciò andare, magari davanti a qualche bicchiere di vino, riempiendo l’osteria di racconti della vita in trincea, degli assalti, di quell’indicibile orrore. Storie che si diffusero rapidamente e lasciarono sgomenti.
Accadde ovunque, in ogni angolo del Regno, e assunse un aspetto preoccupante tanto che il Governo e lo stesso Cadorna si videro costretti a porre un freno a quel dilagare di racconti incontrollabili emanando precise direttive contro il “disfattismo dei soldati in licenza”.
Lao ascoltava quei racconti e li confrontava con quello che di solito leggeva sui giornali. Si chiedeva allora, perché fossero così distanti le versioni, chi fosse a spararle più grosse, e dove fosse quel popolo d’eroi che qualcuno vagheggiava, dove fosse quell’esercito che mieteva vittorie e spogliava progressivamente il nemico di uomini e mezzi? Raccontare le atrocità della guerra, era questo forse il disfattismo?
Alcuni racconti li ebbe direttamente in casa, da un suo fratello cugino, Delio Tofani, un ragazzo ancora, fante nella Brigata Pavia, che riferì d’aver visto in qualche mese talmente tanti morti in un frustolo di terra che se li avessero lasciati lì, sul posto, non ci sarebbe stato spazio per seppellirli tutti. Prima sul Podgora, che lì chiamavano Calvario perché prima che l’artiglieria italiana le distruggesse, v’erano tre croci in sommità. E lo chiamavano anche monte, anche se era solo una collinetta, (240 metri, non di più), ma sotto c’era Gorizia e la sua valle. Poi aveva combattuto su e giù per le pendici del Monte Sabotino in un marasma che non lasciava tempo e spazio per essere capito. Si raggiungeva una quota dopo giorni di scontro continuo, si conquistava la posizione e neanche il tempo di organizzarsi che si era di nuovo ricacciati via da una controffensiva nemica. Saranno stati più di 500 morti, raccontava Delio, e feriti a migliaia solo nella sua Brigata avevano insanguinato quelle montagnole intorno Gorizia.
E quella non era che una piccola parte, un cantuccio appena di quella enorme guerra. Lao rimase incantato da quei racconti. Un profluvio di stimoli e emozioni che lo immersero ancor più nel ruolo di cantore che ormai s’era ritagliato.
Quel periodo però Lao rimase solo. Il fratello Giuseppe era militare e l’altro fratello, Guardiano Cappuccino a Pietrarubbia col nome di Padre Alfonso Maria, non potendo più mandare nessun aiuto a casa (“oggi è l’ora della crisi generale”, scrisse al Comune per giustificarsi), s’era portato con sé, in convento, l’anziano padre, lasciando praticamente Lao in stato di abbandono.
Al Sindaco che gli chiese di farsi carico anche di Lao, rispose con toni piccati che non aveva nessun obbligo nei confronti del suo “infelice fratello” e, soprattutto, reagì rispedendo il padre a Esanatoglia “..così cotesto Comune anziché di amministrare uno, ne amministrerà due.”
Davvero è uno strano secolo, si disse Lao, e cominciò a pensare che la guerra avesse diversi modi di ammazzare.