Capitolo 4 – ultimo
Elementi naturali e simboli di povertà
Fuori del claustro di Fontebono, poco distante da quello che era stato l’ingresso della chiesa, prima che i Cappuccini stessi ne ribaltassero la struttura spostando l’ingresso nel lato opposto a quello in cui si trovava originariamente, v’era la fonte che dava il nome al luogo. Una sorgente che sprillava le sue acque direttamente dalla roccia, e di particolare bontà, d’una specialità che attraeva e che da sempre aveva stimolato i reni e con essi la fantasia. Si trattava di un’acqua le cui caratteristiche mineralogiche un geologo d’oggi ascrive alle formazioni di calcari marnoso-silicei-bituminosi e spiega con la presenza, al loro interno, di noduli di Marcasite (solfuro di ferro). Ma a quel tempo, era semplicemente salutifera e ricca di proprietà curative poiché conteneva, oltre a vari minerali, “argento et principalmente oro” come riporta un anonimo foglietto vergato a mano apparentemente coevo che ne elenca le componenti.
Pietro Agostino Boscherini, il medico condotto che il Consiglio generale aveva nominato nel 1672 e confermato l’anno successivo “per le buone qua- lità e perizia e diligenza…” la dispensava pura ma a volte la usava anche per farne impiastri e giulebbi vari con cui affrontava svariati malesseri.
Proprio nell’anno in cui la comunità decideva di continuare ad affidarsi alle sue cure, così l’aveva cantata in un suo sonetto:
In lode dell’Acque Auree di Fontebono
Di Fontebono il liquido elemento Ch’ha miniera dorata, anzi vitale, distilla a prò del misero mortale potabil oro, e liquefatto argento.
Quinci non fia stupor se in un momento Di sua bontà la fama impenna l’ale,
che se d’oro, e d’argento ha il minerale, rende l’alma tranquilla, il cor contento.
E’ quest’acqua pregiata, onda gradita,
che gemme accoglie, onde può dirsi appieno liquor gemmato, ed Elisir di vita.
Langue il sen, torpe il senso, il cuor vien meno? Non paventi il mortale: essa dà vita,
forza al cor, gioia al senso, e spirto al seno.
E non sembri una esagerazione, se pensiamo che più di cento anni dopo, l’anonimo autore delle “Analisi delle acque di Fontebuono che scaturiscono nel Convento dei PP. Cappuccini di Santanatoglia, e
loro mediche facoltà, esposte secondo la nuova dot- trina di Brown” (Jesi, Stamperia Bonelli, 1798) indica quell’acqua come rimedio per: “affezioni melanconiche, scabre, diabete, eccessiva perdita di sangue, vomiti, cardialgie, dispepsia, coliche intestinali, diarea, dissenteria, affezioni scorbutiche, e isteriche, podagra, ipocondria, asma, idrope, epilessia, paralisi e altre affini…., vertigini, gonorree, ulcere invecchiate, fistole”.
Come era d’uso nei conventi e monasteri, anche a Fontebono v’era, seppur modesto, l’orto dei semplici, ossia il giardino in cui si coltivavano alcune piante medicinali, anche umili erbe, buone per lenire i dolori, farmaci naturali adatti per comporre unguenti e pozioni, decotti e impiastri; lo curava Fra Giuseppe, quello era il suo regno e in esso ricadeva anche la fonte. Così, e non poteva essere altrimenti, egli era anche un po’ come il custode di quella sorgente, quello che più di chiunque altro riusciva a rappresentare la straordinarietà di quell’acqua.
Quando Carlo Bonnani, Cancelliere Episcopale in Matelica, in una domenica di settembre del 1690, dopo aver sonata la solita campanella, vide aprirsi la porta del Convento proprio da fra Giuseppe, sperimentò la vertigine ch’emanava quel luogo e quel piccolo frate. La sua visita era diretta alla ricerca di un consiglio, un orientamento per un cruccio che lo assillava; l’episodio non sembra testimoniare molto di più della capacità di Fra Giuseppe di entrare da subito in sintonia con il suo interlocutore, di saper leggere nel suo intimo come se “Iddio lo favorisse di svelargli i pensieri altrui, e i segreti ancora più ascosti”; un episodio marginale ma che ci aiuta a capire come egli riuscisse ad esercitare il suo potere evocativo attraverso gli elementi più umili, utilizzando anche questa prodigiosa risorsa, l’acqua di Fontebono, che dispensata da lui diveniva ancor più prodigiosa: gli ammannì una ciotola di quell’acqua facendogliela bere a digiuno e dicendogli “E’ bene, Fratel mio, è bene ricordarsi dell’acque fresche del Paradiso”.
E allora occorrerà ricordare che usò anche mele e prugne rinsecchite, semi di anice e mappe di finocchio, meloni e melarance; elementi naturali che occasionalmente integrava con simboli di povertà che egli “era solito dispensare non solo a i Poveri, o alla sola gente plebea, ma alle persone ancora Civili”: principalmente tozzi di pane, ma non solo.
“Per dimostrarsi, et essere cortese: per professare civiltà, e gratitudine: per attestar benignità e benevolenza: per captivar l’altrui corrispondenza, e gli affetti: e per eccitare, e mantener la pronta divotione nel Prossimo, portava seco qualche frutto, e qualche piccolo, e ruvidetto tozzo di pane. … quei frutti e tozzi di pane non erano degli eletti frà i migliori; ma i soli avanzati nella comune, e frugalissima Tavola dei Religiosi; e col divoto preambolo d’esser quelli stati benedetti nella solita refettione dei Frati”. Avanzi della già povera tavola dei frati, che all’occorrenza divenivano “rari regali di esquisita, e pretiosissima stima”: “Né ciò egli eseguiva coi soli fanciulli e con gente povera, nò, ma senza mini- ma differenza, coi piccoli, e grandi; con poveri, e ricchi, con nobili e ignobili; con civili e plebei; e infino con Sacerdoti di non infima sfera, e graduati”.
È un lungo elenco di testimonianze di benefici ricevuti; un repertorio da cui carpiamo alcuni esempi di varia ed ineguale intensità.
Nel 1684
Giovanna di Angelo di Pecchie, moglie di Salvatore di Francesco di Sant’Anatoglia, prima d’esser collocata in matrimonio fu sorpresa da una febbre veemente e incurabile. Maria Felice, sua madre, spedì Antonia, l’altra sua figlia, al Convento dei Cappuccini a pregar Fra Giuseppe che la esortò a sbandire ogni dubbio consegnandole un melarancio. In capo a qualche giorno Giovanna recuperò per intero la sua salute.
Nel 1690
Venanza Bonapasta della Villa di Massa della Fiuminata, si vide offrire una mappa di finocchio che la risanò da un’aspra infiammazione alla gola.
Lo stesso periodo, nel castello di Pioraco, regalò una rametta di finocchio a Maria Francesca Leonardi che la usò all’occorrenza per sanare un veemente mal di denti.
Nel 1693
Risolse i frequenti dolori di corpo di Sebastiana di Pietro di Antonio, vedova di Michel’Angelo di Valentino dal Colle Villa del Poggio di Sorifa Ca- stello di Camerino, donandole una “borsetta di tela con un poco di quella polvere, che per divotione si raccoglie nello scopare la Santa Casa di Loreto”.
Nel 1697
La Signora Virginia Periberti di Matelica invocò la presenza di fra Giuseppe al capezzale di Dia Maria, sua figliola, afflitta da una febbre che faceva temere per la sua vita; di fronte alle tenere espressioni con cui la madre supplicava per la salute della figlia ninnandola tra le braccia, Fra Giuseppe intervenne opponendo alle “rigorose e prudenti prohibitioni del Medico” una prugna rinsecchita. S’impose con decisone alle rimostranze della madre: “Eh lascia, che ne mangi: perché non fa niente: Stà allegramente, né pensar’altro”. Così promise e così, pare, avvenne che la febbre si risolse.
Nel 1689
Giacomo e Santa Biancaspalla, contadini di Matelica, pativano ambedue “certi dolori interni” e avevano un figliolo dodicenne, Antonino, malato di idropisia. Con poche fette di pane, portate da Fra Giuseppe e ch’essi centellinarono, la famiglia fu, in breve tempo, risanata.
Sempre con due fette di pane e un pero risanò Aurelio di Andrea Vissani da Sant’Anatoglia “già disperato da Medici e in mano de Sacerdoti”.
Ancora nel 1699 dispensando lo stesso rimedio sanò Anna Braschi moglie di Astorre Costanzi “da una postema dentro la bocca nella parte destra con enfiagione assai grande nell’esteriore”.
Nel 1682
Contro la dissenteria di Santa moglie di Antonio di Giuliano nella Villa di Massa della Fiuminata, impose la falda del suo mantello e diede da mangiare alcuni confettini di anice (“dare a mangiar confetti di anici ad una inferma di dissenteria, è certamente un mettere a precipizio una simile infermità”). La cura ebbe buon esito.
Nel 1690
Vittoria Bonapasta di Camerino, ritrovandosi nel mese di agosto nella Villa di Massa, dove quella famiglia ha i suoi beni, assalita da veemente dissenteria tanto che il Medico di Sant’Anatoglia, alla cui cura si era sottoposta, viveva assai dubbioso di saperla, e di poterla liberare dalla morte. “Estrasse dal suo pranzo un rimedio, a cui secondo l’arte avrebbe contraddetto e l’esperienza, e la sapienza tutta de i Medici”: le inviò una fetta di melone e due prugni. “Dite che mangi questo, e non occorre altro”. La dissenteria declinò “senza applicarvi altro rimedio, benché si trovasse in pronto una gelatina di Corno di Cervo”.
Nel 1684
Villa di Massa, Girolamo di Giuliano giaceva infermo per una forte febbre. Il medico non seppe fare di meglio che spedire con tutta prescia un parente a Sant’Anatoglia, a far distillare dalle monache di Santa Maria Maddalena una gallina; incontrato per caso fra Giuseppe fuori della Porta di Sant’Andrea, gli narrò che Girolamo era in procinto di avvicinarsi alla morte.
Fra Giuseppe s’avviò così a passo lesto verso Fiuminata. Nel frattempo le condizioni s’erano ag- gravate tant’è che alcuni accorsero alla Chiesa, “e col suono della campana, diedero al popolo il solito avviso dell’agonia”.
Fra Giuseppe arrivò e fece tacere i lamenti invitando a confidare in Dio “che fa, e può non solamente risanar gl’infermi, ma richiamar gl’infragiditi, e schifosi cadaveri da i sepolcri”. Dopo le litanie con tutti gli astanti, cavò dalla Tasca della Cerca una mappa di finocchio (“donativo atto naturalmente non a sollevare, ma a metter in più celer precipizio un moribondo”) e porgendola all’infermo gli ordinò che lo mangiasse. Obbedì questi prontamente e “quasi avesse gustato in quel finocchio un Elisir vitae, si sentì in un subito declinar la febre, rinvigorir le forze e assicurar poi con tanta, e così inaspettata celerità la salute”; Girolamo lasciò il letto nel termine di cinque giorni.
Sempre in quell’anno, Ansovina, moglie di Francesco Cesari della Villa di Santa Lucia di Somaregia, nell’aiutare il marito a scaricare sotto una impetuosa e copiosissima pioggia la soma di un giumento carica di fieno, si sentì trafiggere da “una punta acuta nel ventre”, e poco dopo “si ritrovò aperta nella parte destra una gravissima crepatura”.
Dopo cinque giorni di atroci dolori, col permesso del marito, cavalcando un’asina, si condusse a S.Anatoglia e giunta al Convento dei Cappuccini, prima ancora che potesse suonare la solita campa- nella le si parò davanti Fra Giuseppe che non le dette nemmeno il tempo di parlare. Corse dentro al convento e ritornò poco dopo con tre piccole fette di pane e in un vaso un poco di vino. Le disse di mangiare il pane e poi lavarsi i polsi e il naso con il vino che le versò nel concavo delle mani.
Fiduciosa lei eseguì; prima di ritirarsi nel convento, la invitò ad andare alla Messa che stava per uscire. Già nel salir la scala, per cui dalla porta del convento si va in Chiesa, lei stessa, nella sua memoria, racconta d’essersi sentita libera dal dolore e risanata dall’infermità.
Altri fatti miracolosi
Dove non erano sufficienti gli elementi naturali, Fra Giuseppe impegnava direttamente il suo corpo. Il segno di croce tracciato con le dita screpolate, l’imposizione delle mani, fino a gesti di estremo simbolismo, di condivisione corporea: la lingua, l’uso della lingua per segnare con la croce, ma anche per sorbire, nettare il male.
Nel mese di luglio del 1698 il medico Giuseppe Spinosi che aveva la condotta in Sant’Anatoglia, fu assalito da “una febre terzana doppia continua e de genere acutarum”. Venutone a conoscenza, Fra Giuseppe decise di fargli visita e quasi irrompendo in casa sua lo assalì dicendogli con una punta di sarcasmo: “Ah vigliacco, vigliacco! Non dubitare, non temere: perché presto guarirai, e presto ancora partirai di qua”. La testimonianza fu resa dal medico stesso, dopo che guarito da quella pericolosa infermità era stato trasferito a Sassoferrato e ricordava la sensazione di un graffio a forma di croce che il frate gli aveva impresso sulla fronte.
Nel 1698 fu chiamato a visitare la contessa Faustina Teresa della Genga, moglie dell’allora Governatore della Santa Sede Nicolò Bianchi.
La nobildonna era oppressa “per lo spazio di molti mesi da una grave e travagliosa infermità d’ itterizia”. Le mani del frate si posarono sulle spalle dall’ammalata, ch’ebbe come un sussulto: “strisciò egli più volte sopra la spalla sinistra dell’inferma una mano, ch’essendo ruvida faceva qualche rumore sopra le di lei vesti di seta…”. Un gesto, semplice, un contatto; poche parole altrettanto semplici “habbi fede, habbi fede, guarirai” e quasi cantalenando questa che poteva essere sia promessa che auspicio, se ne andò via per lo scalone del palazzo.
La contessa guarì e raccontò, e nel raccontare riudiva il fruscio di una mano che raspava le sue sete. Sempre con l’imposizione delle mani, stavolta sul ventre, sanò Giovanni di Paolo della Villa di Massa, quando fu sconvolto dal “male del volvolo” detto anche “mal del miserere” o “passione iliaca”: un vomito senza fine, “così pertinace e insuperabile, che per lo spatio di più giorni, benché avesse preso e inghiottite alcune palle di piombo, non aveva potuto fare la naturale evacuatione del corpo”. Le mani, ruvide e rugose, brancicarono il ventre o forse lo carezzarono appena. Giovanni di Paolo raccontò il buon fine della sua triste esperienza.
In altri casi ricorse a un pannicello come con Caterina Micheli a cui per una febbre maligna considerata incurabile “pose una mano in capo, e colla mano un pannicello di mezza lana di quei, che usano i Capuccini in occasione o di fatiche, o di viaggi…”.
Astorre Costanzi ritrovandosi oppresso dalle angustie della podagra, per tormento maggiore fu assalito nel ginocchio destro “da una così eccedente enfiagione” da costringerlo all’immobilità assoluta.
Sentendo i Cappuccini picchiare alla porta della casa per chiedere l’elemosina, chiese se fosse Fra Giuseppe. Proprio il fraticello gli si parò di fronte al letto. Dalle coperte sgusciò fuori un ginocchio intumidito ed ammorbato da una maligna gotta. Fra Giuseppe “vi si chinò colla Faccia, vi si accostò colla bocca: lo lambì colla lingua; e lambendo vi fece il sospirato, e benedetto segno di Croce”. Senza aggiungere altro, se ne partì; “la sera medesima (che è il dire, nel breve spazio di due, ò trè hore)” l’enfiagione si dileguò.
Bartolomeo Ferri di Sant’Anatoglia era allettato da più d’un anno per una “grave e stravagantissima infermità che gli aveva enfiato fuori di modo tutto il corpo, e l’istessa gola, si estese tale enfiagione ancora nelle mani, che avendogliele affatto instupidite, non gli permetteva il servirsene…”.
Era il 10 di maggio, giorno della Festa di San Cataldo, e i Cappuccini erano scesi in paese per partecipare alla processione. Fra Giuseppe, conteso come sempre, fu quasi come rapito e condotto a forza e suppliche al capezzale del Ferri. Non si scompose alla vista di quella sofferenza; gli fece scoprir le mani, e lambendole vi impresse con la lingua il segno di Croce e immediatamente licenziatosi se ne andò alla Processione. Il malato fu sorpreso da un insolito sonno, s’accorse appena di sprofondare “e con tutta quiete, e senza angustia dormì per lo spazio quasi d’un ora”. Destatosi poi dal sonno, come ebbe modo di capacitarsi, fu preso come da uno stordimento. Chiamò sua moglie Marsilia, gridando al miracolo: aveva le braccia libere dall’enfiagione. Terminata la processione Fra Giuseppe volle tornare a visitarlo.
E mentre fuori la festa profana s’era sovrapposta a quella religiosa e riecheggiavano per tutto il paese i chioppi degli archibugi che si contendevano, com’era tradizione, il Palio di San Cataldo, nel chiuso della sua stanza Bartolomeo non cessava di lodare con ènfasi la salvezza che gli aveva procurato Fra Giuseppe. A più non posso urlava d’essere stato da lui miracolato.
Lo ammonì il frate, che non si trattava di un miracolo, che quelli solo Iddio li fa; e in silenzio, a testa bassa, quasi scivolò via tra lo stupore della gente; l’euforia per il prodigio e per la festa s’alimentavano a vicenda mentre le botte secche di chi onorava il patrono tirando al bersaglio, accompagnavano quella macchia marrone che, a dispetto dell’età, risaliva scaprettando la costa del Corsegno verso Fontebono. Nello spazio di quindici giorni il male di Bartolomeo Ferri regredì per intero.
Antonia Micheli nell’ottobre del 1688 si trovava afflitta da una febbre maligna che dal Medico era stata giudicata incurabile e “si disponeva a ricevere i convenevoli Sacramenti, e singolarmente il Santissimo Viatico”. Al suo capezzale giunse Fra Giuseppe facendosi largo tra il medico e il pievano che s’erano appena accordati sul passaggio di consegne; poggiò la fronte sulla sua e le chiese “Che male hai Antonia?”. La risposta non si può immaginare più definita d’un sussurro, una gnacchera, un mugugno destinato a strozzarsi in gola.
Nella Vita invece, alla donna si concede la lucidità e il fiato per poter descrivere la sua pietosa e disperata situazione: “il mio maggior male – rispose – è un fetore insopportabile causatomi dalla malignità della febre: questo mi angustia, questo mi tormenta, senza poterci ritrovare un minimo rimedio”. “Habbi fede, habbi fede” la esortò il frate toccandola, e a quelle parole e a quel contatto “quasi si fosse aperta una profumeria preziosa, o si fossero ivi radunati i più celebri aromati dell’Arabia, si sentì l’Inferma svanire in un subito quel fetore, e provò spirarsi una fragranza così soave, che non seppe contenersi, di non esclamare ripiena di giubilo, e di maraviglia: Oh che odore! Oh che odore!”. Quasi volendo occultare la sua opera, come intimorito dal risultato che aveva prodotto e preoccupato come sempre delle reazioni della gente, il frate se ne andò prontamente: “statti quieta, statti quieta !…” implorò scivolando via nel buio dello scalone.
Raccontiamo senza l’onere della prova, perciò evitiamo di essere estenuanti; poiché lunga sarebbe ancora l’elencazione di cancri alla bocca e dissenterie, di idropisie e balli di San Vito e Sant’Antonio, il campionario di ammorbamenti e insanie varie, dai semplici malesseri, che dal racconto suggeriscono depressione e scoramento, fino ai mali devastanti.
Il secolo, intanto, se ne stava andando insieme alla sua vita; un crescendo di presenze, segnalate laddove una sofferenza lo reclamava e testimoniate con fervore dai beneficiati, accompagnava questo declino. Alla fama, diffusasi nei circondari dei vari conventi ove aveva dimorato, s’era ormai aggiunto il rispetto e la venerazione per la vecchiaia che gli aveva rugato il volto, scartocciato i piedi, e reso meno ispido il carattere e con esso lo sguardo. Non diminuì però il suo ritegno; più aumentava il carisma della sua figura, più egli tendeva a divenir schivo e ad allontanarsi dal clamore rifuggendo ogni occasione che poteva turbarlo.
S’avvicinava il sedicesimo Giubileo, quello del 1700, il terzo da quando aveva indossato il saio; la sua ritrosia, l’estraneità nei confronti di un mondo a lui così distante, l’avevano sempre tenuto lontano da ogni contatto con la città dei Papi. Nel corso della sua vita se n’erano avvicendati ben dieci al soglio pontificio, di cui otto dopo la sua professione di fede: da Paolo V, Camillo Borghese a Innocenzo XII, Antonio Pignatelli, di casato in casato avevano guidato la Chiesa di Roma potenti famiglie che variamente ne avevano influenzato magistero e im- magine non sempre in modo per essa onorevole: i Ludovisi, i Barberini, i Pamphili, i Chigi, i Rospigliosi, gli Altieri, gli Odescalchi, gli Ottoboni. Certo che lui, Pocognoli, “figlio di Pocognolo”, fraticello cappuccino, avvertisse l’abisso che lo separava da tutto ciò.
La malattia e la morte
Era già accaduto qualche anno prima con Anna Fiore Finaguerra di Matelica che assalita da “un rigore di malinconia così intenso” era salita a Fontebono per lucrare un rimedio, una consolazione.
Fra Giuseppe la incontrò sulla soglia della chiesa e quasi non le consentì di parlare; le bisbigliò all’orecchio un impegno che la stordì: si sarebbe caricato di metà del suo male; metà!
“Già ho penetrato l’intensione delle vostre pene – la rassicurò – e perché il liberarvene non è così facile; e restar di darvi aiuto alle viscere della carità non è mai convenevole, sia questa la risoluzione. Per sollevar voi da tante gravi afflittioni voglio prendere, e attualmente ricevo sopra di me la metà del male, che avete. Ma preghiamo Iddio, che non mi nieghi la gratia di vigorose, e sufficienti forze a soffrirlo”.
E poiché la donna, come lei stessa raccontò, fu di molto sollevata dalle sue pene, ritenne d’averne lasciato il carico al fraticello, non si sa con quale patimento.
Così pure avvenne nel giugno del 1699, quando ormai quasi ottantenne, Fra Giuseppe era per il suo obbligo della Cerca nella Villa della Castagna poco distante dal Castello di Fiuminata insieme a un Sacerdote, Padre Girolamo da Monte Alboddo; lì fu invitato a visitare Sabbatino di Chrisostomo ch’era oppresso da una gravissima infermità ed era “giudicato già vicino senza alcun rimedio alla morte”.
In una misera casa, lo accolse Santa, sua moglie, attorniata da uno stuolo di figlioli il più piccolo dei quali stacciava stancamente in braccio con muta dolcezza.
“Oh che bell’arte di supplicare – esclamò il frate – chiedere più coll’aspetto della miseria che colla tessitura delle parole…”. E c’era poco da tessere in quella situazione, la povera donna riuscì solo a mendicare un checcòsa, magari un segno di croce per la salvezza di suo marito.
Raramente Fra Giuseppe era uso dispensare segni di croce se aveva per compagno un sacerdote; ma la scena straziante che gli si offrì lo indusse ad eliminare qualsiasi tentennamento: “egli non resiste; non si scusa; non ricusa; non si astiene; non fa; né pensa fare un atto in contrario”. Ignorando il consueto rispetto gerarchico, “vide egli, e previde in un istante le gravose, e aspre miserie, che per la morte di quell’Infermo dovevano in breve sostener senza dubbio e la Moglie come Vedova desolata, e i piccoli Figliuoli come pupilli derelitti; e tutti unitamente, in restare esausti, in gran parte almeno, e di congrui alimenti, e di tutta l’indispensabile, e rigorosa opportunità di sussidi”.
Fra Giovanni da Belvedere gli attribuisce questa supplica: “Oh Signore! Questo poverello ha tanti Figliuoli, e per la poca età non sono habili, a ritrovarsi, e provedersi il vitto opportuno! Come dunque hanno da vivere privi del Padre? Eccomi pronto al loro soccorso. Coll’ abbondanza delle vostre misericordie degnatevi, di restituire a lui la salute, e trasferire a me la così grave, e pericolosa infermità, che l’opprime. Se questi muore resta misera la sua Famiglia; ma se io perdo la vita, né apporto, né posso cagionare in altri alcun danno”.
Lasciò poi la casa senza altre parole e tornatosene al suo Monastero “se ne cadde infermo”; intanto, alla Castagna, “il predetto Sabbatino hebbe ricuperata la pristina sua salute…”.
L’improvvisa infermità infieriva su un corpo stanco, provato da una lunga vita aspra e sacrificata; e la situazione s’aggravò per l’imperizia di chi provò a curarlo somministrandogli una medicina sbagliata.
Se fosse il Diavolo, come racconta Fra Giovanni, o fosse il marasma delle ultime ore, chi siamo noi per dirlo; il racconto ce lo consegna così, mentre sprofonda nel delirio che precede la morte con ripetuti attacchi convulsivi. Dapprima “il nemico infernale, l’afflisse, lo scosse, lo percosse, e lo straziò con tanta rabbia, e furore, che lo lasciò affannato, pendente, attraversato, e quasi fuori dal letto in procinto di cader con una grave e precipitosa sconciatura per terra”.
E dopo questo primo assalto, ne seguì un secondo “in tempo di notte, in cui più difficilmente poteva esser udito, e molto meno poteva esser sovvenuto da i Frati”.
“In questo nuovo assalto non contento di fargli tanti strapazzi, quanti glie nè suggerì in quel punto lo sdegno, lo precipitò furiosamente dal letto, e trascinatolo col materazzo, e colla coperta vicino all’uscio dell’infermaria, ivi lo lasciò quasi svenuto…”.
Così lo raccolse al mattino Frate Francesco Antonio da Fabriano, che aveva lo speciale obbligo d’essergli infermiere.
Anche in punto di morte, pur offeso fisicamente, con un beffardo sorriso Fra Giuseppe si vantò d’aver sconfitto ‘lu diaulu’ che in vita l’aveva più volte tormentato e gli ultimi suoi rantoli furono spesi per non dargliela vinta.
I santanatogliesi, scossi dalla notizia, s’erano da subito caricati emotivamente della malattia che nei racconti di strada, a seconda degli umori e delle attitudini dei singoli nel dare risonanza e coloritura alle voci, ebbe per più di venti giorni a gonfiarsi e sgonfiarsi della sua gravità.
La gente comune, impegnata nel gravoso compito di vivere, accolse l’annuncio dell’imminente eclissi del suo fraticello con addolorato fatalismo.
I Signori principali della Terra, abilitati a trarre giovamento anche da queste situazioni, alla notizia dell’aggravamento “posposto ogni loro benché grave interesse” furono ammessi a visitarlo e “con pia gara” chiedevano al Padre Guardiano qualcosa che gli fosse appartenuta e “con fervida divozione ricevevano in dono, chi una cosa benché vile, chi un’altra”. Anche il più semplice degli effetti personali, le cose più ‘vili’, quelle che Fra Giuseppe considerava come inutili sarselli, assumevano, in quell’ansia di rapina, un valore ineguagliabile.
“Né solamente le comuni, come corona, coltello, ruvidi fazzoletti laceri, sudarij di lana e altre simili, ch’erano il ricco tesoro della lui strettissima povertà: ma ancora un succido berrettino di tela, che attualmente riteneva in quella estrema, e necessaria urgenza nel capo”. Uno dei predetti Signori, di nascosto, riuscì addirittura a tagliargli destramente la punta del Cappuccio.
S’avvicinava intanto un appuntamento importante per il paese: la festa di Santa Anatolia. La Comunità, come di consueto, aveva iniziato i preparativi per tempo: il 21 giugno 1699 il Consiglio Generale, sotto la guida del Podestà Angelo Gregari, che pochi giorni dopo avrebbe ceduto lo scranno a Leonardo Dialti, aveva stabilito di onorare l’imminente ricorrenza patronale “conformemente al solito con celebrare detta festa con musica, messe et altri esercizi spirituali”.
Era la principale occasione in cui tutta la comunità si ritrovava e, nel nome della santa protettrice, marcava la propria identità.
Ma la mattina di quell’8 luglio 1699, l’atmosfera tipica della festa stentava a prendere corpo: si facevano sempre più insistenti le voci sull’aggravamento delle condizioni di Fra Giuseppe.
La conferma s’ebbe proprio con l’assenza dei Cappuccini dalla processione che mosse nella tarda mattinata dalla Chiesa della Pieve. Il consueto massiccio concorso di popolo, una presenza corale, composta e organizzata, in un corteo che, come sempre, prevedeva alla sua testa, dietro alle insegne comunali ed alle massime autorità, Podestà e Priori, la sfilata dei rappresentanti delle varie Arti, normalmente incolonnate secondo un gerarchico criterio di rilevanza.
Quell’anno, come da tanto tempo ormai, questa sequela era capeggiata dal Capitano dell’Arte dei Lanari a cui seguiva il Capitano dell’Arte del Fabro e quello dell’Arte dei Vasari. Affiancati, procedevano poi i tre Capitani dell’Arte dei Galligari, Calzolari e Sartori che precedevano il Capitano dell’Arte della Carta e i due Capitani dell’Arte dei Falegnami e Muratori. Chiudevano i quattro Capitani dell’Arte dell’Agricoltura.
Il corteo sciorinava le sue litanie, i suoi canti, le sue intenzioni lungo la via principale del paese, fino a raggiungere la Piazzetta di Sant’Andrea; da lì, dopo una breve funzione religiosa, riprendeva a ritroso la salita verso la Chiesa della Pieve dove poi la reliquia della patrona si celebrava con solennità.
Passando per la piazza di Sant’Agostino, dove tra i palazzi del corso si apre uno squarcio verso il monte Corsegno, lo sguardo di tutti si volgeva verso l’alto, quasi a spiare i segnali che potevano venire dal convento dei Cappuccini. E proprio mentre il corteo era sulla via del ritorno, s’udì distintamente il rintocco funebre delle campane della chiesetta dei santi Cosma e Damiano.
Era il segno.
Il corteo fu percorso da fiotti di mormorii che sommandosi e fondendosi si risolsero in un unico scomposto fremito.
Fra Giuseppe era morto!
Alcuni, senza indugio, lasciarono da subito il corteo e defilandosi per vicoli, s’incamminarono lungo la costa del Roccone per raggiungere Fontebono. Altri, dopo qualche esitazione, presero ad imitarli.
Procedendo verso la Pieve, la fila in processione andò così assottigliandosi sempre più e nel volgere di pochi minuti si ridusse al raggruppamento delle autorità che precedevano il reliquiario della patrona e allo sparuto gruppo di chierici che lo seguivano.
A frotte salì la gente inerpicandosi su per la costa della montagna invadendo in breve tempo gli spazi intorno al convento. I frati, sopraffatti da quella massa di persone, furono incapaci di agire e di affrontare la situazione.
“Il rimirar piccoli, grandi e uomini, e donne di minore conditione” riempire in un istante la chiesa “e affollarsi a vedere, toccare, e riverire quello esposto Cadavero, non cagionò meraviglia”, poiché “la gente meno avveduta con facilità si commove, e eccita a qualunque indizio di divotione senza riflettere, se sia, o non sia atto poco consigliato, e prudente”.
“Ma quando videro persone primarie della Patria, e forastieri, prudenti, e virtuosi, Sacerdoti, e Graduati, Religiosi e Secolari accorrere a venerare il Cadavero di un Fraticello, a toccarlo con riverenza, ad assistergli con devozione, a posporre ogni cura di un così sontuoso giorno, a tralasciar la propria Chiesa, e portarsi in quella de i Capuccini a celebrar le Messe per quell’Anima, e a fare dimostrazioni tali di mestizia per la perdita di quest’huomo che, non pareva, essere riconosciuta l’insigne, e celebre solennità della loro Santa, non hebbero la forza di reprimere la maraviglia….”.
Come quando a beneficio dei poveri si spargono denari con solenne allegrezza e s’assiste allo “scagliarsi, affollarsi, sospingersi, distendersi, rivolgersi e isforzarsi a raccoglierli…” da parte della turba, così non furono minori “l’industria, e l’avidità di quel popolo in procurar quanto più poteva di prendere qualche cosa ancor minima di quel Cadavero, e presala, gioirne, ascondersela, portarsela via, e custodirsela con maggior rispetto, di quanto avrebbe fatto coll’argento, coll’oro, colle gemme, e con altre varie robbe singolari, e preziose”.
L’abito fu fatto a pezzi e i pezzi più grandi contesi da una selva di mani, di braccia protese che invocavano per accaparrarsi un brandello anche minimo di quelle reliquie e garantirsi una dose di quella santità. Insoddisfatta quella moltitudine e bramosa: “desiderosa di aver cosa più immediata, e secondo il suo giudizio maggiore, e più alto pregio, tutti quelli, che n’ebbero il com- modo, gli tagliarono l’ugne delle mani, e de i piedi, gli carpirono a più potere i capelli, e per riuscire loro più facile, gli svelsero tutti i peli della barba, senza lasciarne per decenza, o discrezione immaginabile un solo”.
Il corpo del frate fu ferito anche al dito d’un piede e “stillandone vivo sangue” si gridò al prodigio e vi fu chi, in quel sangue “v’intingeva il deto, e quasi fosse stata acqua santa, vi si faceva in fronte ossequiosi, e replicati segni di Croce”.
Come già occorse al suo venerabile zio più di mezzo secolo prima, per evitare che la venerazione tributata dalla “turba ignorante” degenerasse, il corpo venne racchiuso “in una Cappella ben monita di Cancellata”; ma il poterlo solo vedere senza nemmeno sfiorare quel corpo per trattenerne il sollievo, accrebbe di tanto il tumulto che i suoi confratelli furono costretti a nascondere la salma in Sacrestia.
Il giorno successivo in cui furono fissate le esequie, “se ne volò alla Chiesa de i Capuccini, molto accresciuta la moltitudine, sì de i Paesani, come de i Forastieri”. A questa folla, che riempiva tumultuosamente la chiesa e tutti gli spiazzi intorno al Monastero, venne presentato il corpo di Fra Giuseppe “dentro una cassa munita con sigilli a istanza de i Primarij del Luogo”.
Dopo una cerimonia breve e priva di ogni ènfasi, la cassa fu calata nel sepolcro all’interno della Chiesa; alla pietra che lo chiuse toccò in sorte una levigatura per gli intensi sfregamenti, per le devote toccature che iniziarono da quel giorno e proseguirono per molti anni a venire, fintanto che la memoria venne coltivata.
Quella tomba fu meta di pellegrinaggi e alla figura di Fra Giuseppe, alla sua intercessione, furono attribuiti altri numerosi prodigi.
Voci, anche queste, che poi persero di alimento nel corso degli anni, perché tutto ha bisogno del sostegno dell’uomo, anche i sogni, le leggende, le santità.
Diversamente, certe cose tendono a nascondersi nella memoria degli uomini, a sprofondare in un limbo che sembra essere l’abisso della dimenticanza; ma non scompaiono mai del tutto, resta sempre qualche traccia, qualche pezzoletta…
Tra le mani una pezzoletta di tela marrone…
Sono io oggi che rigiro tra le mani una pezzoletta di tela marrone, un brandello di quel saio che, come si vuole, rivestì il corpo di Fra Giuseppe; una delle poche reliquie giunte sino ai giorni nostri perché conservate gelosamente da alcuni discendenti del suo casato.
Pezzolette tenute segretamente addosso sotto la divisa militare negli interminabili anni della guerra al fronte; elette a scudo contro malanni e malasorte; mostrate, seppur raramente, come reperti, talvolta come curiosità ormai svaporate. Le hanno comun que mantenute, insieme al ricordo di una storia il cui racconto si faceva sempre più sfumato.
Per me, confesso, è una particolare emozione concludere questo breve viaggio con la sensazione di sfiorare idealmente quella presenza umana che in questo periodo ho inseguito.
La propongo a me stesso come una reliquia di storia che ispira simbolismi: una ruvidezza che verrebbe da passare su tante superfici lisce e laccate di cui oggi ci contorniamo.
E la propongo come uno stimolo ad una riflessione condivisa sulla storia che sta deposta a strati sotto i nostri piedi e che dovrebbe indurci ad un passo più lieve; ricordiamolo quando ci aggiriamo per il paese, per il suo territorio, quando guardiamo la costa del Corsegno e ne percorriamo i sentieri, ed anche, e soprattutto, quando con la mano pesante di oggi, prendiamo a schiaffi le nostre vicende millenarie.
Nonostante l’allegria che sembra imperversare, viviamo tempi bui e poco rassicuranti.
Se il problema del rispetto è legato alla conoscenza, ci siamo concessi, con questo, un piccolo tassello offerto per favorirla; è sempre di più, giorno dopo giorno, un dovere civico.
Perché è pur giusto che l’ignoranza non sia considerata una colpa, ma è inammissibile che, come s’usa oggi, venga elevata a motivo di vanto e governi le sorti di noi tutti.
Per inesorabile che sia, pure il Tempo, nostro ostinato avversario,
anche se si chiama Dio, a volte indugia.
J.P. Swindler
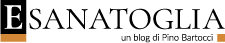


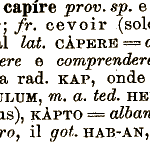







Semplicemente Grazie caro Pino
Ho appena riletto quello che anni fa avevo scorso su carta forse un pò in fretta, distratto da tanti richiami ambientali. Confesso un pò d’invidia, caro Pino, ma spero che vorrai considerarla purificata proprio dalla confessione. Vorrei avere in questa materia la felicità della tua scrittura e la profondità della riflessione storica che fai affiorare carsicamente qua e là, a collegamento e commento dei fatti. E’ facile dirti che meriteresti un uditorio numericamente più largo perché fatalmente l’argomento locale te lo preclude. Ma non ti dico che meriteresti una materia più nobile. Non esiste materia più nobile di questa. E allora capisco che proprio in essa sta la tua gratificazione dominante. L’apprezzamento esterno in questa prospettiva diventa meno importante. Cionondimeno tutto il paese dovrebbe esprimerti gratitudine e ammirazione, io, per quel poco che conta, ti rinnovo l’una e l’altra con grande piacere personale.
Mi sento estremamente lusingato dal ricevere sostegno e apprezzamento così da una persona e da un autore che gode di meritata stima per ciò che è e ha fatto (e spero continuerà a fare, vero?…). Un sovrappiù di stima da parte mia per quel tuo particolare rapporto passionale e al tempo stesso ‘solitario’ con questa nostra terra natìa, che per certi versi mi pare ci accomuni. .
Sono l’autore del commento precedente. Volevo tranquillamente firmarlo ma l’imperizia nell’utilizzo degli spazi me lo ha impedito. Mi scuso per la “coda”.
Bruno Caldarelli