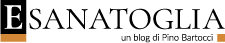Racconterò di Palazzo, a cui sono molto legato. Per un periodo della mia vita ho sognato di viverci. Nei limiti che (fortunatamente?) frenano l’ardore giovanile, ho speso anche qualche sacrificio per realizzare quel sogno. La vita ha preso poi un’altra direzione, ma quel grumo di case m’è rimasto nel cuore. Un rapporto fatto non solo di intime emozioni, ma anche di concretezza; per me ha rappresentato infatti anche una entusiasmante prova lavorativa in cui ho profuso tutto l’impegno e la passione di cui sono stato capace, promuovendo, seguendo e agevolando, in ordine: prima il salvataggio dalla condanna alla demolizione pressoché totale della ‘rocca’, poi l’intervento della Soprintendenza ai Monumenti che la scongiurò ponendo un freno al degrado, di seguito la demolizione dei capannoni prefabbricati che deturpavano l’area posta all’ingresso, infine, dopo il terremoto del 1997, l’intervento di recupero dell’intero borgo.
Materiale per raccontare quel luogo, la sua storia, le vite che ha ospitato, ce n’è in abbondanza.
Racconterò quindi di Palazzo.
Ma oggi, qui, voglio che a raccontarlo, o meglio ad introdurre ogni futura narrazione, siano parole non mie; è una sorta di traccia di racconto, seppur disposto in ‘forma di poesia’, opera di uno che veniva qui in “villeggiatura” e faceva parte della composita famiglia comunemente identificata come “li padruni de Palazzu”. E’ sagace e ironico, introspettivo e acuto osservatore sociologico, lirico quanto può esserlo il rampollo d’una classe ‘privilegiata’ che assiste allo sfaldamento del suo mondo e lo descrive in versi sciolti col garbo e il registro… verrebbe da dire d’altri tempi, ma no, preferisco dire d’un tempo superiore; riassume con bordate sferzanti le metamorfosi di un territorio e di un villaggio che, lontano dal paese (Esanatoglia, rappresenta il più vicino avamposto della civiltà…), era già quasi un corpo a sé. Parla della fine di un’epoca. Un racconto estendibile anche a realtà diverse e più ampie.

Si tratta di Giorgio Leoni che ha scritto nel 2005 “Giochi con acini succhiati” (vincitore nel 2006 della XXIV edizione del Premio nazionale di poesia“Guido Gozzano”). La sintesi, nell’ultima di copertina del volume edito da Manni, così riassume: “Poesie che corrono sul filo di una malinconia soffusa ma non incombente. Il contesto è la regione Marche e la sua società, che è mutata travolgendo i villani e i mezzadri, i padroni e i piccoli nobili, ricollocati tutti in un mondo in cui i valori di un tempo non hanno senso. E’ un libro sui relitti di un’epoca, la prima metà del Novecento, e sulle ortiche e gli spettri che crescono su essa, in orti in cui si coltivano ombre.”

Una consistente parte di queste terre di ombre, dove Leoni sa cogliere i segni di questi mutamenti, sono quelle adagiate lungo le pendici di Gemmo e Colle Puccio che fanno da cornice a Palazzo, e l’antropologia che si sovverte la ravvisa negli uomini e nelle donne che in quel villaggio resistevano ancora (dal secondo dopoguerra fino ai primissimi anni ’60), seppure in un processo di inarrestabile declino e progressivo svanimento. A volte i suoi passi e la conseguente sua disincantata analisi, si spinge fino al paese, a Esanatoglia, che con parole a volte benevole a volte aspre, prova a tratteggiare.
In molti ricorderanno Giorgio Leoni (ovviamente i meno giovani, come me) perché non disdegnava infatti di trascorrere del tempo qui tra noi. Lo ricordo, a fine anni ’60, appassionato giocatore di bigliardo esibirsi, coi suoi inconfondibili ed eccentrici straccali, nel “Bar Renzo” in cui spesso si intratteneva come ricorda egli stesso nella poesia La Tregua (“E se si indugia ancora ai tavolini / del Bar Renzo al centro della piazza / il senso prende che il luogo ti appartiene / per quel transito rado di paesani / non già intenti al pasto quotidiano.”).

Palazzo anima da subito le prime pagine del libro; viene descritto nella fase finale della sua lenta agonia e nello stato d’abbandono in cui si trovava prima degli interventi che l’hanno messo in salvo. Prima cioè che diventasse qualcosa d’altro rispetto a ciò che fu. Il recupero ha salvato gli immobili (fin dove ha potuto), e siatene convinti, è una gran cosa; la memoria della vita prima, può essere almeno parzialmente salvata (anche) da voci come quella di Giorgio Leoni che ci confermano che poesia è qualcosa di più del far grovigli di parole (favorite le più astruse, inconsuete e dissonanti) colandoci sopra melassa di aggettivi; quando non si ferma su sé stessa, la poesia, ma volge il suo sguardo intorno, vola bassa, si sporca di terra, riesce a raccontare, e illumina.
RELITTO DI VILLAGGIO
Da più che secolari fattori erosi
per essere ora diroccati
restano suggestivi spettri d’alveari,
chiusi ai perigli di svianti pensieri agli aratori,
vasi comunicanti architettati
per coloni al pari mietitori.
Con affaccio sul prospetto del relitto
dove sono i tetti più innalzati al cielo,
stavano forse per disegno funzionale,
perché più siano i campi lavorati,
i fattori che guidavano i mezzadri
ma pur sempre sotto del padrone il velo
per l’incombente, pur se prudente, magione padronale
dove il rude desco rinascimentale
di molto risale quell’assetto di stile ottocentesco.
Spuntano, da mattoni rinchiusi,
statici pretesti a tutto sesto.
Da posizione chiaramente dominante
sulle mura restanti del villaggio
gli s’oppone dalla parte prospiciente
la casa del colono del pievano
cui fanno corona le topaie
d’altri cristiani sfuggiti alle fatiche.
Seppellito da ortiche il tratto si diparte
di un preteso interno corso di paese
munito di piazza belvedere
dove era, un non lontano giorno,
di teglie e pani cogestito un forno.
Anche la chiesa, che è alla stessa quota
della riattata casa proprietaria,
resta nascosta tra gli sterpi e i rovi.
I segnali del culto più non trovi.
Più d’un’immagine d’infanzia si condensa
città-montagna rocca fortilizia
dove dimora non è riconoscibile
di me notabile rampollo gentilizio.
Muri di rupe stabbio-pavimento
d’altri tuguri non v’è discernimento.
Padron mi sogno invero contadino:
nell’uno e l’altro pavento indifferenza.
Diviene il villaggio una profonda mole
dove stradelli sono corridoi
come sospeso fosse su una valle
dove vedi traverso feritoie
e passando odi le parole
che il mezzadro scambia con la moglie.
Ogni bambino è sempre lì che attende.
Anche il villano gli compare grande.
Orto coltivato a ombre
Ciò che colpisce in questo sito d’ombre,
piccola pertinenza della casa,
è l’assenza assoluta delle tracce
di ciò che fu trionfo di rigagnoli,
opere idrauliche fondate in dislivelli.
Pure dissolti i legni del frutteto
Prima esperienza di moto a perpendicolo,
magri supporti d’affari ortofrutticoli.
D’estate
Ecco sovvien d’estate un sentimento lieto
Riaffiora ricordo d’esperienza obsoleta
Segregazione in colle d’avite possessioni
Al fine d’imparare le dure procedure
Lontano da plaghe erotico-corsare.
Sta il benedetto mare a valle del filare
Dal clivo in vista coperto dall’ulivo
Un piccolo schivo albero campagnolo
Ecco come miraggio d’un incipiente oltraggio
Contro le architetture di case cantoniere.
Un rammendare reti di genti marinare.
S’impiccava
Restò il festivo rito mattiniero
Finché fu economica l’impresa del villaggio,
socialità solo da un lato intesa
dove quel fine si tramuta in mezzo
nell’inconscio intento del padrone.
Mondo dove nessuno più dell’altro soffriva
Se non fosse per Sante, il mezzadro,
che contro l’assunto, appunto, s’impiccava.

Il libro è tutto da leggere. Parla di Palazzo, di Esanatoglia e di esanatogliesi. Parla di noi. Non è usuale avere letteratura che ci riguardi così direttamente.
Torneremo a parlare di Palazzo…