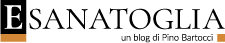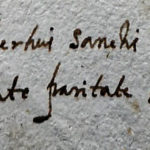Vivo questo presente di isolamento pensando a come potrà (dovrà?) cambiare il nostro futuro. Sento stimoli propositivi che ritenevo in me ormai sopìti, prossimi all’estinzione. Cerco di dare nutrimento alla speranza anche perché ho tra le braccia un nipotino di appena un mese. Sento di doverglielo. Giro e rigiro (anche per raggirare il tempo dilatato che, bontà sua, pare ancora accettare l’inganno) astrazioni e materialità a immaginare possibili scenari ma anche a cercare di capire quanto passato ci sia in questo presente. Gli appigli materiali (oltre al piccolo Alessandro) sono principalmente carte, libri scarsamente letti, scartafacci impolverati, testimonianze tratte da poco attendibili scartabelli ma anche da atti ufficiali, vecchi documenti, in particolare di questa terra in cui vivo. Pur essendo poco il materiale che in questo momento di isolamento posso consultare, mi permette comunque di voltarmi indietro e ingarbugliarmi un po’ nel ripassare il passato. Per me è esercizio utile. Provo a darne conto.
Rimaniamo in argomento ricordando che tra morbi, pestilenze e infezioni varie, la strada fin qui percorsa dall’umanità è lastricata di endemie, epidemie e pandemie che, ora più ora meno, hanno falcidiato i popoli colpiti in ogni parte del pianeta.
Senza andare tanto indietro nel tempo (e scavalcando la terribile pandemia di ‘febbre spagnola’ che, giusto un secolo fa, si sommò ai lutti della ‘Grande Guerra’: da noi le vittime, tra tutto, furono un centinaio, il 5% della popolazione), fermiamoci, a titolo d’esempio, su quanto vissuto dai nostri trisavoli e bisnonni che, in diversi periodi dell’800, ebbero a combattere un nemico micidiale di cui era appena nota l’esistenza ma si ignoravano ancora cause e rimedi: il colera.
In quel secolo, solo in Italia, vi furono ben sei pandemie di colera. Caliamo l’attenzione nel microcosmo esanatogliese (al tempo ancora santanatogliese), per uno stralcio di racconto appena, magari da approfondire quando ci sarà modo, sulla pandemia del 1835-1837, la prima.
Un assaggio: si gonfiavano testicoli e mammelle
Al primo appuntamento con il morbo asiatico (così era definito il colera), i santanatogliesi, per lo più legati in qualche modo alla terra, alla montagna, all’acqua e mediamente di sana e robusta complessione, giunsero in gran parte già fiaccati.
Il caldo dell’estate del 1835, che fu assai intenso, svanì precocemente nel giro di pochi giorni. A metà ottobre si era già sprofondati in un inverno che fu lungo e freddissimo.
Anche questa bizzarria del clima, insolitamente ostile, fu ritenuta una delle cause dell’epidemia che interessò esclusivamente il nostro piccolo borgo e che meritò d’esser menzionata nella fondamentale e monumentale opera di Alfonso Corradi “Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850” (edito a Bologna nel 1865).
Nel quarto dei cinque volumi, che citeremo anche in seguito per le illuminanti sintesi che contiene, l’illustre cattedratico bolognese così riassunse la vicenda che ci riguardò:
“Dall’ottobre 1835 al Maggio successivo in Santa Natoglia di Camerino, corse un’epidemia di parotiti; persone di ogni età e sesso ne vennero colpite in buon numero con i sintomi consueti: frequentemente i testicoli divenivano gonfj, con molto dolore e con febbre ardita; e così pure le mammelle nelle donne: parve al medico di quel luogo che spesso, ed anzi le più volte, il morbo facesse impeto particolarmente al pancreas destandovi vera infiammazione.”.
Un Medico Condotto: un uomo di scienza
La notizia era desunta dalla relazione che il nostro Medico Condotto, il recanatese Filippo Conti, si peritò di fare a epidemia cessata, e che venne pubblicata sia nel volume 3° serie 2° del“Bullettino delle Scienze Mediche” edito nel 1837 dalla Società Medico-Chirurgica di Bologna, sia nel “Giornale arcadico di scienze lettere ed arti”, Tomo LXXI, edito a Roma sempre nel 1837.
Così iniziava il resoconto della sua diretta esperienza che, evidentemente, interessò non poco il mondo scientifico: “Dall’ottobre 1835 in quest’illustre terra di S.Natoglia dietro un rapido cambiamento di rigida atmosfera (per cui il giorno 18 ottobre la neve coprì in notabil copia e le cime dei monti, e le sottoposte valli), fino a tutto maggio 1836 sviluppò una costituzione epidemica di parotiti, che indistintamente attaccava persone di ogni età e di ogni sesso in numero vistoso”.
Per diversi mesi, il nostro medico ebbe a che fare perciò con oltre duecento malati colpiti da una infezione virale, la parotite, che “per attacchi, andamenti, progressi e diffusioni” si riteneva conosciuta, ma che nell’occasione veniva a destare somma preoccupazione (ma anche notevole interesse scientifico) per il coinvolgimento del pancreas (“..per essersi in ispecial modo trasportata la flogistica ascensione alla glandola pancreatica apporterà utili schiarimenti alla patologia di quest’organo”). Furono quindi ingrossamenti di testicoli e mammelle e fino a 20 vomiti al giorno “con rutti acidi acquosi e limpidi, dipoi vomiti decisi accompagnati sul primo da materia alquanto giallastra spumosa ed infine biancastra fluida con sapore salino”.
“Il calomelano unito al diagridio…”
La cura consisteva in “salassi ripetuti generali e locali, il calomelano unito al diagridio, le preparazioni di ossido di ferro nero e di etiope marziale, il tamarindo, l’aloe, le infusioni di rabarbaro, la magnesia, e l’ossido di Bismut a rifratte dosi, infine la soluzione di muriato di Barite”. Il tutto adoperato, stando a quanto lo stesso Conti afferma, “con felicissimo successo”. Questo era quanto offriva allora la scienza medica. Con queste cure, il Medico Condotto otteneva il “ristabilirsi a poco a poco le funzioni dello stomaco”. Gli ammalati piano piano miglioravano, testicoli e mammelle si sgonfiavano, le bocche tornavano a salivare con regolarità. Due settimane per il picco dei disturbi; nel giro di un paio di mesi si era fuori pericolo.
Il male se ne va
L’epidemia scemò del tutto solo verso la fine del maggio 1836. La relazione non accenna a vittime, il che induce a pensare che non ve ne furono (ma sarebbe da accertare). Si immagini comunque lo sforzo di curare, con le risorse umane e materiali di allora, quel numero elevato di ammalati; e si pensi alle condizioni generali di gran parte della popolazione, anche di quella che non patì direttamente il male ma che dovette ugualmente sottostare, per così lungo tempo, a controlli e privazioni.
Poi il colera asiatico
Nel 1817 il colera, una presenza endemica in India, in particolare nel delta del fiume Gange, aveva cominciato la sua lenta ma inesorabile espansione al seguito della sempre più dilagante rivoluzione commerciale e dei trasporti.
Ovunque, ogni zona che veniva raggiunta pagava lo scotto dell’impotenza davanti a un nemico sconosciuto e anche della sottovalutazione iniziale del pericolo. Quando già aveva raggiunto le maggiori città europee, anche in Italia, come era successo altrove, si riteneva che il morbo non sarebbe mai giunto. Giacomo Leopardi, che morì forse proprio di colera nel 1837 a Napoli, scriveva da Firenze nel 1832 che la previsione dell’arrivo del colera da Parigi era “una predizione di cui ridono i medici di qui, perché non ci credono”.
Invece già dal luglio 1835 il contagio penetrò in Italia. Dal nord-ovest iniziò la sua discesa.
In Lombardia ad aprile cominciò già a fare strage; a settembre del 1836 su 60.000 persone colpite ne sarebbero morte 32.000. In Veneto si contarono 22.000 morti. Dopo la sottovalutazione, l’atteggiamento comune in ogni luogo lo descrive bene il Corradi in una sequenza che suona come una formuletta mnemonica applicabile a diversi scenari: “Ovunquev’ebbero dubbiezze, contrasti, scherni e popolari irritamenti nei primordj del morbo, cui susseguirono il terrore, le fughe, i pentimenti e le divozioni; ultima la calma e le cautele, che avrebbero dovuto esser prime”.
Il contagio raggiunge Ancona
Un focolaio importante scoppiò ad Ancona. Il contagio non avvenne a causa di “una nuvola nera pregna d’insetti che fu vista innalzarsi dalla marina come denso fumo” come favoleggiava una ‘fake’ dell’epoca (e ve ne furono innumerevoli altre e non solo ad Ancona).
Attesta il Corradi che “Ad rendere sempre più difficile l’opera della medica polizia si aggiunse la credenza nel volgo che la pestilenza provenisse da veleni sparsi da scellerati e per suggestione degli stessi Governanti. Questa voce che agitò le plebi nell’antichità, nel medio evo, nel seicento, si fe’ di nuovo sentire nel bel mezzo del secolo XIX da Pietroburgo a Parigi, dal Piemonte alla Sicilia, da Genova a Roma.”. Addirittura “nel bel mezzo del secolo XIX…” sottolineava il dotto Professore! Potremmo proseguire…
Il Governo Pontificio era già allertato e tra i primi incerti provvedimenti, per tentare di porre un argine alla diffusione, aveva deciso di annullare la annuale Fiera di Senigallia. La Fiera, che durava anche quattro settimane e godeva di franchigie e benefici economici vari, costituiva uno degli appuntamenti commerciali più importanti del bacino dell’Adriatico, era perciò frequentatissima e rappresentava perciò un notevole rischio per la propagazione del contagio. A contrastare questa scelta, oltre alla Municipalità della stessa Senigallia, anche componenti dello stesso Governo Pontificio più attenti agli aspetti economici che a quelli sanitari. Annullarla era un colpo troppo pesante all’economia di quella città e del circondario. Dopo lunghe trattative, alla fine si adottò una linea di compromesso: per salvaguardare l’aspetto economico si decise di mantenere la Fiera ma… allontanandola un po’ dal fronte delle Romagne dove era stata già segnalata la presenza del contagio.
Nonostante le energiche proteste dei senigalliesi (pare si mosse anche il Cardinal Mastai-Ferretti futuro Papa Pio IX e al tempo Vescovo di Imola) e il parere contrario di qualche dotto consigliere del Papa che la ritenne una scelta irragionevole, la Fiera si fece quindi ad Ancona.
Per un mese confluirono quindi nella città dorica, via terra e via mare, provenienti da ogni dove, persone e merci che liberamente circolarono e, inevitabilmente, diffusero il contagio, in particolare nelle zone della città dove le condizioni igieniche e ambientali erano più lacunose.
Ancor prima di metà agosto, con la Fiera in corso, si cominciò già a parlare della presenza del colera in città. Fu subito guerra tra le diverse ‘scuole di pensiero’, tra chi minimizzava, che erano maggioranza, e chi metteva allarme.
Tralasciamo le diverse teorie in campo sulle cure, perché è una rassegna illimitata e richiederebbe un lungo discorso a parte. Citerei soltanto il Medico-Filosofo perugino Cesare Massari teorico del principio che nei mali epidemici “meglio fare è il men fare” che confidava nel fatto che il colera si sarebbe acclimatato da noi “e allora si parlerà di cholera come oggi si parla del vajuolo, della scarlattina e della sifilide: le prime loro stragi si perdono nel corso rapido del tempo, e la memoria le ricorda senza soffrirle col mezzo della storia o della tradizione.” (“Saggio sulle pestilenze di Perugia” Perugia, 1828).
La scienza arrancava e le teorie si scontravano. Parafrasando quanto detto dal Corradi per “le credenze del volgo” potremmo dire, rimaneggiando la sua prosa, che “Ad rendere sempre più difficile l’opera di soccorso si aggiunse la discordia della Scienza Medica circa la cura. Tale dissidio che agitò li Medici nell’antichità, nel medio evo, nel seicento, si fe’ di nuovo sentire nel bel mezzo del secolo XIX da Pietroburgo ecc. ecc.”. Anche questa una costante.
“Al solito incominciarono le quistioni se era tale [il colera] fra i Medici di quella Città” come ci ricorda anche il Prof. Antonio Grillo nel suo “Ragionamento sul colera asiatico in occasione della sua invasione in Napoli” (Napoli, 1837) riferendo che mentre era in corso l’appassionante dibattito, essendo morto il capitano d’una imbarcazione (un trabaccolo) di Trani, il colera lo sostituì salpando verso il sud. Nei fatti accadde che di quell’equipaggio “un marinajo s’infermò ancora, ed i compagni conscii delle mediche quistioni in città, profittarono del momento favorevole e partirono col trabaccolo per la loro Patria”. Questione di giorni e “In Trani principiarono ad apparire casi sospetti…”. E così di seguito. Raggiunse Napoli dove si contarono 5000 morti.
Il Medico anconetano che per primo si rifiutò di tacere e chiamò il male col suo nome, lo stimatissimo Prof. Lorenzini, fu per questo avversato, attaccato da più parti con violenza, come se lui stesso fosse l’artefice del male. Proprio lui, che di colera morì nel giro di pochi giorni, e si racconta che venne addirittura oltraggiato perfino nella bara durante la sua tumulazione.
Ancora il Corradi: “In Ancona non si volle credere al pericolo, e pertinacemente negavasi il contagio; ingiuriati i medici che l’avvertivano; niuna bastevole cautela contro i primi casi, i provvedimenti successivi, né confacenti, nè concordi o collegati, e perché tardi, inefficaci.”
Il primo caso acclarato, inequivocabile, pare sia stato del 16 agosto. Non si poté più far finta di nulla.
Nel giro di pochi giorni Ancona si svuotò, cessarono di colpo gli affari, sparirono venditori e acquirenti. Il colera era arrivato e iniziava, più corretto dire proseguiva, a mietere vittime (nella città se ne contarono quasi mille). Vennero disposti i cordoni sanitari per isolare la città dall’entroterra.
A Santa Natoglia…
Noi eravamo, come s’è visto, già fiaccati dalla precedente epidemia e nel frattempo ci si era anche dovuti preoccupare di un’altra delle frequenti epizoozie. S’erano ammalati infatti molti bovini della zona di Pagliano. Cosa non da poco: al tempo, si diceva che “‘na vèstia condàa quandé ‘n cristianu” (ritengo, purtroppo, contasse anche di più). Ma passò anche questa e si andava avanti.
Fu in questo quadro che giunsero le notizie provenienti da Ancona; da subito ci coinvolsero non solo emotivamente, ma anche direttamente. Bastò un passaparola per diffondere la noa che due santanatogliesi se n’erano appena tornati da quella Fiera che, ormai era chiaro, poteva fare da detonatore allo scoppio dell’epidemia nella Marca Pontificia. Si trattava di un tal Tomasso Bartocci e di suo figlio, contadini che abitavano a Chiusìa.
Appena la notizia fu ufficiale, il 26 agosto in piena notte, l’Agente Comunale venne spedito a Matelica per informare il Governatore Marchese Avvocato Francesco Patrizi, alla cui autorità al tempo si sottostava, e ricevere indicazioni sul da farsi. Per bocca del suo inviato, la Comune di Santa Natoglia invocava da subito, prima ancora che dotazioni sanitarie, l’istituzione di una Guardia Civica, non solo per mettere sotto controllo i due “reduci da Ancona” e tutti i loro familiari, ma per garantire l’ordine pubblico in generale.
Scatta l’allarme
Il giorno dopo, un lungo proclama venne srotolato e affisso nel Palazzo Comunale e il suo contenuto, insieme all’allarme per il pericolo, si diffuse rapidamente di bocca in bocca.

Recava la firma del Priore Comunale nonché Presidente della Commissione Sanitaria Comunale, Benedetto Brasca Bartocci. Era controfirmato dal Governatore Patrizi e così esordiva: “Le imperiose circostanze delle nostre contrade sul temuto Cholera Asiatico seriamente richiamano l’attenzione e vigilanza delle Autorità onde sono con precisione affermate le cautele e disposizioni in proposito emanate per allontanare possibilmente le funestissime conseguenze, come dall’Editto della Suprema Segreteria di Stato del 18 corrente viene inculcato”. Con l’occasione, venivano replicate le disposizioni che il 30 agosto dell’anno precedente erano state diramate dallo stesso Governatore di Matelica.
Norme di igiene generiche che andavano dal divieto di gettare o abbandonare rifiuti lungo le strade, allo smaltimento del letame, dalle modalità di vendita del pesce, all’obbligo “fino a tanto che l’Amministrazione Comunale non avrà appaltato la scopatura delle strade” di scopare ciascuno il tratto di strada prospiciente la propria abitazione, fino al divieto di immergere qualsiasi oggetto, che non fosse la brocca, nelle fontane pubbliche.
I primi provvedimenti
Domenica 28 agosto è convocata la Commissione Sanitaria Comunale. Oltre al Priore Benedetto Brasca Bartocci che la presiede, sono presenti il già richiamato Medico condotto Filippo Conti, i Deputati Sanitari Ascanio Censi e Don Gaetano Mataloni, nonché Don Biagio Rossolini Parroco di San Martino.
Per prima cosa si decide di individuare un luogo dove poter ospitare i colerosi in caso di necessità: un Lazzaretto. Si propone da subito un’ala del Palazzo Comunale. Si pensa poi di riservare, per le eventuali sepolture, una zona appartata del Cimitero la cui costruzione da anni procedeva a stento intorno alla Chiesa della Madonna di Fontebianco. Infine si decide di chiedere formalmente l’istituzione di una Guardia Civica, ovvero una forza di Polizia, una milizia temporanea (la cui spesa che sarebbe stata a carico del bilancio governativo) per garantire l’ordine e coadiuvare le autorità nella gestione della crisi.
Nel pomeriggio, la Commissione intera esce dal Palazzo e si trasferisce alla Spezieria di Raffaele Pelagalli (detto “lu Mercante”) per verificare la dotazione di disinfettanti e medicamenti. Sono segnali per chi assiste, per la gente che è in giro, che riferisce, amplifica: si stanno muovendo.
Si chiudono le porte. Si circondano i “sospetti colerosi”
Intanto si organizza il Cordone Sanitario locale: ci si asserraglia. Il paese riscopre, immaginiamo con inquietudine, il senso del castrum fortificato.
I lavori avranno inizio il 29 agosto, lunedì. Vengono chiuse quattro delle porte di accesso al paese: la Portella (o Porta del Molino), importante per il traffico di merci e derrate grazie anche alla presenza della pesa pubblica di San Martino; la Porta del Macello (ovvero San Sebastiano) che s’affacciava anch’essa sulla zona dei molini; inoltre le recenti Porta Nuova, che era stata aperta appena una sessantina di anni prima ritenendo ormai superata la logica della cinta muraria, e Porta del Fosso aperta dopo la bonifica della zona con l’interramento del canale che vi scorreva. Sugli ingressi principali di Porta S.Andrea e Porta Panicale ricompaiono le chiusure che erano state tolte quasi due secoli prima. Pare fossero cancelli un tempo, ora in fretta e furia lavorano alacremente il falegname Filippo Pacini e il fabbro Antonio Ubaldini a restituire due portoni, che abbiano un minimo di dignità, agli ingressi che saranno presidiati dalla Guardia Civica.
Sotto la direzione del Capomastro Fedele Cappanna, detto “lu Ciucu, e di suo figlio Giuseppe, inevitabilmente detto “lu ciuchittu”, si misero all’opera muratori, artigiani e manovalanza varia. In due giorni, oltre a due artigiani, furono impiegati 5 muratori 4 facchini e 7 facchine (“le manovale”), più “un bifolco con carro” che trasportò materiali vari, tra cui un “migliaro” di mattoni e 22 “bigonci di calce”.
La Portella viene chiusa murando una vecchia porta riattata che poteva esser chiusa dall’interno. Così pure per le altre porte. Porta Nuova invece, non si capisce perché, proprio murata (forse perché prospiciendo verso la piana doveva offrire maggiori garanzie di tenuta). Porta S.Andrea e Porta Panicale di giorno presidiate da sentinelle e di notte chiuse. Ci penserà la Guardia Civica che viene attivata il 30 agosto. A Raffaele Buscalferri, nominato “Capoposto”, vengono date in dotazione 2 libbre di polvere da sparo e 2 libbre di munizioni terzarole “per caricare li fucili delle Sentinelle”. Vengono armate due Guardie Campestri, Antonio Gasparri e Antonio Tozzi (detto “Melone”), che vengono spedite a controllare “i sospetti colerosi”. Per i fatidici 14 giorni, ininterrottamente notte e giorno dandosi il cambio, vigileranno per isolare tutto il complesso di Chiusìa.
Bruciare e.. pentirsi
Il primo di settembre, mentre la Delegazione Apostolica di Macerata stava assumendo le sue decisioni sulle proposte del 28 agosto, si riunisce di nuovo la Commissione Sanitaria Comunale.
Per il momento due porte sono state chiuse, si stanno ultimando le chiusure dei due ingressi principali che sono piantonati; sotto controllo il borgo rurale di Chiusìa con tutti i suoi abitanti.
Si fissa, per il giorno successivo, l’inizio delle visite alle abitazioni di tutto il paese per verificarne la situazione igienica.
Sabato sarà la volta di stalle, spazi pubblici, strade. Incaricato è il Consigliere Giuseppe Marini.
Si viene poi ad una richiesta espressa da quella che potremmo definire la componente scientifica del consesso: “Hanno opinato i Sigg. Fisici di provvedersi una quantità di Cinebri [sarebbero i Ginepri] e altri legnami per incendiarsi nelle pubbliche strade. Riguardo ai Cinebri dovrà dei manuali a ricavarli dalle montagne, e per le Fascine saranno periodicamente raccolte dagli abitanti e questo temperamento da porsi in esecuzione pentendosi (Dio non voglia avvanzarsi il Malore Asiatico per le nostre contrade, o sviluppandosi nel Comune). Li medesimi Professori hanno fatto istanza di provvedersi di Camigiotti di Taffetano incerato, per loro uso, senza i quali non potrebbero prestarsi alla circostanza.” A qualcuno, a cui mi associo, potrebbe risultare stridente l’immagine di un Filippo Conti, ammirato per il suo metodo scientifico sperimentale che lo aveva accompagnato nell’esperienza dell’epidemia di parotite, che sottoscrive insieme agli altri “Sigg. Fisici” la richiesta, non tanto di bruciare i “Cinebri” (prevaleva all’epoca l’idea del miasmo ovvero dell’aria contaminata, ignorando che il colera si diffondeva invece in tutt’altro modo) quanto di farlo “pentendosi”. Ma tant’è.
Proseguendo sull’aspetto scientifico, vennero stabiliti i medicinali di cui era necessario dotarsi:
Disinfettante di Morveaux 30 bottiglie
Clorugo di calce 20 libbre (?)
Aceto medicinale 2 some
Medicinali:
Acque aromatiche di Aranci, Menta, Melissa 10 libbre
Erbe aromatiche Menta, Camomilla, Melissa, The in tutto 20 libbre
Olio di ricino 15 libbre
Solfato di Chinino 6 once
China scelta gialla 6 libbre
Acetato di Morfina ½ oncia
Olii essenziali 10 libbre
Senapa 70 libbre
La risposta del potere centrale…
Il giorno dopo, mentre erano in corso le ispezioni alle abitazioni, utili anche a gettare uno sguardo sulla condizione di salute degli occupanti, giunse un dispaccio con cui la Delegazione Apostolica di Macerata rispondeva alle richieste della Commissione del 28 agosto.
In attesa di chiarire la collocazione precisa, veniva sospesa la decisione di allestire il Lazzaretto nel Palazzo Comunale in quanto era considerato rischioso “perché troppo contiguo all’abitato”. Si approvavano le altre disposizioni riguardo alle sepolture al Cimitero e al piantonamento dei “sospetti di Chiusìa” ma a chiare lettere si respingeva la richiesta di istituire una Guardia Civica “potendo servire per l’osservanza delle disposizioni date dalla Commissione Sanitaria la forza dei Carabinieri, tanto più che essendo ormai stato rinforzato per Ordine Superiore il Cordone Sanitario, che cinge Ancona, ed una parte del suo Territorio, niuna provenienza potrà esservi da quel luogo.”. Pertanto il Governatore Patrizi, che era solo un tramite alle decisioni della Delegazione di Macerata, è costretto a ritrattare la parola data: “Conoscerà da ciò – scrive quindi al Priore – quali siano le Superiori intenzioni, e che resta in tal modo sospesa l’attivazione della Guardia Civica, di che in proposito l’aveva io provvisoriamente autorizzata.”
Ma ormai la Guardia Civica si era di fatto già costituita e aveva già effettuato i primi servizi. Continuerà poi ad operare, seppur non come tale, a completo carico del Comune e a servizio della collettività ma, nella sostanza, da ‘fuorilegge’.
Infine la Delegazione Apostolica teneva a precisare, qualora non fosse chiaro, che il conto di tutto ciò sarebbe stato da affrontare con i fondi del bilancio comunale; tutte le spese, dettagliate e accantonate, sarebbero potute servire, al massimo, per un eventuale riparto “quando dovesse aver luogo per spontanea elargizione” da parte dell’Autorità Governativa.
Anche questa non era una bella notizia, ma riguardava tutte le municipalità. Si decise allora che per l’emergenza sarebbe stato utilizzato l’importo di 100 scudi, accantonato in bilancio per la sistemazione delle strade.
Il Medico a cavallo
Dopo l’ispezione dei negozi e attività commerciali del sabato, la domenica, il 4 settembre, in groppa alla cavalla presa a nolo da tal Niccola Pedica, il Medico Filippo Conti raggiunse Chiusìa; assistito a distanza dalle sentinelle armate che presidiavano la zona, e incapsulato e incappucciato con l’ingombrante “camigiotto di taffetano incerato” visitò sia i due “reduci d’Ancona” che i loro familiari e quant’altri si trovavano lì: due famiglie, una ventina o forse più di persone, garzoni compresi. Non trovò sintomi riferibili al colera. Almeno per il momento, si poteva tirare un sospiro di sollievo. Ma l’isolamento sarebbe continuato e sarebbe servito ancora il controllo. Per questo divenne urgente chiarire la questione della Guardia Civica che era ancora rimasta in sospeso nonostante alcuni cittadini fossero autorizzati a girare armati per il paese.
Perché noi no ?
Il 6 settembre parte dal Comune una vibrata protesta indirizzata direttamente alla Segreteria di Stato di Roma: “… la forza dei Carabinieri. Ma dov’è questa forza della Brigata di Matelica se apparisce e sparisce in due o tre al più individui come il baleno? Come si possono sorvegliare li contumaci reduci d’Ancona? Come può invigilarsi sulla circolazione delle persone che tutto di’ prendonsi a vagare, nonostante li rinforzi ai Cordoni Sanitari provenienti dalla Città infetta? Per qual ragione le altre Comuni convicine, e la stessa Città di Matelica ove esiste Brigata di cinque Carabinieri, si permette la Civica suddetta ed a questa Comune viene denegata, ove le circostanze comuni indicate non è scarso il Commercio di Carbone, delle Conce e delle Cartiere per le quali giornalmente pervengono estere persone? “. Non pare sortì effetto alcuno.
Intanto da Ancona giungono notizie di centinaia di morti (alla fine ne saranno quasi un migliaio) e qualche vittima sembra esserci anche in Comuni dell’entroterra. Sale l’allarme.
La scelta del Lazzaretto
Il 7 settembre si riunisce di nuovo la Commissione Sanitaria Comunale. Un plenum. Sempre presieduta dal Priore Benedetto Brasca Bartocci, oltre a Censi, Don Mataloni, Don Rossolini e il Medico Filippo Conti, sono presenti Don MichelAngelo Pelagalli (Parroco della Collegiata di San Martino), Don Luigi Moroni (Parroco della Villa di Palazzo), Giuseppe Marini (Deputato Sanitario) e il Dottor Lavinio Zannoni, Chirurgo Condotto.
La Commissione viene messa al corrente delle decisioni dell’Apostolica Delegazione e replica prendendo queste decisioni:
Innanzitutto si riconsidera la destinazione del Palazzo Comunale a Lazzaretto per i colerosi. Si ammette che “la nuova fabbrica del Comune manca di finestre e porte” mentre “il vecchio Palazzo racchiude la Residenza della Magistratura, la Segreteria Comunale, l’Archivio notarile, il Monte Frumentario, il Monte di Pietà e le pubbliche Scuole”.
Il luogo certamente non è adatto. Una alternativa ci sarebbe stata fin dall’inizio: un “casino fuori dal Paese” di proprietà del Sig. Vincenzo Fantini, ma il proprietario s’era in un primo tempo rifiutato di metterlo a disposizione. Ora “però conosciuta dallo stesso Sig. Fantini la ragionevolezza della cosa, che il particolare deve cedere al pubblico comodo, per connaturale suo interessamento al bene della patria dichiarò sormontare dalla fatta sua opposizione cedendo il suddetto di lui Casino all’oggetto sudisposto”. Si decide quindi per questa soluzione.
Un aiuto dall’alto
La Comune di Santa Natoglia era quindi pronta. Un Lazzaretto per ospitare i contagiati: individuato; un Cimitero per seppellire i morti: a disposizione; una sorta di Guardia Civica armata per mantenere l’ordine: attivata.
Mancava solo garantirsi un aiuto dall’alto.
Si provvede. Viene deciso di celebrare un Triduo in onore di San Cataldo comprotettore.
Tre “scopatori” vengono spediti “a riattare la Strada del Monte Corsegno ” perché l’8 settembre, smesso il guazzarone da muratore e indossata la livrea, Fedele Cappanna (sì, sempre lui, “lu Ciucu”, che oltre a fare il Capomastro assume all’occorrenza anche il ruolo pubblico di Famiglio, un sorta di messo, factotum cerimoniere pagato a prestazione) scorta il Parroco di San Martino fin su all’Eremo insieme ad Antonio e Camillo Leoni, evidentemente gente tarata alla fatica, per prelevare la Statua stessa di San Cataldo e portarla giù in paese. Come avveniva anche per la discesa della Reliquia in ogni maggio, il grosso dei fedeli attese all’altezza della Chiesa di San Rocco. Da lì si formò la vera e propria processione che depose la Statua del Santo nella Chiesa di San Martino.
Dal 9 all’11 settembre, visite, rosari e preghiere, in una chiesa schiarita dal consumo di diverse decine di chili di cera sotto forma di cannéle, fàrguli e fargulòtti, poi il giorno successivo il Santo fu trasferito alla Chiesa della Pieve per una “Messa Parata” (ovvero con la chiesa solennemente addobbata e con i paramenti sacri più sfarzosi).
Il tutto mentre in paese, lungo la via principale ma anche nei vicoli laterali dove gli slarghi lo permettevano, fin dal pomeriggio ardevano qua e là focaracci di fascine su cui si facevano bruciare rami di “cinebro per li fuochi disinfettanti”. Su incarico della Commissione Sanitaria, boscaioli di razza come Cataldo Marinelli e Sante Ghitarrini, ne avevano tagliati in gran quantità pressandoli nel biroccio di Nicola Tozzi, tanto da farne due viaggi e distribuirli per le strade.

A trasformare questa ritualità in un evento ancor più straordinario, oltre allo sciogliersi delle campane, concorsero anche le esplosioni propiziatorie che sgomberarono in un attimo le colombaie del paese: i “Micheli bombardieri”, praticanti artificieri, furono compensati con 20 bajocchi “per aver eseguito lo sbarro” (lo sparo, una serie di esplosioni di polvere pirica prive dello scintillìo degli effetti pirotecnici). Mancava la musica e sarebbe stato come alle solennità in onore della Santa Patrona Anatolia.
Di più non si poteva fare. Il fervore eguagliava il terrore.
Il giorno dopo la Statua di San Cataldo riprese la strada del Corsegno e se ne tornò dietro la pesante grata all’Eremo: nel riepilogo delle spese, in questo caso, non v’è traccia di compensi per livree o altre incombenze. Un’unica voce, d’una mestizia dissonante col clamore che era appena svanito, ma riporta un po’ il racconto a terra: “ 13 settembre – Per vino passato a quei che hanno riportata la Statua del Santo al Monte…. bajocchi 17,5”.
Il fervore religioso ebbe anche una coda. In maniera più sommessa il 24 settembre sempre a San Martino venne celebrata una “Messa Solenne” con l’esposizione della Reliquia di San Rocco. Meno di due scudi costò il tutto. Quasi un atto dovuto al Santo protettore dalle pestilenze e a cui era dedicata la Chiesa ormai in rovina vicino a “lu Jócu de lu palló”.
Una perplessità sorge dal sapere che, una ventina d’anni dopo, precisamente nel 1865, durante la terza pandemia di colera (della quale per ora non so altro), non a San Cataldo ci si rivolse per l’occasione, né alla Reliquia di san Rocco, ma, come s’usa in un nostro tipico modo di dire, direttamente a “Cristu ‘n croce”.
Fu infatti l’imponente e austero Crocefisso ligneo di Sant’Angelo che venne portato in processione fino a San Martino (sul cui altare maggiore oggi troneggia) “per domandare ed impetrare la grazia che il Popolo di questo Comune resti salvo ed immune dal morbo asiatico”. Chissà perché.
A questo punto cominciano a mancarmi i documenti e le testimonianze. Mi riprometto di approfondire la ricerca che ormai mi ha irretito.
Mi capita tra le mani solo qualcosa per un rapido ultimo flash. Siamo già nell’ottobre del 1837, pur non sapendo degli sviluppi, dal fatto che in un documento di questa data, quindi un anno dopo, ancora si parlasse di allestire il Lazzaretto (il cui nome s’era addolcito in “Casa d’Osservazione”), nel Casino di Vincenzo Fantini a Calle, si dovrebbe arguire che tanti problemi nel frattempo non dovrebbero esserci stati.
Ma l’allarme evidentemente era ancora alto e i nervi tesi.
Un accenno di tumulto
E’ la sera del 2 ottobre 1837. Tre mesi prima della fine dell’emergenza. La gente è stanca ma, nell’affanno quotidiano, cerca di ritagliarsi qualche spazio di vita sociale. Ascanio Censi, che è ancora Consigliere e Deputato Sanitario (è lui stesso che racconta), intorno alle otto di sera (“circa le due ore e mezza di notte”) entra nel Caffè di Pacifico Santaroni, di fronte all’Ex Convento di S.Agostino, proprio mentre “un Villico richiedeva il Medico condotto ivi presente per condurlo in campagna a visitare in qualche distanza un tal Giuseppe Mingarelli colpito da improvvisa colica violenta”.
Il Dottor Conti sembra esitare, così su due piedi non è pronto; dice di avere “la toga d’incerata non ancora allestita”. Per di più lo preoccupa che il Villico stesso sostenga “essere avvenuta la malattia del Mingarelli in seguito del ricetto ad un accattone sconosciuto”.
Peggio che mai: un accattone sconosciuto, uno straniero miserabile che chissà…. Roba da incoscienti!
Il Medico si rivolge al Censi, per il ruolo pubblico che questi riveste; i due, un po’ in disparte, cercano di affrontare il problema. Parlottano. Censi prova a mediare la titubanza del Medico, che lui ritiene giusta, “senza però perder di mira i soccorsi dovuti all’infelice”. Ma questo confabulare inconcludente urta i presenti.
E’ proprio lo stesso caffettiere che (scrive sempre il Censi): “temerariamente s’introdusse in discorso dubitando che non si fosse visitato l’infermo, e proferì a mio carico non meno che dell’intera Deputazione Sanitaria innumerevoli invettive, e termini ingiuriosi ad alta voce, dicendo che io era un coglione, ed un prepotente, e i miei colleghi tutti cazzimatti.”.
Prudentemente il Censi si allontana ed esce dalla bottega insieme al Medico, ma vengono seguiti e bloccati dal Santaroni e da altri. Le invettive continuano ad alta voce; si radunano altre persone “che si unirono ad inveire contro di me, e contro il Professore con minaccie di sollevare la popolazione, d’incendiare, di mettere le mani addosso, e di procurare altri massacri”.
Dall’esaltazione dei Sanitari e delle Autorità che vigilavano sulla salute pubblica, alla loro demolizione, alla condanna, ai “massacri” il passo può esser breve, corre sul sottile filo dei nervi tesi, sempre pronti a spezzarsi. Gli umori cambiano. Le libertà individuali, in quel contesto storico, non erano certo in cima ai sentimenti della maggioranza; eppure qualcosa in movimento s’avvertiva, già nel rapporto tra cittadini e potere e le ulteriori restrizioni alla già limitata libertà per via del colera, esasperavano ancor più gli animi, tendeva appunto i nervi.
In questa baraonda davanti al Caffè di Santaroni, pare si distinguano, tra i tanti, Pietro Sillani e Gaetano Zampini, vigorosi e irruenti beccari (macellai); il secondo in particolare, negli anni a venire si farà conoscere per altre prove della sua esuberanza. Il Censi, giovane rampollo di agiata famiglia, più incline alla penna che alla mannaia, non può certo competere; ha comunque gambe leste e riesce a svicolare e ad allontanarsi; il Medico invece è praticamente preso in ostaggio dalla folla, tanto che “gli convenne di portarsi precipitosamente al luogo dell’infermo imprudentemente accompagnato dai tumultuanti”. In pratica lo sequestrano e lo accompagnano forzatamente a visitare seduta stante il Mingarelli.
Censi prosegue il racconto, nella sua lettera di denuncia al Priore Comunale, rallegrandosi che “il caso favorevole volle che la malattia fosse semplice colica violenta senza caratteri del temuto colera”. Chiese però “opportune misure” altrimenti “stante anche la mancanza della Forza di Polizia nascerebbero gravi disordini sulla tralasciata punizione dei colpevoli, e le Autorità, e li Pubblici Funzionarj diverrebbero lo scherno e il ludibrio della plebe più vile del Paese.”.
Poco interessa come andò a finire. Serviva solo per tratteggiare un clima.
Si riprende a vivere
Appena due mesi dopo una Circolare della Delegazione Apostolica di Macerata a firma di Domenico Carafa (che sarebbe in seguito diventato il Cardinal Carafa noto nelle cronache risorgimentali) dichiara che “Essendo libero affatto da non poco lo Stato Pontificio dal Cholera Asiatico” sospende “ovunque il sistema delle Bollette Sanitarie per la circolazione interna”.
Si riprende a circolare, a vivere. Mancano sì molte risposte all’appello. Ma il mondo sembra, più o meno, tale a prima. Chi non vuole, se ne duole, si rallegra chi… ha la rima.